Lode al dono
di Francesco Masala(*) (e Davide Galati)
propongo un lavoro a quattro mani e due teste, quelle di Davide Galati e le mie, l’abbiamo fatto qualche anno fa, ci interrogavamo sul dono, abbiamo deciso di scriverci da noi quello che avremmo voluto leggere, e ve lo diamo in dono, non è perfetto, ma non costa niente.
gli amici devono farsi piacere l’un l’altro;
ognuno lo sa da se stesso (per propria esperienza).
Coloro che si fanno reciprocamente regali
restano amici per il più lungo tempo possibile,
se le cose arrivano a prendere una buona piega
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno.
Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due idee. (G.B.Shaw)
Marcel Mauss e il dono: tra il passato e l’attualità
Marcel Mauss, vissuto tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900, è considerato il padre dell’etnologia francese: rivelò il ruolo fondamentale del dono nelle società ed economie arcaiche con il celebre Essai sur le don(1925).
Nei remoti sistemi economico-giuridici analizzati, il dono guidava istituzioni di scambi organizzati, non tanto tra singoli individui, quanto tra intere collettività (clan, tribù) che si ponevano in un meccanismo di obbligazione reciproca: ciò avveniva all’interno di cerimonie ritualizzate nel quale donare, come ricevere e contraccambiare, erano considerati un obbligo contrattuale e non una scelta. Su questo sistema si reggeva l’intero sistema sociale ed economico. Va sottolineato un particolare: donare e contraccambiare non avvenivano contestualmente, e il dono diveniva così un obbligo nel tempo. Con ciò Mauss dimostrò che il concetto di “credito” nacque nell’economia del dono e non, successivamente, nelle moderne economie basate sulla moneta e sulla vendita.
Mauss definì lo scambio di doni un “fatto sociale totale”, nel quale “tutto, cibo, donne, bambini, talismani, terreno, lavoro, servizi, uffici sacerdotali, e ranghi, è materia di trasmissione e di restituzione. Tutto va e viene, come se ci fosse scambio costante di una sostanza spirituale comprendente cose e uomini (…)”. In questo senso è cruciale comprendere il valore sociale, e non soltanto economico, del dono: ogni individuo si considerava piccola cosa rispetto al tessuto del Tutto.
Tra le cerimonie studiate da Mauss vi è il potlàc, praticato dalle tribù indiane del Nordovest americano, da lui definito come istituzione totale “di tipo agonistico”. In queste cerimonie si superava infatti il concetto dello scambio di doni, arrivando anche alla distruzione delle proprietà familiari per umiliare i rivali partecipanti al potlàc: il fine era quello di manifestare la superiorità di rango e la maggiore ricchezza della propria famiglia.
Evolvendosi nel corso della storia e subendo una trasformazione indotta dall’avvento delle religioni monoteiste, “la vecchia morale del dono è diventata principio di giustizia; gli dei e gli spiriti consentono che le parti di ricchezza, che andavano ad essi e che venivano distrutte in sacrifici inutili, servano ai poveri e ai fanciulli”. E’ l’origine della carità.
Da questa sommaria sintesi si evince come il dono abbia in realtà due possibile connotazioni:
a) dono che richiede qualcosa in cambio obbligatoriamente;
b) dono disinteressato che non chiede nulla.
Ci interessano entrambe le dimensioni: la prima ha un’equivalente attuale, ad esempio, nelle “banche del tempo”, i sistemi di scambio operanti a livello locale nel quale una comunità si obbliga reciprocamente, nel tempo (non è baratto), attraverso uno scambio di beni e servizi tra individui. Generalizzando, in questo tipo di circuito, l’obbligo dello scambio di doni rappresenta proprio ciò che rafforza il legame di solidarietà e la consistenza del tessuto sociale: l’uomo torna a diventare un “essere relazionale” (Aime), allontanandosi dall’individualismo utilitarista che domina il modello economico contemporaneo.
Il dono disinteressato che non chiede nulla in cambio conduce a istanze ancora più radicali. Quando non è rivolto ad un individuo in particolare ma generalizzato, all’interno di una certa società o astraendosi sino a livello mondiale, l’idea del dono è affine ad altri concetti quali il digiuno o la decrescita. Vedremo più avanti come queste categorie possano essere calate operativamente in disegni organici articolati di riorganizzazione economica aventi l’obiettivo di raggiungere una graduale riduzione degli squilibri globali.
E’ su entrambi questi fronti che si muove, secondo percorsi anche piuttosto differenziati, il lavoro del MAUSS, il movimento istituito a Parigi nel 1981 che riprende l’opera di Marcel Mauss e che annovera al suo interno, tra gli altri, Alain Caillé, Jacques Godbout, Serge Latouche e il nostro Alfredo Salsano.
Marcel Mauss: una bussola per il web
[1] Un’introduzione al MAUSS, Educazione & Scuola.
[2] M.A.U.S.S.? – The new maussketeers, Nazione Indiana, 02/10/2008.
[3] Radio Kapital – M.A.U.S.S., Nazione Indiana, 05/10/2008.
[4] La Revue du M.A.U.S.S. (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales).
[5] Testi di Marcel Mauss, dalla biblioteca digitale “Les classiques des sciences sociales”.
[6] Dono e intercultura: a proposito del Saggio di Mauss, B.Giacomini – Trickster.
[7] The breakdown of the neoliberal world economy, The Memory Bank, 24/11/2009.
[8] Marcel Mauss: our guide to the future, The Memory Bank, 20/03/2007.
[9] Denaro e Rito. Il valore della moneta falsa, Rivista Liturgica n.2 mar/apr 1997.
Il dono nel mondo dell’utile
Cosa significa il dono nell’epoca dell’utilitarismo? Ma, cosa è utile?
Dal punto di vista economico, utile è ciò che consente di aumentare le proprie entrate monetarie. Purtroppo il punto di vista economico ha invaso anche altri ambiti della vita, come metro di misura di troppe altre cose. Leggere un libro, ascoltare musica, fare una passeggiata, guardare un film sono, secondo quell’ottica, non utili e rappresentano una forma di egoismo non produttivo. Secondo noi le attività citate prima, e non solo quelle, sono invece un dono fatto a sé stessi.
Naturalmente il concetto di dono riguarda soprattutto quello diretto agli altri. Per esemplificare quanto esposto nella sezione precedente: un esempio di dono che richiede qualcosa in cambio obbligatoriamente (almeno moralmente), può essere un invito al bar, o un invito a un matrimonio, o il dono di un cestino di limoni del giardino; in tutti questi casi gli individui si conoscono e sanno che il credito/debito è reciproco e c’è l’attesa della restituzione. A ben vedere siamo ancora in un’ottica non mercantile, ma l’attesa della restituzione ha instaurato un rapporto sociale concreto, che l’ acquisto di una merce in cambio di denaro non può creare.
Altrettanto interessante è il dono disinteressato che non chiede nulla in cambio, di sicuro non nei rapporti individuali reciproci. Anche qui esemplifichiamo: quando si dona il sangue anonimamente non si sa a chi lo si dona, è entrare da protagonista in quell’ampio contratto sociale per cui chi può dà, chi ha bisogno riceve.
Il dono, sia quando richiede qualcosa in cambio obbligatoriamente, sia quando non chiede nulla, aumenta la sfera del non economico nei rapporti sociali.
Oggi i rapporti di scambio sono rapporti sociali mediati (misurati) dal denaro, dal prezzo, che ha un’aura di oggettività, il dono non è misurabile con quell’unità di misura. Ci torneremo.
Se consideriamo la vendita di materie prime, soprattutto di origine agricola, da parte dei paesi poveri, appare in tutta la sua evidenza che il prezzo è determinato dal compratore, senza nessuna considerazione della persona produttore o del lavoratore. Il commercio equo e solidale è un piccolo tentativo di svincolarsi dal prezzo di mercato, astratto, misura inappellabile del rapporto sociale e della condizione umana del coltivatore-produttore.
Quando il denaro (e il prezzo) sono l’unica misura delle azioni dell’essere umano, visto tout court come homo economicus, il passaggio a un commercio equo e solidale (che vuole avvicinarsi alla giustizia) e tutto quello che sta al di fuori del prezzo, come il dono, è follia. Ciò che esula dal prezzo come misura oggettiva di tutte le cose (e le persone), che è aldilà o al di fuori del prezzo, come il dono, diventa non misurabile e quindi economicamente impossibile.
Ora, presentando una selezione di siti che per noi rappresenta un dono e la cui consultazione è un atto (in)utile, stiamo compiendo un atto di follia, e voi con noi.
Prima ci fa piacere condividere una parte di un’intervista a Pepe Mujica, neoeletto presidente dell’Uruguay, che a noi è piaciuta molto:
“…l’austerità è lotta per la libertà. Chi perde la libertà è chi si fa intrappolare dalla società consumista, perché quando si compra qualcosa non si compra con il denaro, ma con il tempo di vita che si è dovuto sprecare per ottenere quel denaro; si è liberi quando si ha tempo libero per fare quello che a ciascuno piace,… si può giocare a pallone, dormire sotto un albero, ma occorre tempo libero per farlo…..siamo austeri perché abbiamo una mentalità certosina, siamo austeri per avere la maggior quantità possibile di tempo per dedicarci alle cose che ci interessano.“
Alain Caillè citato da Alfredo Salsano in “Il dono nel mondo dell’utile”, Bollati Boringhieri, 2008“La comunità di mercato come tale è la più impersonale delle relazioni di vita pacifiche
nelle quali più persone possono entrare in contatto tra loro…
Dove il mercato è abbandonato alla sua autonormatività,
esso conosce solo una dignità della cosa e non della persona…”
Max Weber citato da Alfredo Salsano (cit.)
Vogliamo tentare di rispondere a questa domanda adottando la prospettiva del MAUSS (Movimento Antiutilitarista per le Scienze Sociali), il movimento nato a Parigi nel 1981 e il cui acronimo rinvia alla figura tutelare di Marcel Mauss, di cui abbiamo scritto nelle scorse settimane.
Va precisato che affronteremo il dono più nella sua accezione dello scambio che in quella della gratuità (si veda il post precedente): il primo caso è valido soprattutto nella sfera del singolo individuo, ma è il dono-scambio che conduce alle implicazioni più interessanti per quanto riguarda sistemi economici, società o Stati.Il MAUSS radica la propria visione dell’economia in due fondamentali contributi: l’idea di Marcel Mauss del dono e dello scambio come “fatti sociali totali” e l’analogo concetto di embeddedness dell’economia nella società espresso da Karl Polanyi (1886-1964), economista e antropologo ungherese che nel Novecento percorse sentieri in qualche modo simili a quelli di M.Mauss; anche per Polanyi l’economia non può essere considerata come avulsa dalla società, ma ne è parte integrante e vi è radicata all’interno.Il dono nel contesto del MAUSS è antiutilitarista non nel senso che necessariamente rifiuti l’economia di mercato; si intende però ribaltare l’approccio di una società incorporata all’interno di un sistema economico, proponendo esattamente il contrario: è il sistema economico che dovrebbe essere “incorporato nelle relazioni sociali” (K.Polanyi citato da A.Salsano in “Il dono nel mondo dell’utile”). Non più l’homo economicus schiacciato su un individualismo tutto orientato alla massimizzazione della propria funzione di utilità, ma un uomo che sappia porsi di nuovo in relazione con gli altri, ponendo i propri interessi economici all’interno di un sistema più ampio e ricco di rapporti umani.Il MAUSS non è per nulla monolitico nel perseguimento di questo obiettivo: al contrario, i contributi dei suoi principali animatori sono molto differenziati tra loro: c’è chi considera l’antiutilitarismo come vero e proprio rifiuto dell’economia di mercato (in un’articolazione che in passato, per Polanyi, fu una visione vicina al marxismo, e oggi consiste soprattutto nell’idea di decrescita espressa da Serge Latouche), ma c’è anche chi considera l’antiutilitarismo come percorso orientato al raggiungimento di un “autentico” utilitarismo. In questo filone l’intento non è quello del sovvertimento dello status economico-sociale ma di una sua graduale riforma (Alain Caillé, Jacques Godbout, Alfredo Salsano in Italia), che sappia conciliare il dono con l’economia di mercato e l’intervento statale. Usando i termini di Polanyi, è la poligamia delle forme di scambio, la ricerca di forme democratiche che sappiano includere in sé redistribuzione (Stato), reciprocità (scambio personalizzato) e scambio di mercato.
Tutto ciò può sembrare astratto ma le ricadute di queste analisi sono in realtà molteplici: ad esempio, nella teoria economica, la riduzione dell’orario di lavoro (G.Aznar), il reddito di cittadinanza (A.Gorz), l’influenza sulle teorie del salario di efficienza (G.Akerlof); nelle prassi economico-sociali, la valorizzazione del terzo settore, le banche del tempo, le reti di scambio. Sullo sfondo il superamento della polarità Stato-mercato. Salsano (cit.) riprende A. Gorz:
“La via di uscita dall’attuale crisi di società deve essere ricercata al tempo stesso in meno mercato, meno Stato e più scambi non retti né dal denaro né dall’amministrazione, ma fondati su reti di aiuto reciproco, di cooperazione volontaria, di solidarietà autorganizzata: il rafforzamento della ‘società civile’, se si vuole”.
E ancora:
“Ci deve essere una politica per promuovere lavoro comunitario o cooperativo non pagato e dargli riconoscimento sociale e politico…”
Riprenderemo più avanti e con maggior dettaglio qualche piccola riflessione economica su queste idee, che, come vedremo, ci possono condurre fino al ridisegno complessivo del mondo.
Ora affrontiamo invece alcune considerazioni utili a distinguere il dono da ciò che sembra tale ma non lo è, in particolare quando ci sono di mezzo gli Stati.
Come abbiamo visto, il dono nei termini di Mauss si compone di tre stadi: dare, ricevere e ricambiare.
A questo proposito l’economista Mary Douglas (ripresa da Alfredo Salsano cit.) così scriveva:
“La nozione stessa di dono gratuito deriva da un malinteso. Non ci sarebbe mai stato un solo dono al mondo se si prendesse alla lettera questa nozione di gratuità… Mauss sostiene al contrario che sarebbe perfettamente contradditorio pensare il dono ignorando che esso implica un dovere di solidarietà… Un dono che non contribuisce affatto a creare solidarietà è una contraddizione in termini.”
E afferma Jacques Derrida:
il Saggio sul Dono di Mauss “parla di tutto tranne che del dono: esso tratta dell’economia, dello scambio, del contratto (do ut des), del rilancio, del sacrificio, del dono e del contro-dono, in breve di tutto ciò che, nella cosa stessa, spinge al dono e ad annullare il dono.
Il dono richiede:
– che il donatario non restituisca
– che non riconosca il dono come dono
– che il dono non appaia come tale né al donatario né al donatore
Dono è “figura dell’impossibile”, anche se pensabile.” (Da qui)
Probabilmente, diciamo noi, il dono vero, senza trucchi, è “donare agli altri quello che vorremmo fosse donato a noi stessi”.
Lo pseudodono
Bisogna saper distinguere tra dono e altro. Si legge a volte che il nostro paese, o altri stati ricchi, fanno dono di qualche milione di euro a qualche paese povero. In realtà il denaro è indirizzato al governo di quel paese, magari per essere speso nell’acquisto di beni e prodotti del nostro; quello che è apparentemente un dono risulta essere solo un sostegno all’esportazione delle imprese italiane, macchinari nei casi migliori, materiale bellico negli altri. Forse il modo migliore per fare un dono sarebbe quello di sostenere organizzazioni di base che migliorino la qualità della vita, saltando i governi. Ma quando questi possono venderci materie prime a buon prezzo, quei contributi ai governi sono forse modi per oliare il meccanismo del commercio iniquo. Una donazione di qualche milione di euro per comprare medicine o cibo, magari scaduto, già successo nel passato (ah, il buon cuore italiano), in zone in cui il nostro esercita sta in armi, o in zone in cui l’Eni estrae petrolio, distruggendo la vita naturale e umana: questo è dono o carità interessata? (a proposito, ecco da dove arriva la nostra benzina).
Proprio in questi giorni si leggono le accuse, lanciate da alcuni paesi sudamericani, che gli Stati Uniti starebbero usando l’occasione del terremoto per un nuovo intervento ad Haiti, nel cortile di casa. Già Ulisse, per prendere Troia, si era servito di un dono, un cavallo con sorpresa. Diceva Laocoonte ai troiani: ”Timeo Danae et dona ferentes”.
Anche l’ipotesi che l’Italia rinunci unilateralmente al proprio credito verso Haiti è un dono? Se si ritiene che Haiti non li possa restituire comunque, facciamo il bel gesto e in fondo è solo marketing.
Dono e giustizia
“…Nella fase attuale dell’evoluzione della società ci serve, oltre che un percorso di decrescita nel senso indicato da Serge Latouche, lo sviluppo della giustizia. Anzi, la decrescita è un versante specifico di questo sviluppo fondamentale. Non c’è altra via d’accesso a un’altra economia. Ogni momento dell’organizzazione economica della società (…) deve articolarsi secondo criteri di giustizia che impediscano all’economia stessa di volgersi contro gli esseri umani e la natura…”
Roberto Mancini da Altreconomia n.112, gennaio 2010.
Un’altra distinzione è quella fra dono e giustizia. Proprio in questi giorni e anni il tema del clima è urgente. Se i paesi ricchi continuano a consumare energia fossile e produrre scarichi tossici, ridurre l’inquinamento è un favore che facciamo agli altri o a noi stessi? Concedere contributi economici e tecnologici ai paesi in via di sviluppo affinché possano crescere in maniera ecocompatibile è un vantaggio anche per noi. Sono esemplari e chiare le parole di una rappresentante della Bolivia a Copenhagen:
«I paesi sviluppati, con il 20% della popolazione mondiale, hanno totalizzato il 75% delle emissioni storiche di gas serra. Non abbiamo provocato noi il problema. E non possiamo fermarlo noi. Abbiamo solo dieci anni di tempo e occorre un impegno mai visto prima nella storia. Rivoglio indietro la mia atmosfera. Come fare, è un problema vostro». Insomma: il prezzo del cambiamento del clima «non può certo essere buttato sulle spalle di paesi poveri che già lottano per dare ai loro cittadini i servizi di base e non possono permettersi di stornare risorse scarse per affrontare una crisi che non hanno causato».
Questo il punto: se noi, i paesi ricchi, investiamo e spendiamo grandi risorse nella direzione indicata sopra, stiamo parlando di dono o giustizia? Secondo noi è semplice giustizia, e nel nostro interesse.
Domanda: ci sono casi in cui uno stato può avere comportamenti che si avvicinano al dono disinteressato? Sempre in Ecuador (di nuovo un paese sudamericano, avremo qualcosa da imparare?) il presidente Correa propose qualche anno fa questa ipotesi: noi abbiamo petrolio che sta nella foresta, le risorse che ne ricaveremmo dall’estrazione e dalla vendita ci permetterebbero di migliorare il livello di vita della popolazione; vi propongo un accordo: se le risorse necessarie potessimo averle da voi stati ricchi e da voi associazioni ambientaliste, noi potremmo salvare un pezzo di foresta amazzonica, utile e necessaria per tutto il pianeta. Aderire a un patto del genere non significa fare carità: facendo l’interesse di qualcuno staremmo facendo anche il nostro. Forse stiamo solo restituendo una parte del debito ecologico e climatico che abbiamo contratto nel tempo.
Siamo così arrivati alla lista di siti per noi davvero (in)utili.
La vera felicità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l’altro come un soggetto: il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché, in realtà, non si ha nessuna voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti (…). Lo stesso vale per la riserva della sostituzione, che praticamente significa: ecco qui il tuo regalo, fanne quello che vuoi; se non ti va, per me è lo stesso; prenditi qualcosa in cambio. Rispetto all’imbarazzo dei soliti regali, questa pura fungibilità è ancora relativamente più umana, in quanto almeno consente all’altro di regalarsi quello che vuole: dove però siamo agli antipodi del dono. (…)”Nella prossima puntata andremo ancora alla ricerca del dono in Internet, questa volta elencando alcuni blog che riteniamo valga la pena di visitare (nessun intento di completezza, solo incontri casuali interessanti nel mare magnum della Rete): nel caso dei blog, il dono sta nel tempo e nell’impegno profuso per mettere a disposizione di altri le proprie conoscenze o le proprie capacità attraverso la propria pagina personale.
queste sono le nostre radici e magari un ritorno alle radici è necessario, prima che lo tsunami finanziario-economico-culturale ci sommerga tutti.
“chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamoci il passato” o una robusta redistribuzione?
uscire dai paradigmi dominanti, che portano al disastro del pianeta, è necessario – franz
…Il potlatch è un esempio di economia del dono, in cui gli ospitanti mostrano la loro ricchezza e la loro importanza attraverso la distribuzione dei loro possessi, spingendo così i partecipanti a contraccambiare quando terranno il loro potlatch. Contrariamente ai sistemi economici mercantilistici, infatti, nel potlatch l’essenziale non è conservare e ammassare beni, bensì dilapidarli. La logica dell’economia di mercato è quindi completamente invertita…
da qui
…It is important to note the differences and uniqueness among the different cultural groups and nations along the coast. Each nation, tribe, and sometimes clan has its own way of practicing the potlatch with diverse presentation and meaning. The potlatch, as an overarching term, is quite general, since some cultures have many words in their language for various specific types of gatherings. Nonetheless, the main purpose has been and still is the redistribution of wealth procured by families…
da qui
…Nella teologia dell’anno giubilare si concentra una molteplicità di temi biblici e spirituali che da sempre hanno alimentato e continuano ad alimentare la vita del popolo ebraico. Tra i più importanti di questi aspetti sono da ricordare i seguenti:
1. L’impossedibilità della terra: l’affermazione dell’impossibile possesso della terra. Facendo shabbat, la terra si sottrae al possesso dell’uomo, si rifiuta ad un rapporto di sottomissione che sia solo funzionale e contesta la pretesa dell’uomo di ridurla ad oggetto di dominio,
2. La signoria di Dio: l’affermazione che signore e creatore della terra è Dio che, per questo, non può essere l’uomo. “La terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e pellegrini” (Levitico, 25 23): nella terra l’uomo è “forestiero” e “inquilini” nel senso che ne è ospite in quanto ospitato da Dio che ne è l’unico e legittimo proprietario.
3. La gratuità: l’affermazione che, se l’uomo vive in una terra che non è la sua ma di Dio, egli vive in forza di una gratuità o grazia che è l’amore disinteressato di Dio: “La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli. Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per tre anni” (Levitico 25, 19-21).
4. La giustizia: L’affermazione che, se la terra è dono di Dio al bisogno umano, essa è di tutti e per tutti e che ogni volontà umana di accaparramento che neghi o arresti questa destinazione universale è peccato contro Dio e contro il prossimo. La giustizia, cuore del messaggio biblico e soprattutto profetico, è riconoscere l’amore gratuito di Dio nel mondo e assecondarlo facendo di esso il principio del proprio agire e del proprio essere. Per questo, secondo i profeti, è “dalla giustizia”, cioè dall’agire giusto, che fiorisce “la pace”, la pienezza dei beni per tutta l’umanità (cfr Isaia 32, 15-20).
5. La fine delle disuguaglianze e delle ingiustizie: l’affermazione che, essendo la terra di Dio, in essa dovranno essere superate tutte le forme di sfruttamento, quelle che riguardano i beni della terra e soprattutto quelle che riguardano l’uomo nei confronti dell’altro uomo.
da qui
…abbiamo un’espressione abbastanza chiara delle proposte del giubileo. Il nucleo del testo consiste nella redistribuzione delle terre e nel ritorno alla propria famiglia – talora nel senso di smettere di lavorare come servi per altri. L’anno giubilare proclama esplicitamente “liberazione per tutti gli abitanti” (Lv 25,10.13). Con ciò si dà a intendere che ricuperare la porzione di terra significava liberazione; la stessa cosa vale per il ritorno alla famiglia…
…Non c’è dubbio che con la proposta del giubileo, così come nelle leggi dell’anno sabbatico e dei giorno di riposo, si cerca di modellare una società le cui relazioni socioeconomiche siano giuste, e tutto ciò legittimato da Dio, descritto come liberatore. La redistribuzione della terra, la remissione dei debiti, la liberazione degli schiavi, il riposo della terra e dei lavoratori non mirano, in una realtà che ne ha bisogno, che a questo…
da qui
Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri cosí ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile… Quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i pali o colmando il fosso, avrebbe gridato ai suoi simili: “Guardatevi dall’ascoltare questo impostore; se dimenticherete che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, sarete perduti!”…
da: Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini, di J.J. Rousseau
http://liberarete.altervista.org/index.html
(*) «Nella prefazione a “Le folgori d’agosto” (edizione Vallecchi 1973) alla domanda sul perché scrive Jorge Ibargüengoitia ha confessato che scrive un libro ogni qual volta desidera leggere un libro di Ibargüengoitia, che è il suo scrittore preferito. Quella lettura fu una folgorazione, da allora ogni volta che voglio leggere qualcosa di veramente bello e interessante che non riesco a leggere da nessuna parte, me la scrivo da me, anche perché non è mica facile per gli scrittori sapere quello che voglio leggere io».Francesco Masala si presenta così. Aggiungo solo che una delle sue frasi preferite è «La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta» di Theodor W. Adorno. (db)

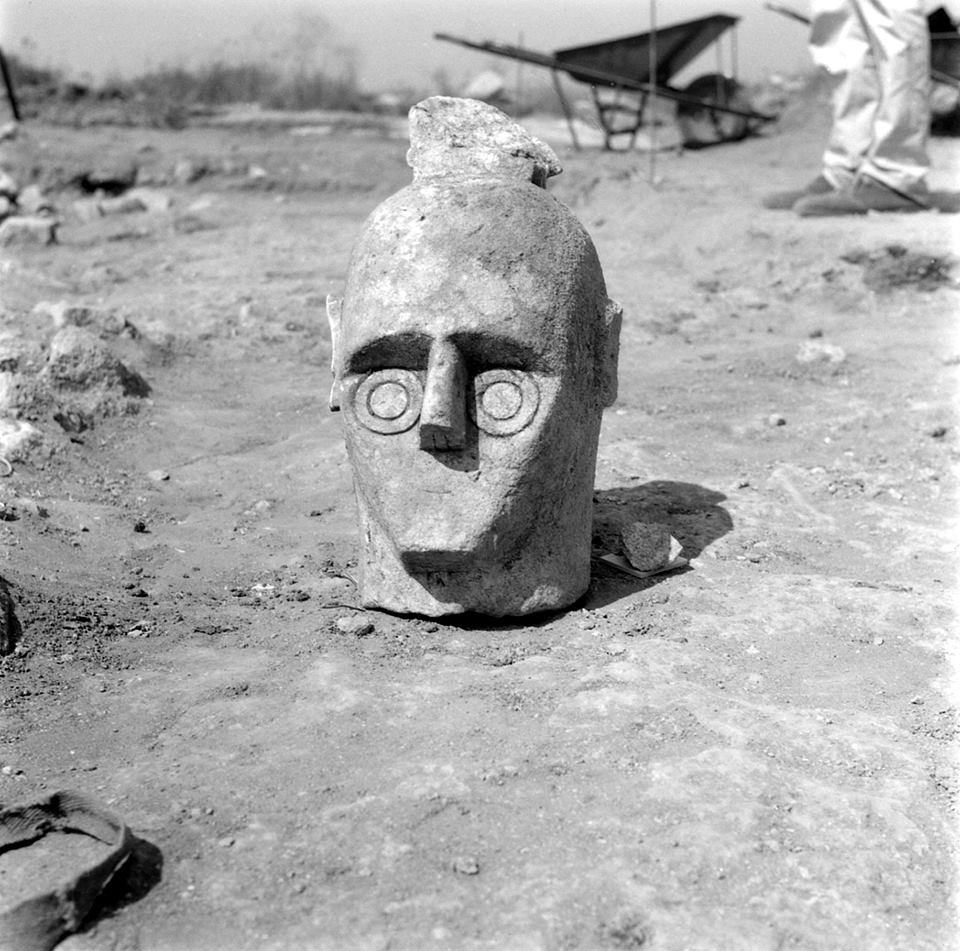
Grazie per il dono di un’ importante riflessione. Ho stampato la nota per leggerla con calma su carta stampata. La condivido anche sulla mia pagina Facebook.
anche la calma è un dono, quando tutti corrono, e molti non sanno perché (tranne Daniele, che lo sa)
Grazie per aver ripreso questo lavoro che tanto ci aveva appassionato: un intenso momento di riflessione a quattro mani e a distanza (tra Cagliari e Padova) per cui occorre ringraziare le possibilità che ci offre il web. Per il resto, buon lavoro per questo blog così attivo! Davide Galati
aspetto ancora che ci conosciamo de visu, cugino Davide:)
Bello! bello! e geniale trasformare Marcel Mauss
in un acronimo così denso di
> significati. grazie del dono caro Daniele
>