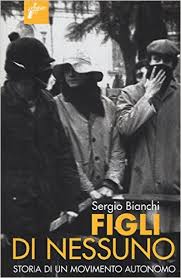Quando il tradatese non parlava leghista
Riflessioni sul libro di Sergio Bianchi «Figli di nessuno – Storia di un movimento autonomo»
di Gian Marco Martignoni
Sulla scia della contestazione studentesca e operaia del biennio 1968-1969, gli anni ‘70 furono caratterizzati da un forte e ampio processo di politicizzazione del mondo giovanile che investì anche quelle zone di provincia allora tradizionalmente dominate dal trinomio casa (rigorosamente di proprietà), chiesa e lavoro. Un lavoro segnato dall’intreccio perverso tra subordinazione più che accettata e sfruttamento brutale.
Il tradatese – ben collegato per via delle Ferrovie Nord sia con Varese che con la metropoli milanese – fu al centro, grazie anche alla scolarizzazione di massa, di una delle esperienze più interessanti di crescita di un movimento spontaneo di ribellione esistenziale e politica, che approdò, con tutta l’irruenza del caso, nel 1975 all’occupazione del Cantinone e quindi alla costituzione di un centro sociale.
Cosa determinò e come quel gesto di rottura, qual’era la composizione sociale di quel movimento, le dinamiche che lo hanno attraversato nel bene e nel male, è ora magistralmente raccontato da Sergio Bianchi – protagonista del romanzo di Nanni Balestrini «Gli invisibili» – nel libro “Figli di nessuno – Storia di un Movimento Autonomo” (pag 252, euro 14,90 Milieu edizioni).
Presentato a Tradate il 5 febbraio, in una serata più che affollata di persone e ricordi, il libro si legge di un fiato, giacchè un filo rosso lega rivolta, rifiuto del lavoro, esodo dal regime di fabbrica, fuga nel lavoro autonomo ed esaltazione della micro-imprenditorialità, spaccatura nell’Autonomia tra componente militante e componente movimentista, repressione e carcere, nuove pratiche di resistenza e di sottrazione alla omologazione dilagante.
Non vi è nessun reducismo nella ricostruzione di Bianchi ma la rivendicazione di un percorso collettivo di alterità con la sinistra storica (anche extraparlamentare) e le organizzazioni sindacali, in quanto accanto alle medie e grandi fabbriche organizzate sindacalmente, nel territorio – tramite la ristrutturazione capitalistica e il conseguente decentramento produttivo – imperversava la “fabbrica diffusa” prevalentemente artigiana e viziata da rapporti familiari o parentali.
Una fabbrica diffusa ove la prospettiva per l’operaio sociale – così lo definiva la rivista «Rosso» – era quella della flessibilità spinta, del lavoro nero o a domicilio, dell’allungamento della giornata lavorativa, dei ritmi da inferno e infortuni denunciati come malattia. Ovvero la negazione più totale della ricchezza insita nella personalità umana, stante l’impossibilità di far valere istanze collettive, che trovavano spazio solo nella socializzazione extralavorativa.
Che poi da territori come quello del Varesotto si sia affermato un movimento di tutt’altra natura, coniugante l’essere imprenditori di se stessi con un localismo rivendicativo di natura reazionaria, è un’altra pagina del discorso, che Bianchi rileva anticipatamente con le armi affilate dell’inchiesta militante.