Quando uno sbaglia
di Mauro Antonio Miglieruolo
a Laura Sanseverino, estemporanea mia maestra di ballo.
Si svegliò consapevole di stare ancora sognando. Ciò che lo circondava, nonostante l’inusitata visione chiara, limpida, pareva stabilizzato su un’alta definizione che solo inforcando gli occhiali, a volte, quasi sempre nei sogni, riusciva a realizzare. A volte. In altre invece la visione era appannata da una cataratta instabile, che veniva e andava; veniva e andava, precaria, simile alla aleatoria ed ordinaria consapevolezza di esserci. Si distraeva volentieri, si distraeva. Il poveretto. In quell’occasione invece l’insieme delle cose pareva finto, costruito per lui, affinché potesse vedere e persino giudicare. Come poteva essere il mondo, bello, colorato, e come invece ordinariamente se lo rappresentava. Del sogno, oltre la finzione, l’interno del risveglio possedeva anche la precarietà propria alla dimensione onirica, la sensazione forte di provvisorietà, gli avvenimenti che a ogni istante rischiavano di collassare; e trascorrendo da uno all’altro, potesse precipitalo nel caos. O lui precipitare nel caos il mondo. Mentre sarebbe stato suo compito, onere fondamentale, mantenere la realtà nella consistenza dovuta. Ma come se tornando al mondo in lui era tornata l’incertezza, la consapevolezza evidente delle capacità di valutare, d’essere perennemente in errore? Provare l’inquietante sensazione di star sbagliando, di non procedere con adeguata accortezza nel giusto, accortezza che a un giusto è richiesta?
Ma lui era nel giusto? Se lo fosse o meno si sarebbe visto. Di questo sì era sicuro, lo sapeva con inaudita certezza. Si sarebbe visto, pesato e soppesato, come sempre passato al setaccio…
Ma, ecco, però, sì, l’insicurezza, il dubbio… la tensione e l’inconsistenza (che guaio l’inconsistenza, porre la paura davanti al proprio essere), neutralizzavano le persone. Insieme alla tensione interna lasciata libera d’espandersi, senza controllo. Facile per uno del suo stampo, uno che di ansia si nutriva, facile sbagliare. Ma quando si attraversava un momento insolito di calma, come in quel caso, acqua profonda priva di turbolenze, avendo la sensazione di esserci ma da lontano, osservatore attento ma non coinvolto, uno non avrebbe dovuto sentire disagio. Non almeno uno ragionevole. Uno ragionevole non vive, stando in sé, l’ordinaria consueta netta sensazione di essere errore.
Strano.
Strana anche quella sua tranquillità. Nella parte più intima di se stesso, al netto di eventuale impazienza o noia, era in quiete. Nella convinzione che tutto fosse come doveva essere. Cioè bene.
La sensazione di star sbagliando proveniva da tutt’altra direzione che la mera presenza del giudizio, quel tale livello di insania con il quale ognuno è frequentemente connesso. Quello di cui in effetti dubitava era di non trovarsi nel luogo e posto giusto. D’essere cioè fuori posto. Insicuro anche su come ci fosse arrivato. Sì, nemmeno cognizione del come ci fosse arrivato aveva. Aprendo gli occhi si era ritrovato lì, in quell’ambiente alieno del quale stentava a prendere atto.
Un ambiente largo, con tre panche di fòrmica e metallo cromato addossate alle tre pareti. La quarta non esisteva. O comunque era lontana. La sala continuava per dieci (venti?) metri e finiva all’inizio di una rampa di scale. A sinistra quella che portava su, a destra quella che conduceva a un ignoto, sgradevole piano di sotto. Ancora più a sinistra, un ulteriore prolungamento della sala finiva in una grande vetrata che illuminava l’interno. Fuori si intuiva il sole, una giornata radiosa, ma nel più interno in cui si trovava era tutto penombra. Ci si vedeva a malapena. O erano i suoi occhi, annebbiati dal ritorno del principio di cataratta a vederci a malapena?
Ho dormito, razionalizzò. Si era addormentato, chissà dove e poi svegliato, in quello specifico dove. Sonnecchiando su una panca di ferro. In una sala d’attesa. Non poteva trattarsi d’altro. Soltanto le sale d’attesa sanno essere tanto spoglie e scomode. Fredde. Repellenti. Date per indurre il bisogno di abbandonarle al più presto, costi quel che costi, piuttosto che soggiornarvi.
Non appena fu sufficientemente in se stesso gli sembrò, oddio non chiaramente, sul circa quasi… gli sembrò di esserci già stato in quel posto. Il giorno precedente o due giorni prima, gli era impossibile stabilirlo. Troppe erano le somiglianze con i ricordi per poter escludere lo avesse già visitato. A principiare dai riti propiziatori che vi venivano celebrati.
Tutto ciò che avveniva era naturalmente nuovo, eppure con qualche solida istanza di ripetizione. La coppia di anziani coniugi che, rammentava, se n’erano andati impazienti per la lunga attesa. Ed ora eccoli di nuovo lì a subire l’iter di procedure tanto inevitabili quanto imperscrutabili. Ma poi altri, facce vecchie e facce nuove, mai viste prima, familiari per l’ansia segreta che leggeva in ognuno di essi. Beh, se costoro pur nella loro ansia, si adattavano ad aspettare, anche lui, con quella sua tranquillità, la cui origine non si spiegava, si sarebbe adattato. Aspettando insieme agli altri.
Acquietato dalla decisione (è il non sapere il da farsi che rende ansiosi, decidere di farlo è un po’ anche averlo già fatto); tentò di meglio rendersi conto della situazione. La decisione non ebbe altro effetto che quello di moltiplicare la sensazione di essere in errore da cui era stato investito al momento della presa d’atto d’esserci e d’essere in quello specifico luogo. Un sospiro d’esasperazione gli fiorì in petto, tanto forte da non riuscire a soffocarlo.
Adesso chissà cosa crederanno, pensò guardando gli altri chiusi con lui nella sala, altri che intanto erano moltiplicati. La gente continuava a arrivare a sedersi e aspettare. Né i nuovi, né i vecchi lo badavano. Neppure nel momento in cui emise il plateale sospiro. Erano tutti sordi, per caso? O forse era lui ad essere cieco? Probabilmente ognuno (che ne sapeva certamente più di lui sulle circostante di tempo e luogo di quel suo stare) riteneva altamente giustificato quel sospiro. Ognuno ne teneva in petto un altrettanto clamoroso. E d’altronde, dovevano valutare, era stato infilato a forza in quelle circostanze, che almeno gli fosse dato spazio d’esprimere insoddisfazione.. ipotesi ragionevole, o no?
Tempo luogo dimensione. Come avesse camminato nel buio ed ora in piena luce. La luce al neon della stanza e quella fuori del giorno che irrompeva utilizzando la grande vetrata panoramica. Dentro però permaneva il buio. L’ignoranza dell’essere come dell’avere. Perché era lì senza neppure sapere perché fosse lì? Che ci stava a fare? Il ripetuto interrogarsi non trovava risposta. Se non una. L’ipotesi che non si trovasse nel luogo dovuto, quello che gli era stato assegnato. Che tale particolarità lo rendeva alieno, praticamente invisibile… una condizione fortunata, quella. Gli stava bene. Nella vita aveva sempre voluto non dare nell’occhio. Aveva sempre operato in modo da sgusciare tra una goccia d’attenzione e l’altra. In modo da cavarsela con il minimo di danni. Il che equivaleva a evitare di collocarsi sotto il microscopio dell’attenzione altrui. In quel frangente tuttavia la tendenza diventare l’Uomo Invisibile era di danno. Nella condizione in cui si trovava l’attenzione della quale aveva sempre ritenuto di poter fare a meno, gli era adesso necessaria. Aveva bisogno di sapere. Quel che da sé non riusciva a sapere. Per poter chiedere e ottenere una qualche spiegazione. Per non starsene eternamente ignaro in quell’interno squallido fatto di sedie di metallo, espressioni apprensive e inservienti annoiati che a tratti apparivano per subito dopo scomparire.
Era comprensibile. Come lui non voleva essere lì, gli inservienti umani sensibili quanto lui, non volevano essere lì. Ottenebrati dalla stanca routine, sempre la stessa, anni e anni di ripetizione priva di costrutto, forse addirittura cento volte più di lui desideravano evaderne.
Egli era di passaggio, domani non ci sarebbe stato più, loro invece obbligati oggi e domani, dopodomani pure, vittime della tortura dell’infinita ripetizione. Annoiati. La noia degli inconsapevoli sotto lo giogo di una attività che raramente era vocazione, per lo più sacra costrizione. Annoiati anche dal loro essere annoiati. Non avrebbero dovuto, dato che avevano uno scopo, in quell’inane ripetersi. Lo scopo periodico di quella volta al mese per il quale tanto si affannavano. La volta che serviva a permettere loro di acquisire quel minimo necessario per la sopravvivenza, per tornare a quell’infernale dunque del loro mestiere, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, compiendo gli stessi atti, eseguendo le medesime indicazioni. Ma era comunque qualcosa, si tenevano impegnati. Un qualcosa che dava loro solidità. Mentre lui, nonostante la provvisorietà, subiva senza ragione l’insieme assurdo della nuda parete bianca della sala d’aspetto, i pazienti afflitti che non sapevano d’altro che delle loro malattie, di questo o quello fortunato sfortunato, del lontano cugino che se l’era cavata per il rotto della cuffia, della zia che ci era rimasta secca. E raccontavano certe storie! Storie che terminavo sull’istante – quasi mai poi riprese – non appena quella sorta di uccelli cucù che erano gli inservienti si mostravano con gli elenchi in mano. Davvero strani esseri questi cagionevoli da cui dipendevano. Apparivano e scomparivano a minuti fissi. Con nessun altro scopo che instillare ansia nelle persone. Quasi le persone non contassero nulla fuori dall’ansia che si intendeva estrarre da loro.
Tuttavia, bisogna ammetterlo, nonostante il compito infame, mostravano sottofondi estivi di umanità, i tizi in camice bianco, verde a volte, che uscivano con l’apparente disponibilità a servirli (e invece non li servivano, innervosivano soltanto). Uscivano ben compresi nel ruolo, utilizzando una buona dose di diligenza, che in alcuni addirittura diventava passione, essì ce la mettevano tutta nello svolgere i loro compiti. Il risultato lo stesso sembrava essere nullo. Un nulla equivalente all’insensatezza di ciò che commettevano. Cioè uscire da una porta chiusa, una porta corazzata – una porta corazzata in ospedale? Sì certo, probabilmente per salvare le apparecchiature interne dai ladri… dai ladri interni ed esterni… uscivano dalla porta chiusa, un largo battente di più di un metro di larghezza, consultavano un elenco e pronunciavano un nome. I soggetti interpellati saltavano su e blaterano “Io! Io!”; e quanto ci tenevano a affermare che si trattava di loro, proprio di loro e non uno dei tanti altri in attesa; saltavano su dunque e sventolando il loro titolo, alias prenotazione, esibita più a beneficio degli astanti che degli addetti, avvicinavano il varco che serviva d’uscita agli infermieri e d’entrata ai pazienti. Ne seguiva un faccia a faccia breve, pezzo teatrale al volo, in cui scambiavano alcune scarne parole, le ultime necessarie per avere conferma all’accesso e tutti insieme, infermieri e pazienti, si inoltravano nei misteriosi recessi dell’interno. Dei cui misteri non si sapeva nulla, solo quel poco che il breve del battente aperto permetta di individuare: un piccolo atrio che concedeva accesso ad altri interni. Dalla sala d’aspetto se ne potevano identificare due, una sulla destra e uno di fronte. Il battente di quella sulla destra era chiuso, quella di fronte aperto. Esibiva la complicazione di alcune apparecchiature la cui funzione, ma fungevano poi? O erano lì abbandonati alla ruggine ed erosione del tempo?… la cui funzione non era decifrabile.
Altre porte invisibili, intuite, sul lato sinistro, là dove procedevano le persone; e sparivano. Definitivamente. Probabilmente da una uscita secondaria. Oppure inoltrati al seguito degli impegni a cui l’impegnativa concedeva di avere accesso.
Un tizio seduto alla sua destra ammise lo scopo suo.
“Devono operarmi”, confessò. “Una ciste perianale.”
Un altro invece aveva un compito meno fastidioso, ma più grave. Un intervento urgente. Vena aorta, gli sembrò dicesse. Poiché però non capiva nulla di anatomia, non ne fu sicuro. Sicuro invece che un terzo, tirando furori una borsa marcata Furstenberg (a fuoco? In piena prateria? Nelle pampas?) iniziò a parlare delle sue speranze di avere una casa. Poiché l’argomento attrasse l’attenzione degli astanti, decise di dedicargli anche la propria.
Il boccone era ghiotto. La casa di un Ente. Spaziosa ma con un affitto abbordabile. Trecento al mese, pareva. Al che tutti si felicitarono. Occasione da non perdere, felice ognuno di affermarlo. Al limite dell’entusiasmo. Poter socializzare su buone notizie diventava sempre più raro. Riceverne una di tale importanza, in quel luogo poi, comportava persino l’obbligo di manifestare contentezza.
Unico a rimanere freddo fu proprio lui, colui che osservava e riferiva. Il cronista. Sempre sull’insicuro. Anche in quel caso, dubitando di aver udito bene. L’avere udito infatti, dopo averlo udito, si trasferiva automaticamente nell’archivio dei ricordi, in quel luogo oscuro, invernale si potrebbe dire, un luogo governato dai pensieri, nel quale, proprio perché dei pensieri, vigeva l’incertezza. Mai i pensieri ne davano. Certezze. Non fornivano nemmeno la certezza elementare, scontata necessaria, si potrebbe e dovrebbe dire, di esistere; o certezza sulla mera possibilità dell’esistere. Si esisteva o si era il pensiero di qualcuno, a sua volta dubbio e incerto, che pensava su quell’esistere? Quel che esisteva in effetti al più era la un fugace pensiero che, per una attimo, afferrava la possibilità dell’esistenza; l’attimo successivo negando, arreso al cospetto della soffice inconcludenza di un pensiero che sgomentava di fronte alla possibilità stessa dell’esistenza. Quale assurdo! Quale demenziale presupponenza! Pensare l’esistente è anche pensare l’inesistente e nel paragone il pensiero si smarrisce, perché non riesce a pensare l’inesistente. Nell’inesistente nulla è, neppure il pensiero dell’inesistente. Il pensiero poi, per dirla tutta, non riesce a pensare che a se stesso, al se stesso pensiero che pensa. Ma d’altronde quale conoscenza può nascere dall’evanescente rapidità di un pensiero? Il pensiero costruisce sulle sabbie mobile affidandosi alle memorie di massa del cervello. L’unica era accettare l’idea di precarietà permanente, quella a cui siamo condannati noi esseri di pensiero, e tirare avanti.
Ritirarsi nella precarietà, alla quale si stava rassegnando, di tutti quei camici bianchi e verdi che entravano e uscivano, passavano, ridevano, interpellavano, si davano arie e si abbassavano a livello degli astanti. Piccoli piccoli esemplari smarriti di un’umanità dolente, bisognosa, che sola in se stessa avrebbe potuto trovare soddisfazione e compimento, ma non sapeva. Peggio, neppure voleva saperlo.
Si aggrappò a una entità tra le più lente, l’unica a concedergli l’occasione di farlo, un tipo sui cinquanta, bassina, sul viso quel minimo di colore di disponibilità che l’incoraggiò a osare. E l’interpellò.
“Ho sbagliato,” ammise. “sono sicuro di avere sbagliato.”
La donna sorrise. O meglio, gli sorrise. A lui solo. Stranamente nessuno infatti provò ad avvicinarsi alla tipa. Sebbene fosse in tanti ormai a esibire impazienza. Forse perché indossava un camice celeste, un celeste pallido, e imponeva soggezione.
“Lei è il secondo oggi, giornata sfortunata.” Parve per davvero addolorata. Proseguì. “Purtroppo dovrà ancora attendere. Abbiamo tutti molto da fare. Davvero una giornata speciale, non sappiamo a chi dare i resti.”
Poi che si fu allontanata, una seconda inserviente apparve. Per dare a tutti l’analogo messaggio di colei che l’aveva preceduta.
“I dottori sono tutti occupati con alcuni casi gravi. Una giornata speciale quella di oggi. Finché l’emergenza non si sarà risolta, non potremo procedere con le visite.”
Preoccupazione, molta preoccupazione sui volti. Quasi che le disgrazie dei poveretti di giornata potessero ricadere su di loro. Ma se neanche quelle dei padri?! Come mai quelle degli estranei?
Dopo un po’ uscì una seconda infermiera. Splendida questa. Ma non per il suo aspetto, veramente degno d’ammirazione, le si fecero tutti intorno. Il sesso può molto, non tutto. Coloro che sedevano sui ripiani di fòrmica non erano nella condizione di sorridere al piacere. Ciò che volevano, al momento, era d’essere confortati. Assistiti. Tolti dalle loro ambasce. Ma poiché si trattenne più del necessario, l’attenzione fece presto a convogliare nella solita direzione. Quella degli uomini sul seno prorompente e le evanescente possibilità di poter riposare su di esso, meditando sul fluire inesorabile della vita… le donne attratte dal riflesso senza specchio di una grazia che sentivano di avere, ma non riuscivano a far emergere.
Provò ad avvicinarsi anche lui. Non appena si mosse, anche la donna abbandonò la postazione, in favore dei recessi misteriosi ai quali tutti aspiravano. Scomparire. Dissolversi. Non avere più cognizione, né di problemi, né di possibilità varie di dolore. Altre la porta di quel purgatorio di anime sembrava vi fosse la remissione dei peccati e la resurrezione della carne. Un fiume di persone la seguì, una decina almeno di speranzosi.
Il dubbio appena accantonato su quello straordinario traffico di corpi tornò a assillarlo. Quel diavolo di battente che procedeva a senso unico! Le figure potevano affacciarsi, non sottrarsi alla profondità del mistero. Che fine facevano? Calcolò che da quando era lì, in alcune ore (o minuti) di attesa almeno una trentina di persone avessero varcato la soglia di quel largo battente. Sicuramente venivano guidati verso un’uscita secondaria. Ameno che quello non fosse, come aveva iniziato a credere, l’astanteria di un ospedale, ma una sorta di stazione di transito, nella quale i pazienti venivano recensiti e poi lasciati liberi di disperdersi, abbandonati a se stessi, nel vasto intreccio di corridoi che indovinava nell’edificio. Un labirinto, un lascito dell’umana inclinazione all’inconcludenza e alla perdizione.
La circostanza che più lo incuriosiva era che durante il periodo in cui la sua pazienza era stata messa alla prova, nonostante i numerosi ingressi nell’oltre del battente corazzato, i posti a sedere occupati non venissero liberati. Erano più coloro che venivano a sacrificarsi che quelli che vedevano soddisfatta la propria ambizione. L’afflusso, con il farsi del giorno anzi tendevano a aumentare. I nuovi venuti per trovare posto erano costretti a scovare sedie in giro. I più intraprendenti le scovavano e tornavano trionfanti, addossandole al muro. Sorridendo, un sospiro di sollievo e sedevano. Insistenti e fortunati continuarono finché ci furono più muri da saturare sui quali accostare sedie. Non rimase allora altra possibilità che di sostare in piedi. Sbuffando.
Il peggio fu quando neppure a starsene in piedi ci fu possibilità. Lo sbuffare allora diventò protesta, l’alzarsi di voci irate, che non comprendevano il perché di quei trattamenti. Perché la gente persino sulle lettighe, la gente costretta a pazientare nei corridoi, gli inservienti che invitavano amici e parenti ad allontanarsi. Non si poteva lavorare in quelle condizioni. Ma sempre nuove speranze giungevano ad alimentare quella sorta di processione verso il nulla che officiavano. Una processione che non sapevano come contenere. Della quale neppure intendevano sapere. Gli era necessaria non sapere. Necessario restare in quei loro elenchi, nei numeri e l’ordine delle prenotazioni. Non avrebbero potuto continuare, altrimenti. Continuare a accompagnare dentro persone, alle quali non restituivano nulla. Appena qualche inevitabile briciola di umanità. O ai quali restituivano fantasmi proprie stesse paure. Un giorno anche loro, anche mogli,mariti, figli, genitori, fratelli avrebbero potuto trovarsi nelle medesime condizioni. E allora? Il dolore del mondo è sterminato, l’umanità lo subisce passivamente, apparentemente rassegnata, senza sapere come liberarsene, forse neppure volendo liberarsene. Molto di quel dolore si leggeva nei volti che continuavano a arrivare. Di quel dolore nulla volevano sapere, se non l’ingannevole astrusa brevità di una diagnosi. Che poi erano solo parole, convenzioni. Non foste stato per quel nulla, barriera eretta contro la paura e il dolore, nessuno di quegli inservienti avrebbe potuto durare più di un giorno in quel loro mestiere. La morte è nulla di fronte alla consapevolezza immediata e improcrastinabile di dover morire. Di dover assistere alla morte.
A volte era un vero e proprio corteo quello che accedeva per riempire la sala d’aspetto. Il corteo di amici e parenti. Solo alcuni arrivavano soli. Il passo incerto esitante, si guardavano intorno, chiedevano muti, muto scrollare (impercettibile) di spalle.
Erano costoro, i single, ad apparire, forse in ragione della solitudine, i più afflitti e interiormente sconsolati. A meno che non si trattasse dell’effetto secondo della malattia di cui soffrivano. Arrivavano con in mano un foglietto rosa e, dopo essere stati convocati, se ne andavano, questi sì li vedeva allontanarsi, con un foglio bianco in mano. Già, dal rosa si passava al bianco… voleva dir qualcosa? Che l’avevano sfangata? O la condanna irrevocabile… neppure la consolazione della ana speranza che speravano di trovare varcando la soglia della porta corazzata.
Capitava però che all’appello a volte rispondesse solo il silenzio. L’eco di quel silenzio rimbalzava sui muri e ritornava agli addetti sotto forma di delusione. Il parlottio sommesso che animava il locale si spegneva. Speranza ed eccitazione. Il nome veniva ripetuto alcune volte – Mariani? C’è Mariani? E a voce più alta: MARIANI? È PRESENTE MARIANI? Per passare poi al prossimo. Al prossimo Mariani qualsiasi. O Felicetti che fosse. Il nome comunque veniva reiterato all’appello successivo, più e più volte; finché i tizi, le tizie interpellati (interpellate) saltavano fuori misteriosamente proprio mentre la porta stava già per chiudersi. Giustificandosi. Erano andati al bagno. Accompagnato qualcuno a prendere un caffè. Non ci sentivano bene, oltre a non sentirsi bene. Avevano trovato posto a sedere in un altro reparto, stanchi stanchi stanchi, scuse tanto, sa… Uscivano questi ultimi da recessi invisibili e confermavano la loro presenza facendo voci. Gridando: Io, sono io, Marcucci sono io! Ma poteva trattarsi di un qualsiasi Rossi, o Frattini o Compagnone, uno/una fra le tante/tanti. L’inserviente riapriva il largo battente, riprendeva il ritardatario, lo lasciava passare e si dissolveva – quella l’impressione ricevuta, che si dissolvesse – insieme al paziente nelle stanze misteriose custodite da quei severi dieci centimetri di acciaio e inesorabilità.
Le ore passavano, alla fine il turno tanto atteso, per questo o quel Bellini, Cutrufo, De Santis arrivava. Qualcuno finiva effettivamente per cavarsela. Arrivava il suo turno, l’attesa non era stata inutile. Ma per altri era l’inferno, rimandati al giorno seguente. E magari a quello dopo ancora.
L’impazienza naturalmente aumentava. Anche nel cronista che pur sapeva di non doverselo permettere. Nessuna dose di impazienza. Nonostante più di tutti fosse inconsapevole del perché di quel noioso attendere. Se gli fosse necessario o meno. Subirlo o meno. Se fosse in obbligo e nemmeno se fosse il posto giusto dove scontare l’attesa.
Le prime ore di appelli e controappelli trascorsero senza problemi, la pazienza essendo comunque tanta. Nel corso del primo pomeriggio dalle persone iniziò a trapelare una certa irritazione. Sul ripiano freddo rigido di formica si stava scomodi e la scomodità induceva a esternarla quell’insofferenza. Che traspariva nelle inflessioni con cui venivano condotti discorsi, nei mugugni, nelle precipizio di richieste di chiarimenti che investiva gli addetti a ogni apparizione. Non appena la magia delle infermiere e degli infermieri li materializzava nel riquadro della porta d’accesso e davano inizio alla ossessiva ripetizione dei Mazzetti, chi è Mazzetti? Chi è Antonacci? Chi Ferrini? Proteste e irosità varie riempiano l’ambiente. Insieme si capisce all’entusiasmo di coloro che alla meta erano finalmente arrivati. Da loro solo cori d’allegria a approvazione. Un pigolare di Io, io, io, ioioioio… che pareva fosse stata introdotta una intera covata di pulcini. Per gli altri invece era tutto un coro di vari quando tocca a me? E a Me? E a Me? Nonché di inviti a procedere con i controlli controlli, la prego se ci sto sull’elenco… Il suo nome prego? Come si chiama lei? Corsini… Corsini, Corsini (scorrendo l’elenco)… eheee, Corsini, ce ne sono un paio di dozzine prima di lei!
Brutta notizia. Significa dover aspettare ancora molto.
Solo lui non chiedeva, né sbuffava. Lui, l’infastidito supremo. Che fingeva di possedere la riserva di maggiore pazienza esistente al mondo. La verità è che non sapeva dire nulla di sé, come stava, quel che desiderava, se stava dove doveva stare, o invece era nella pienezza dell’errore. Non chiedeva dunque, ignorava cosa chiedere. Aveva troppe domande per poterne scegliere una da rivolgere al personale di passaggio. Per di più afflitto dalla sensazione che fosse difficile contattare quel personale, indifferente a lui e ai suoi bisogni.
Quel che non osava con gli operatori osò con uno suo pari. Chiedere.
“Ci terranno ancora a lungo? Qui ad aspettare?”
Il tizio rispose confessando di lavorare nella scuola, non si intendeva di infermiere, medici, pazienti, ospedali, sale d’attesa. Tempi d’attesa. Gli ospedali, a suo dire, erano entità arcane, imperscutabili, dove l’imprevedibile e gli imprevisti erano all’ordine del giorno. Meglio non occuparsene. Si occupavano già abbastanza gli ospedali di loro tutti. Se ne occupavano nel peggior modo possibile e nella maniera più umiliante possibile. Meglio tenersi alla larga dagli ospedali, accettare di averci qualcosa a che fare solo quando diventava inevitabile. Gli ospedali erano mostruose entità che servivano esclusivamente ai sani, per mantenere in loro l’illusione di poter essere soccorsi quando il destino batteva alla porta. Ma così di volata, una visita, una radiografia, anche due, poi la cura e niente altro. Ricoverarsi, Dio ne guardi! Meglio morire subito, per un accidenti, da un secondo all’altro, senza neppure aver avuto tempo di salutare. Ah, sì, quello era il modo migliore d’andarsene, senza troppi problemi e troppi strascichi!
Subito dopo aver manifestato con tanta consapevolezza del niente che sapeva degli ospedali, passò ad argomentare che se ne intendeva poco anche di scuola. Dove comunque insegnava. Una cosa però era insegnare, ben altra valutare l’istituzione. Della quale si chiedeva lo scopo. Insegnare significava dare qualcosa a chi era disposto a riceverla. Chi è oggi ad aver voglia di apprendere? Nella scuola odierna tutto è relativo e tutto prescritto, determinato. Aleatorietà e certezze vanno a braccetto. Ma poi neanche quello. Quello è ciò che avviene in teoria. In pratica si procede a naso, come viene viene. Le uniche certezze sono il gran compilare di elenchi e di elenchi di elenchi di cose da fare. Come dappertutto, nella pubblica amministrazione. Anche nella privata amministrazione, per altro. Attraversavamo tempi bui, non c’erano dubbi. Tempi in cui ciò che conta è il contenente, non il contenuto. Era questo il motivo per il quale mezzo e messaggio venivano considerati uguali. Per l’indifferenza e il pressappochismo che regnavano sovrani. Con ciò dicendo sollevò il borsone nel quale aveva stipato la biancheria necessaria a affrontare le contingenze ed emergenze del ricovero e mostrò lo stemma che la valorizzava. E volgarizzava. Una borsa marcata Furstenberg. Raffinato, l’amico. Una borsa così era difficile da trovare in circolazione. Non al loro livello almeno. A livello di chi è costretto, felicemente costretto, in due camere cucina termoascensore e per di più probabile casa di un Ente (non precisò quale). Una borsa che forse non era neppure la sua, magari avuta in prestito, non si poteva mai sapere, non esisteva nulla di certo a questo mondo. Neppure la certezza di esistere o di un pensiero che pensava l’esistere. Il pensiero che ritornava. Sempre tornano i pensieri. D’altronde, quale certezza poteva nascere dall’evanescenza rapida di un pensiero? Che balena un istante poi era già nell’altrove?
Stava già accusandosi di sclerosi, parendogli aver già affrontato a sufficienza l’argomento, quando, fortunata combinazione, una nuove inserviente varcò il battente che raccoglieva gli sguardi pieni di aspettativa delle persone in attesa.
Anche lei avviluppata in un camice celestino. A differenza della prima, di un bel celeste acceso. Differenza ancora più interessante, il viso asciutto, il fisico armonioso del quale il camice aderente svelava ogni rientranza e ogni prominenza.
“Io, io, io…” balbettò il paziente giunto ormai all’estremo. “Io qui che ci sto a fare?”
“E a me lo chiede?” piccata l’infermiera. “Se non lo sa lei!”
Guardando poi l’espressione desolata del paziente, rise divertita. Divertita forse dallo sguardo che, inesorabilmente magnetizzato, era sceso ad esplorarle il petto. C’era tanto da guardare, perché era stata incauta (o fin troppo accorta) e aveva omesso di allacciare due bottoni di troppo. Quattro in tutto. Un altro paio e la camicetta sarebbe stata libera di svolazzare al vento. Non vide niente in effetti, solo la solidità del reggiseno, che conteneva, copriva, alludeva… un seno pieno che non esitò a definire “principesco”. Ma definendolo provò anche una grande delusione. Avrebbe dovuto interessarlo, se non anche turbarlo. Invece nulla. Lo stesso che se avesse visto il dorso della mano o il lobo delle orecchie. Persino meno. Una volta, ricordava, erano bastati un orecchino a rimescolarlo. Invece lì niente. Fu quasi per chiederlo. Come mai non mi fa alcun effetto? Decise ch’era meglio non formulare quella domanda. La donna probabilmente sapeva meno di lui del perché di quell’indifferenza. Avrebbe potuto persino considerarla offensiva. Quasi che le dicesse, come donna vali meno di niente. Non era quello che pensava. Per una volta andava di là dall’abitudine, la classificazione, il ruolo obbligato, il dover strutturare natura essenza dell’altro. Per una volta un contatto serio. Uno scambio di favori.
“Val bene,” disse allora, “val bene scambiare un grazie con una informazione? E per questa prima che le chiedo, se posso o meno, il mio grazie, subito…”
La donna si portò tre dita alle labbra per trattenersi dal ridere. Buffo quell’ometto. Riuscì solo a procrastinare l’erompere del riso. Comprimere quel qualcosa che dentro legittimamente premeva. Ristette due, tre secondi al massimo, poi se ne uscì in una franca risata. Un “Ah! ah! ah!” che avrebbe dovuto attrarre l’attenzione generale; e invece rimase affare privato, tresca di loro due. Sempre ridendo riprese a camminare, ridendo e voltandosi a guardarlo, ridendo e commentando.
“Ma guarda tu questo! Chiede l’autorizzazione a guardarmi le tette, così, a prima vista…”
È una calunnia! Stava per sbottare. Qualcosa lo trattenne. Il ricordo di com’era, com’ero stato, come forse sarebbe tornato a essere, uscito dall’ospedale. Il ricordo della congenita insincerità di maschio. Chi, io? Ma quando mai…
Fortuna che nessuno sembrava averci fatto farci caso. Altrimenti sarebbe stato davvero costretto a parlare e negare, risolvendosi a essere quel che non era. O disdegnava essere. Un bugiardo.
Sempre parlando a voce alta l’infermiera giunse al principiare della scalinata sulla sinistra, quella che conduceva verso l’alto. Si voltò e imprevedibilmente chiese: l’aspetto? Doveva spettarmi. La domanda finì di confondermi. D’atterrarmi. Ancora enigmi? Di nuovo impotenze, inconcludenze, misteri? Non c’era soluzione. Ero condannato all’errore, all’ignoranza e all’errore, ad attendere e attendere, ancora, eternamente. Ero quasi per scoppiare a piangere quando l’occhio mi cadde sul grande deodaro che campeggiava in una delle piccole sezioni di giardino del quale era costellato l’ospedale. I rami del deodaro sciabolavano in basso, giungendo quasi a toccare terra. Lo stesso che i seni della donna, in quella loro forma universalmente riconosciuta come la migliore, la più appetibile. Seni che scendevano per poi risalire, assottigliandosi curvi fino a completare il percorso nell’altera sua arrogante definizione, forma di seno rara, che quando è pure grande, mai sembra eccessivo. Lo stesso che il deodaro, la cui imponenza appariva naturale, la minima per poter fare sfoggio d’augusta imponenza.
Perché non chiedere a lui? si interrogò. Quell’albero era vissuto a lungo, aveva già visto molte cose, avrebbe saputo certamente rispondere. Si avviò verso la vetrata, pronto ad affacciarsi a una apertura e chiedere delucidazioni. Si fermò un istante prima di formulare la domanda. Aveva ricordato di non conoscere il linguaggio degli alberi. Lo conosceva ancor meno di quanto conoscesse quello dei propri simili. Un oscuro parlare che quasi mai portava a una qualche conclusione. Quale immane fatica conversare, cercando di dare senso e finalità a ciò che veniva detto!
La domanda che aveva fermato alle soglie della labbra partì ugualmente, proiettata dal pensiero. Io che ci sto a fare? L’albero la percepì e tradusse come poteva. Come voleva poi rispose.
“Che strana domanda…” balenò un pensiero all’interno dei pensieri. Come fosse suo, e forse lo era. Nello stesso istante il commento gli arrivò addosso da dietro le spalle, condotto da uno strano tipo paludato nella solita casacchina verde e il pantalone bianco.
“Che strana domanda…” udì.
Un portantino o un dottore. Un dottore, decise.
“Strana? Perché strana? Non sbaglia mai lei? Non le capita mai di perdere i pazienti?”
“Sbagliare, no, non sbaglio mai. Ho un superiore diretto molto bravo che mi assiste. Non mi concede di sbagliare. E poi non mi riferivo mica a ciò che lei chiama il suo errore. Fossero tutti della stessa misura gli errori in cui incorrono le creature… no io dicevo di quella sua strana domanda sul reggiseno…
Anche lui con la storia del reggiseno? C’era proprio di che arrabbiarsi. E infatti per un poco andò su tutte le furie.
“Queste vostre infermiere, sbraitò. Che se ne vanno in giro seminude e pure bardate di corazze medioevali! Le pare cosa, questa? Le pare cosa?”
“Ma pure lei… chiederle di togliersi il reggiseno…”
“Io, io…” ricominciò. Fermandosi subito dopo. Quell’io era proprio improponibile. Assolutamente fuori posto. Tanto più che proprio nel momento di quell’iterazione, doppio io galeotto, una mingherlina autorevole uscì dalla solita porta. Si accorse di lui e accorse per richiamarlo al dovere.
“Ma dove si era cacciato?”
Non conosceva la mingherlina. Mai vista prima. Eppur la donna conosceva lui.
“Ma cosa le salta in testa!” continuo la donna. “Nella sua condizione, distrarsi in questo modo…”
“Lei mi conosce?” la interpellò il paziente.
“Certo che sì. Mi è stata affidata. Sono ore che la sto cercando.”
“Non mi sono mai mosso da qui…”
“Per fortuna! Avrei finito col perderla altrimenti. Adesso però mi segua, devo portarla a destinazione.”
“A casa mia, vero?”
“A casa sua, certo.”
Si avviò. Con una autorevolezza, determinata, con un piglio tale che non poté evitare di seguirla. Seguire la sua coda di cavallo, i capelli biondi, il fisico minuto svelto che pareva scivolare sul pavimento, piuttosto che percorrerlo. Non sentiva rumore di passi. E neppure fruscio di calze strofinate, risultato inevitabile in alcune un po’ tondette e che pure accentuavano sfacciate. Sì, ce n’era anche di quelle. Lui però non trovava fosse da sfacciate. Bello da udire, invece. Sapeva di vita. Di vitalità. Di salute. Di lontananza dalle afflizioni della moda.
Le andò dietro perché palesemente lei sapeva, non era in errore, aveva una sua meta. Seguendola era probabile riuscisse a scoprire anche la sua. Rendersi conto dell’errore, che probabilmente era proprio quello: non avere una meta. Seguì i suoi fianchi stretti, sottili, che nemmeno una adolescente. L’abbondanza però era in quel suo modo deciso di procedere, quello era importante. Un certo modo protettivo e definitivo di essere che valeva mille inviti sessuali e almeno cento sorrisi.
“Senta, senta…” tentò di interpellarla mentre andavano. La donna continuò imperterrita, ignorandolo. Sicura che sarebbe stata seguita. Si fermò soltanto un paio di volte. La prima davanti a una porta chiusa dove dovette attendere l’arrivo di un addetto per poter passare. E una seconda che aprì in proprio, armeggiando su una tastiera numerica. Dopo molti passi, porte aperte e porte chiuse, si fermò davanti a una vetrata, aldilà della quale molte figure paludate in camici lunghi quasi fino a terra erano chine su un paziente che non ne voleva più sapere di loro. Altro che paziente!
Non recepiva, il poveretto. Alle parole, alle cure, alle preoccupazioni. Sordo e muto. Ogni tentativo di dialogo impossibile. Il maggiore di essi si tolse la maschera. S’arrese. Le sua labbra si mossero. Lo vedete anche voi che non recepisce, decifrò.
Il paziente non recepiva. La mingherlina invece sì.
“Che peccato!” esclamando. “ È un vero peccato!”
Si voltò verso il paziente che si era portato dietro, che guardò con severità.
“Si rende conto di quello che ha fatto?” Chiese.
Ma fatto cosa? Lui non aveva fatto nulla. Aveva dormito e poi si era svegliato. Null’altro.
“Sono innocente,” balbettò. E però nel tono di chi si scusava, convinto di non esserlo per nulla. Innocente. Dormire non è una buona cosa, quando occorre stare svegli, capire in cosa si sta sbagliando. “Non se la prenda con me. Io più di capire che ero finito nel posto sbagliato non potevo intendere.”
La donna lo fissò con pietà.
“Oh, lei non sa, non vuole sapere… le cose che si possono capire quando si vuole. Per altro nessuno l’accusa. Ci si rammarica, ecco. Lei non si rammarica? Mai?”
“Ma io voglio capire! Sì che voglio!”
“Forse… forse è vero. Cominci a capire, allora. Cominci. Invece di chiedere scusa badi a rendersi conto. Ma lei no, non vuole. Come tutti d’altronde. Ah! come siamo fatti male!”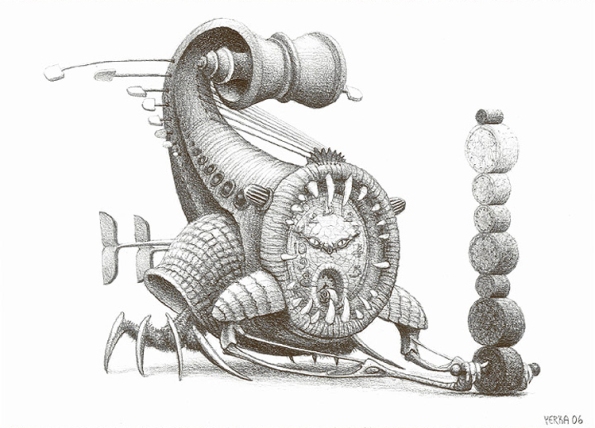
Frastornato da tutti quei discorsi senza capo né coda, partivano tutti da un assunto sbagliato, che si scusava, ma lui non intendeva scusarsi. Chiedeva indulgenza… senza per altro darsela (occorreva ammetterlo). Era quello il motivo per cui fraintendevano. Trovava sempre fraintendimenti nei colloqui, sempre. Quasi ci fosse una barriera semantica a separare le intelligenze, simile a quella che separava i corpi. Stava per pronunciare qualche stupidaggine in proposito, un qualcosa che sarebbe stato sicuramente recepito come stupidaggine, quando lei, pietosa, aggiunse:
“Non la prende a male. Forse ha sbagliato, forse no. Forse semplicemente tutto era stato disposto affinché prendesse la forma che ha preso.” Sorrise e subito aggiunse: “Anche perché ormai è fatta. Non si può più cambiare.”
Non rimaneva allora che preoccuparsi del seguito. L’antefatto era andato, restava da svolgere il tema. Sempre che non si trattasse di arrivare a una conclusione.
“Dove vado adesso?”
“Non è a me che deve chiederlo…”
“E a chi, allora?”
“Al Direttore… al Direttore di tutti i primari. Mi intende? Il Primo Primario… Lo troverà all’ultimo piano. Non si muove mai da lì, in modo da poter essere reperito in qualsiasi momento.”
Guardò il dito della donna puntato verso l’alto, in direzione dell’Ultimo Piano.
“Ci vada. Vedrà che da Lui riceverà ogni possibile spiegazione. Lui è l’unico che si azzardi a dare consigli. Sempre che glieli si sappia chiedere…”
Ultimo piano? pensò l’uomo. Non esisteva, a sua conoscenza, un ultimo piano in quell’ospedale. In nessun edificio esistono ultimi piani. Ci sono sempre piani ulteriori dopo il determinato numero con il quale finiscono. E dopo quell’ulteriore un ulteriore numero ancora. Ma si trattava sempre di numeri. Un ultimo piano, che voleva dire? Ultimo Piano è un concetto non a portata dell’umano. Agli uomini è possibile recitare una lunga serie di numeri, aggiungere e aggiungere, finché la materia sopporta si possono sempre continuare a effettuare babeliche scalate del cielo. Ma parlare di ultimi piani significa accedere a una dimensione cosmica, sovrumana, non essendo l’universo altro che un succedersi interminabile di ultimi piani. Senza fine e senza principio. Ultimi piani pullulanti di infiniti Direttori che dirigevano altrettanti infinti Primari, Primari speciali, che hanno effettiva attenzione alla cura delle miserie umane.
La donna era sparita. Scomparsi anche i contriti donne uomini all’interno della vetrata. Nelle vicinanze, di là dalla vetrata, il corpo di cui vedeva il rilievo sotto il lenzuolo che lo copriva. Per la prima volta da quando aveva aperto gli occhi si rese conto di essere solo. Che probabilmente avrebbe continuato a esserlo, per chissà quanto. Cercò l’ascensore per salire a quel faticoso alto livello dove avrebbe ricevuto i chiarimenti che desiderava avere. Non trovò ascensori. Alla prima svolta del corridoio una enorme porta a vetri e una rampa di scale, che gli sembrò compisse una curva asintotica per approdare a un alto del quale era probabile non esistesse la fine. Il primo e l’ultimo dei sentieri luminosi. Possibile prima e ultima illusione. Aperture alari e grandi aspirazioni. Ospedali volanti e sterminate congerie di errori, di errori da sorvolare e sorpassare. Il tempo e lo spazio la dimensione le illusioni le speranze, chimeriche svolte del pensiero. E poi neppure quello, lui solo, giunto finalmente a se stesso, alla consapevolezza ultima e prima. Lui e l’impotenza alla quale si era ridotto e che finalmente poteva lasciarsi alle spalle.
Aprì la porta non trovò il precipizio del vuoto verso il basso che aveva temuto di dover scontare. Trovò la effettiva interminata distesa di gradini dei quali aveva scorto il riflesso, aleatoria entità che si perdeva verso un alto del quale poteva intuire la fine, non conoscerla. Non finché non l’avesse percorsa.
Solo allora capì di essersi effettivamente sbagliato. E che ora non poteva più.




