Settima suggestione su Yerka: Il Giorno in cui le stelle caddero sulla Terra
“Si sta muovendo l’Universo,” sussurrò il mio amico Franco, poeta, musicista, chimico e venditore di fumo. E poi, con inconseguente enfasi. “Guarda, guarda quante stelle!”
Sissignore, tante. Ma perché sosteneva si stessero muovendo?
La notte era bella. Bella e incipiente, più immaginata che reale. Il sole già da tempo sotto l’orizzonte, non più rosseggiando il cielo; e invece ombre, ombre che intensificavano con rapidità, contrastate dalle luci delle strade e dei negozi. Il cielo punteggiato di stelle. Una moltitudine mai vista. Neppure nelle terse notti di un tempo, in cui pareva di poterle identificare una ad una, tanto distintamente erano esibite. Notti vere, quelle dei decenni intorno alla metà del secolo scorso. Notti dense, e silenziose, belle; notti delle quali non ho più nostalgia, convinto d’essere stato tradito. Dov’erano finite quelle notti, calde e quiete, il mormorio delle donne torno torno al lampione sospeso al muro d’una casa, a favellare di mostri, eroi, lupi mannari e rari uomini buoni? A chiacchierare spettegolare sospirare, nell’attesa del ritorno dei mariti ubriachi?
“Sono tante, sì,” ammisi.
Il pensiero però era lontano. Viaggiava sulle ali della nostalgia. Deconcentrato, pur ponendo attebnzione, dalla loro effettiva presenza. Incurante del numero. Ero stato colto dalla vertigine per il buon tempo antico, ben sapendo che dietro soggiornava il rimpianto di un’età nella quale l’intensità è il primo comandamento, il resto essendo il diverso squallore che caratterizza ogni epoca. Tornare al buon tempo antico, un modo come un altro per sottrarsi al presente.
“Vedi che sono tante e che si muovono non lo vedi?” chiese.
Al solito, con il solito tono caustico, un tantino sprezzante. Tornai alla realtà. Alle immediate esigenze di Franco. Che non fossero più fisse lo vedevo. Quale fossero i movimenti effettivi, la direzione, le conseguenze non mi riuscivo a individuare. Insistendo con l’attenzione tuttavia mi resi conto. Con enorme spavento. Un tuffo al cuore.
“Occristo! È vero, girano…”
Ma non era solo che girassero, o vibrassero, o che l’insieme tendesse a spostarsi, spostando la disposizione intera del firmamento. Era che pareva si avvicinassero.
“Sì, si muovono,” confermò lui, indulgente come sempre verso se stesso. Una conferma pacata condita dalla soddisfazione che ancora una volta poteva constatare di aver avuto ragione. Uomo di mondo, di colui che sapeva le cose. Sapeva anzitutto non c’era nulla di cui stupirsi. Si stupiscono gli ignoranti, non Franco, uno di color che sanno. Non tutto, l’essenziale. Ciò che dell’esistente poteva costituire un pericolo, o promettere un pericolo e nessuno apparentemente era in grado di neutralizzarlo.
Al contrario di lui, nell’istante stesso in cui presi atto, senza provare imbarazzo mi concessi una adeguata porzione di stupore. Al quale fece seguito una adeguata porzione di inquietudine. Pronta a trasformarsi in gambe in spalla. Il cielo, mi dissi, annuncia follia. Le stelle più che muoversi sembravano scendere. Di grado in grado diversificando e persino moltiplicando. Erano partite come stelle, ma palesemente non erano più stelle. Ugualmente il cielo pareva svuotarsi di loro. Di una essenza che le voleva stelle fisse quando restavano aggrappate al firmamento, qualche altra cosa mentre ascendevano verso la Terra. Erano tante, milioni di miloni. Miliardi di miliardi. Davvero, come sosteneva Franco, l’universo si era mosso per visitare questo nostro piccolo, insignificante mondo.
Avanzai il mio dubbio. Stranamente consentì. Per una volta accettò una mia opinione.
“Non sono stelle,” dissi. “Una volta forse lo erano, molto molto tempo fa. O forse lo sono state per un porzione ragguardevole di tempo e finalmente sono maturare, diventando tutt’altro. Lo scopo per il quale erano state create. Astronavi, sembravano queste tante piccole stelle nuove. Tante piccole astronavi, con i loro carichi segreti da disseminare ovunque.”
Non si trattava comunque di un invasione, precisai; o d’un rigurgito di turismo di massa innamorato del nostra pianeta. “A naso,” conclusi. “Non può che trattarsi di una testimonianza delle varie possibilità e ferme e meraviglie che l’Universo ha in serbo per noi.”
Ero un ottimista, in fondo, anche se ottenebrato dall’indulgere ingiustificato al pessimismo. Dio ci voleva bene. Tutto ciò che proveniva dal cielo non poteva che essere bene. Il male solo dall’uomo, perché nel mondo il male è nell’uomo.
Le luci infittirono. Meravigliose luminarie estive, surclassando ogni festa paesana, ogni portento di fuochi d’artificio. Migliaia e migliaia di minuscole particelle luminose, lucciole celesti. Alcune, le più prossime, in procinto di posarsi. Pur avvicinandosi, le prime quasi a portata di mano, tuttavia non ingrandivano. Non conservavano nulla della pregressa natura di immani corpi gravitazionali e infuocati che forse erano state. Sempre le stesse del giorno in cui avevano ricevuto il primo umano sguardo, mantenevano la loro illusoria sostanziale natura di minuscoli baluginanti puntini che per infinite ere l’illusione aveva decorato il cielo. Ed ora la Terra.
Scendevano e scendevano. Scendendo moltiplicavano e moltiplicando differenziavano. Per colore anzitutto. Ognuno uno suo, ognuno esibendo una particolare sfumatura tra le infinite esistenti. Rosso, azzurro, verde, gialle, indaco, violetto… ma il vero notevole e singolare di quella pacifica invasione era dato dalla sensazione di aggraziato che trasmettevano. In particolare la moltitudine delle stelle o luci o sfere o puntini bianchi; nonché quelle, numeroso anch’esse, che erravano passeggiando tra i colori. Di qualunque tonalità fossero, vezzose le si sarebbe potuto persino definire. Giovani, fresche, esuberanti. Sì, anche esuberanti. Come in procinto di erompere, spontanea manifestazione di vitalità.
Alle prime seguirono le seconde e poi le terze, ogni volta più fitte e numerose. Posandosi a caso decoravano tetti, alberi, strade, marciapiedi, piante e balconi. Piovendo persino su di noi. Impigliandosi nei capelli, poggiandosi sulle mani, trasmettendo carezze. I dintorni si popolarono rapidamente di entità che erano state piante e era non altro che aleatori alberi di Natale.
Una di esse posò in prossimità di noi, a metà delle spazio che ci separava. Sul tavolo rotondo su cui avevamo appoggiato le bevande preferite. Lui un caffè lungo, all’americana; io un te bollente. Per godere ambedue del fresco incipiente che prometteva la notte. Promessa mantenuta prima della fine del giorno stesso aveva, a causa del fresco che venticello che proveniva dal mare. Nella nostra città sempre, sempre il fresco della sera era stato più fresco che in altre parti. La lucciola galeotta si posò nel punto mediano dello spazio che ci separava, tra una tazzina e l’altra, i bicchieri, l’inevitabile cestino delle fette biscottate.
“Buongiorno,” mi sembrò sentir salutare, alito di bambino addormentato. Non diedi retta. Ascolto tante cose io, alcune preziose, mai però dato retta. Procedo così, alla cieca, dritto incontro alla mia perdizione. Vittima della stessa mediocre ispirazione che avvilisce ognuno. D’altronde che saluto era mai quello, datato di quale sincerità? di giorno non si poteva più parlare, sopravvenuta ormai la piena oscurità fitta della notte.
Avvertì Franco il medesimo saluto? No, lui era impegnato ad afferrare al volo quelle avanguardie del cielo, utilizzando il gesto rapace di chi tenta di appropriarsi della vita degli insetti. Lo stringersi del palmo intorno alla luce era palesemente inutile, non ne arrestava la discesa. La luce attraversava la carne, ma Franco perseverava. Ce ne voleva con uno come lui, non a caso amico di uno come me, per indurlo a desistere.
Posatesi sul pavimento però smettevano di scendere. Non lo trapassavano come avevano fatto con la mano. Smettevano di scendere anche quando si posavano sulle foglie, sui vasi nudi, su quelli in fiore… ben presto ogni superficie, corrimano del balcone incluso, ne fu ricoperta.
“Sembra una nevicata,” commentò Franco. Per nulla spaventato. Non ancora. Come me osservava stolidamente, paciosamente, tranquillo, l’animo alle prese con un eccesso di stupore, troppo, per poter entrare in agitazione. Osservando, osservavamo soltanto. “Una bianca distesa fatta di sola luce.”
Per subito dopo correggersi. No non si trattava solo di bianco, ma di un rimescolato arcobaleno.
Bizzarrie dell’essere e del non essere, della mente e della coscienza. L’intera galassia stava precipitando sulla Terra e noi paciosi a sorbire caffè, tè, masticare noccioline, bearsi della notte, sul quasi indifferente, degnandosi appena.
“Ho vissuto qualcosa del genere una cinquantina di anni fa a Belluno,” dissi. Lui, sì, interessato (miracolo delle lucciole calanti). “Sul piazzale della stazione ferroviaria. Appena sceso dal treno aveva iniziato a nevicare. Lo spazio largo del piazzale ne fu subito coperto. Nevicava fitto, larghi cristalli di neve che scendevano lenti, addensando sui fiocchi già caduti. Faceva un freddo cane, nel simile di adesso in cui fa un caldo cane. Mi strinsi nel mio pesante cappotto verde e mi avviai verso l’albergo. Prima però mi attardai un poco a ammirare.”
Mormorò qualcosa sul freddo, non gli piaceva il freddo; poi sul caldo, non gli piaceva il caldo. Quasi nulla piaceva a Franco. Salvo che bere caffè, importunare ragazze e spararle grosse. Concluse imprevedibilmente con qualcosa di saggio (l’avvertii nel rimodularsi della voce) il cui senso specifico malauguratamente mi sfuggì (sono il giusto contraltare di Franco: non a caso la vita ci ha appaiati). Ero troppo occupato a percepire, a dare senso, individuare almeno un bandolo di matassa per accedere ai bofonchia menti demenziali intelligenti dell’amico.
Fino’ora mi sono riferito alle stelle in caduta frenata utilizzando il comodo termine di “lucciole”. Tuttavia le sferette multicolori e bianche e radiose e marmorate che procedevano dal cielo avevano ben poco a che fare con i lampyridi. Niente enzimi in quei minuscoli corpi. Forma nessuna, non elitre, ossiluciferina e luciferasi che dir si voglia. Impossibile assimilarli a quei coleotteri ed ancor meno ai freddi bianchi fiocchi di neve. Era pure palese che non si trattava di stelle, o di astronavi, per quanto in formato minimo; né di alcunché che fosse entrato in precedenza nel novero delle esperienze umane. Erano luce e basta, essenza di luce, null’altro che luce e basta; di qualcosa che aveva attinenza, attinenza nascosta con la luce e basta. Scendevano e scendevano, coprendo col passare dei minuti e poi dei quarti d’ora, ogni possibile superficie sulla quale potessero posarsi. Era sufficiente una superfice minima della larghezza di un centimetro e si accumulavano, continuando a accumularsi, apparentemente bene intenzionati a fasciare, sudario di gloria, l’intero orbe terracqueo.
“Bello orbe terracqueo,” riconobbe Franco. “Adeguato alla retorica dell’avvenimento.”
Ha letto i miei pensieri, valutai. Valutando nel contempo la singolarità dell’evento. Ed io l’uguale, coinvolto dai pensieri suoi. Nulla di articolabile in parole. La sola immagine di una donna piccolina, non identificabile, il viso nascosto dietro un sipario di capelli rossi (il gran seno però era impossibile nasconderlo). Seppi di chi si trattava. I suoi pensieri. Gli antichi desideri, le pregresse frustrazioni. Castigo interiore suo, castigo d’ognuno.
“Franco!” esclamai. “Ancora! Dopo tanto tempo!”
Dopo più di venti anni Rossana, la Rossana della sua vita, ancora nella mente. Ancora negli occhi, nelle orecchie, nel discernimento. Per impedirgli di esercitarlo. Aveva amato molto quella donna, molto desiderata. Ma lei, lei dura, aveva scompaginato ogni difesa con la sua bellezza e dopo aver conquistata e saccheggiata la rocca, l’aveva abbandonata in rovina. Una scrollare di spalle, una risata, un “non vali niente” e passata a dar retta ad altri, dieci altri. Forse cento altri. A Franco non era rimasto che impazzire, trasformarsi nel gigantesco istrice ch’era diventato. La pazzia, le tante manie, ingannevole via di fuga, Rossana sempre presente. Crudele, irridente… E che non gli si presentava davanti, di tanto in tanto, al braccio del decimo o ventesimo amante, esibendo ognuno con maggiore vanità di quanto non esibisse l’immenso seno?
Dopo Rossana Franco non era più stato lo stesso. S’era messo in punizione da solo, raggrinzendo in un prigione di disdetta e disdoro, infelicità per scelta. Se la portava sempre dietro la prigione, unica sua vera compagnia. Dissimulava utilizzando cerebralismo d’accatto e cinismi d’occasione. S’era chiuso in casa, a studiare, come diceva lui. A maledire cielo e terra a mezzo del suo proprio dolore, credevo io. Chi aveva ragione? Lui, al solito. Lui, lui. Non conveniva, non conviene, anche per una volta sola, dissentire dalle sue opinioni. A che pro?
“Lascia perdere,” invitò scrollando le spalle. “Dopo tanto tempo che?”
Il tempo non esisteva. Non esisteva modo di dimenticare. Sanare le ferite si poteva solo quando queste non erano inflitte da una donna. La donna è l’esser più potente dell’Universo, uguale quasi a Dio. Solo lei può riparare le brecce che il chicchessia le permette di aprire nel proprio cuore… con la sua risposta desidera farmi credere d’aver superato? Sì, amico mio, sia come tu vuoi. Io però quella donna l’ho vista, tornata al centro dei tuoi pensieri, dal fondo nel quale l’avevi relegata.
“Hai notato” tornando alle preoccupazioni del presente, “che evaporano non appena a contatto con il suolo?”
In effetti non evaporavano. Si schiudevano come tante uova giunte a maturazione. Uno sbuffo di vapore colorato e le uova cosmiche spallidivano. Di loro non restava che un minuscolo puntino brillante del tanto colorato di poco prima. Come la bara, carapace vivente, di un artropodo giunto alle fasi finali della sua crescita. Ma Franco d’improvviso fu attratto da tutt’altro per seguire me e il mio rendermi conto.
“Cosa cavolo sta succedendo?” lo udii esclamare, tornato al nervoso suo esagerato di sempre. La patina di tranquillità che ci aveva avvinti ambedue (sono portato a pensare che non fosse nostra, un espediente per renderci più facili accettare gli avvenimenti); quella patina era scomparsa. Lui si alzò di scatto e io pure, incapace di contenere l’impazienza. Perigliosamente veloce, temetti per le giunture, che qualcuna si ribellasse. Nessuna schioccò, protestò, mi sommerse di dolore. Anche dorsali e cervicali se ne stettero buone. Dritto in piedi dall’alto della mia imponente statura di 168 cm, forse anche 167 o 166 (erano decenni che più non la misuravo e sapevo che l’età rimpicciolisce: sappia telo tutti), scrutai l’ampio orizzonte che i tanti piani del palazzo mettevano a disposizione. Scrutai a destra e poi a sinistra del lungo terrazzo sul quale avevamo inutilmente contato per un inizio notte tranquillo.
Non vidi alcunché potesse indirizzarmi per capire il “cavolo” (veramente lui aveva adoperato ben altro più efficace termine) che succedeva. L’unica cosa di cui fossi certo era che qualcosa non andava. Ma Franco era ben oltre la mia sordità.
“Mi sto cacando sotto,” affermò. Chiarimento che non valse per nulla a placare le inquietudini personali.
“Il bagno sai dov’è…”
“Non senti il suono?”
“Che suono?”
“Una voce lontana e poi una fanfara di sole trombe…”
La notte nonostante la città, nonostante il chiarore delle sfere che continuavano a scendere, era buia come mai era stata. Le lucciole pullulanti, insegne dei negozi, illuminazione stradale, nulla potevano. Potevo porre io attenzione e lo feci. O tentai di farlo. Le fanfare no, non le udii, ma la voce sì. Alto tuono di temporale che, rotolando nell’aria tersa, s’espandeva per ogni dove. Avrebbe piovuto, di certo.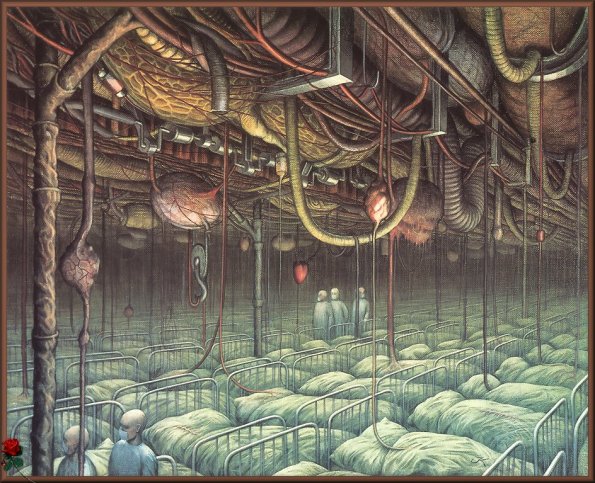
Un suono quello che mi paralizzò. Restai non so quanto ad osservare il pauroso incanto della notte, la semina immensa, l’Universo intero che prendeva possesso della tomba scoperchiata ch’era diventata la terra. Un secondo o un’ora, non so. Neppure so se Franco restò immobile, ipnotizzato, nel mio identico tempo sospeso. So che fui svegliato da tutt’altro che dai suoi improvvisi scoppi d’ira. Mi svegliò l’appendice inevitabile del tuono, la pioggia. Pioggia di sole, non d’acqua. Fu uno scroscio di luce abbagliante, una catinella colma, quella che ricevetti. Un improvviso proliferare di fotoni simile a quello che, all’origine del Tutto, aveva dato luogo a questo tutto. Un irradiarsi improvviso che cancello la notte particolarmente intensa di poco prima.
Proveniente da altrettanti milioni di piccole sfere che invece di completare il percorso s’erano aggruppati a un certa altezza per formare tanti piccoli soli, la luce fu. Radiosa. Invadente. Pervasiva. Piovve, ma non acqua. Piovve luce. Vidi bene allora che ognuna delle sfere vaporizzanti, lasciava dietro un grumo, non so, una fiammella baluginante, fiamma di candela, danzante nell’aria. Ogni fiammella una voce. Una nel milione di altre voce che iniziarono a parlare tutte insieme, sospinte dalla necessità di farsi sentire. Il brusio immane, la confusione irrimediabile. Eppure, non potei evitare di notarlo, le fiamme di candela parlavano tutte insieme, peroravano tutte insieme senza che nessuna desse sulla voce dell’altra. A tutte veniva concesso distinguersi, all’interno di un piccolo spazio aleatorio che ad ognuna assegnato.
“Cazzo!” esclamò Franco a questo punto (non posso più coprirne la volgarità), dimostrandomi che, qualunque le disavventure che aveva attraversato, era tornato al mio stesso presente.
Ho riportato il suono come tale, credendo possibile riportarne il qualcosa; impossibile invece riportarne l’enfasi, lo stupore. Chi ha mai potuto tradurre l’invisibile e l’inaudito in parole? Se ne poteva a malapena segnalare la presenza. Franco lo aveva fatto a modo suo, utilizzando una sola parole; io tentando la medesima impresa azzardando lo possibilità attraverso mille. Non so lui, osservando il medesimo suo osservato, giunsi alla conclusione che il mistero non era poi tanto fitto da doverlo riassumere né con una sola parola, Né a mezzo di volumi: enciclopedie e traduzioni. Forse neppure concetti, erano estraibili dai suoni che mi sembrava di udire (un unico suono continuo, in verità). Non c’erano significati da spiegare, ma momenti specifici di un campo psichico, d’un quantum emotivo.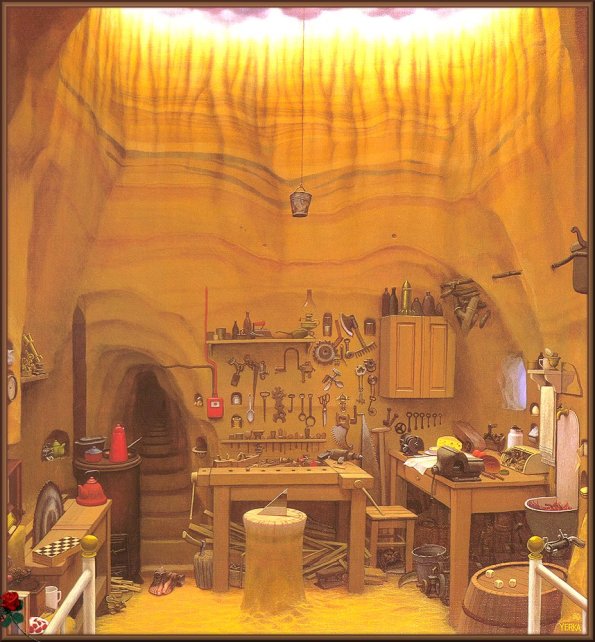
Mi si drizzarono i peli delle braccia. Non quelli del capo che non ho, sì però quelli Franco, dotato di una capigliatura formidabile. Un sordo verso gracchiante di gola poté essere udito. Il suo, il mio…
Non abbiate paura, perorano tutte insieme le ex-lucciole evolutesi in istanze di consolazione, loro tutte un concentrato di concetti e sensazioni. Le loro, le mie, quelli di Franco, le innumerevoli che percorrevano pelle e mente dei miliardi di miei simili sparsi per il mondo. Tutta una realtà mobilitata per comunicare e alla quale veniva impedito di continuare a non sentire. Continure a sonnecchiare, mentre la vita procedeva, i destini arrivavano al loro dunque.
Voci voci voci, una Babele bene organizzata di lingue e comprensioni. Tra tutte qualcuna familiare. Che arrivava e passava, sospinta indietro da altre che si portavano in primo piano. Non ne riconobbi nessuna. In realtà non ne ebbi il tempo. Franco mi anticipò, in anticipo come sempre. Non aveva forse lui percepito per prima il cambiamento? l’Universo che precipitava su di noi. Percipito inoltre l’annuncio della trasformazione, che ho descritto sotto la specie, una a mio vedere capace di descrivere, del tuono?
“Mamma!” lo udii gridare, incurante d’essere patetico, felice solo di quel suo essere tornato bambino.
E mamma pietosa, nell’uguale di tutti: non avere paura… Di suo aggiunse, a beneficio del figlio: mai avere paura…
Com’era possibile, all’interno del nostro piccolo comprendonio, non avere paura se tutto ciò che circondava, l’aria, il suolo, le piante, la notte diventata giorno, trasmettevano lo stesso inquietante messaggio inquietante alienità? Ma poiché udii “padre!” e qualcuno interpellare anche me con quell’impalpabile con il quale Franco era stato illuminato, capii, motivo ulteriore di terrore, che non provocò terrore (ma quiete) che non c’era nulla di alieno in quel che succedeva. L’aria, il tuono, la luce trionfante, il giorno, la notte. Non lo erano le presenze che sempre più nettamente percepivamo. A meno che non si vogliano considerare aliene le anime, l’insieme della anime che erano state prima di noi e ora con noi, scivolate dalla dimensione immateriale del cosmo accanto nella nostra; ed erano lì per scopi che potevamo capire, ma che la nostra debolezza ci impediva di accettare. Perciò tranquillizzavano. Sapevano che quello che sarebbe seguito non era diverso da quello che loro avevano attraversato. E che ora tutti insieme avremmo affrontato.
Il tuono tornò, crebbe. Aveva fatto il periplo del mondo e si svelava per quella che era. Non la fine del mondo, il quale era già finito, da tempo, senza che ce ne accorgessimo. Già giunto al capolinea.
Quello era l’ultimo atto, l’ultimo secondo che precedeva la fine dell’ultimo atto e il Giudizio Universale.


