«Stalingrado»
Giuseppe Callegari ricorda Vasilij Grossman (*) presentando il suo libro e scegliendo alcuni brani
Premessa
Vasilij Grossman con Stalingrado mette in scena un romanzo storico. Non il solito pamphlet in cui si esaltano le gesta di grandi uomini che cambiano i destini del mondo. Non si tratta di un libriccino di poche pagine, ma di un “tomo” di oltre 800 e i protagonisti sono i piccoli uomini che insieme riescono a ribaltare la storia e a sconfiggere la belva nazista. Non a caso un passo del libro recita: “E in questo risiede la speranza del genere umano: sono le persone semplici a compiere le grandi imprese”.
Il tema di fondo rappresentato dall’invasione tedesca non viene sviluppato attraverso la descrizione delle battaglie, ma raccontando il prima e il dopo. E questi due tempi sono popolati da persone, cose e ambienti.
Appare Vavilov che riceve la lettera di chiamata alle armi e dichiara:“finito”.
“E non si riferiva alla sua firma sul registro, ma alla sua vita familiare, che era finita, che era stata stroncata in quel momento esatto”. Diventa di una parusiaca tristezza il momento in cui si accomiata dalla figlia: “Nastja lo guardava con occhi diversi, indagatori. In quei pochi attimi era diventato un altro, per lei, e fra di loro sembrava essere caduto un velo invisibile”.
Naturale conseguenza della guerra è la produzione di orfani. Ci appare Griša, un bambino poverissimo, i genitori ammalati e la casa che è un tugurio, ma tutto questo non gli impedisce di essere felice. Per lui: “Quella casetta era meglio di tutti i palazzi e le chiese del mondo. Perché lì dentro lo amavano, lui, la sua timidezza e le sue orecchie grandi”. E alla festa del Primo Maggio dice ai genitori: “Mamma, papà, come siete belli, come siete eleganti”. È il suo ultimo saluto, perché poco dopo le bombe mettono fine alla sua felicità (che non chiedeva niente) ma soprattutto a una storia d’amore, con epilogo straziante: “Nessuno sapeva quanto li amasse, quanto fosse strenuo, dolce il suo amore per loro. Griša li aveva visti dopo il bombardamento, riversi, coperti con un panno grezzo e bruciato: il naso aguzzo del padre, l’orecchino a cerchio della madre, una ciocca dei suoi pochi capelli biondi…”.
Grossman non presenta solo il singolo individuo nelle sue interazioni, ma visualizza il gruppo, ci fa partecipi della comunità, non come entità grigia, inestricabile, informe ma come una forza viva, un coro che trasforma le difformità in suono armonico. “In quei giorni fu come se la differenza di età, professione e stato sociale che talvolta impediscono alle persone di avvicinarsi scomparissero, e chiunque lavorava alla Centrale elettrica sentì forte i legami veri — umani — della vita e si sentì parte di un’unica grande famiglia unita”.
In uno scenario apocalittico come l’assedio di Stalingrado c’è posto per alcune riflessioni sull’arte, alla quale non ci si accosta intimoriti, senza alcuna gioia ed emozione perchè diventerebbe “un’inferriata ruvida fra l’uomo e il mondo”. Di fronte a un’espressione artistica ci si scopre a gridare: “Anch’io ho pensato e provato qualcosa di simile e lo provo ancora; anch’io l’ho vissuto sulla mia pelle!”.
Infatti: “L’arte di questo tipo non separa l’uomo dal mondo, ma al mondo, alla vita, agli altri uomini lo unisce. L’arte di questo tipo non usa lenti colorate e «astruse» per guardare alla sua esistenza”. In pratica: “È come se la vita entrasse dentro di noi, come se accogliessimo nel nostro sangue, nella nostra mente e nel nostro respiro tutta l’immensità e la complessità della vita umana”.
La guerra, crudele e distruttiva, non può prescindere dal lavoro e dalla famiglia, due entità di pace che non entrano direttamente in contatto con il conflitto, ma rappresentano microcosmi con i quali si certifica l’appartenenza al mondo attraverso una singolare e creativa partecipazione. Infatti Andreev: “Fondeva l’acciaio secondo le sue personalissime regole e misure, aveva una sua percezione del tempo, della temperatura e delle proporzioni della carica fra ghisa e ferro di risulta. E siccome la tabella di marcia e le specifiche tecniche non sempre coincidevano con le sue, per rispetto per l’ordine e per la scienza Andreev le rimpiazzava con quelle richieste dal manuale, ma lo faceva dopo aver prodotto e consegnato ai reparti di forgiatura il suo ottimo acciaio”.
Andreev aveva anche una particolare ideologia per quanto riguarda la famiglia: “Per lui i rapporti fra suocera e nuora dovevano essere come quelli che vigevano all’interno di uno Stato e fra gli Stati. E i rapporti fra suocera e nuora erano la spiegazione esemplare di quanto accadeva fuori: le imperfezioni di casa erano le imperfezioni del mondo. «In più stare stretti è una disgrazia» pensava. «Ad averci spazio andrebbe meglio, ma mancano i soldi». E la mancanza di soldi e spazio era anche il primo motivo delle guerre fra Stati.
A casa Andreev era severo fino alla cattiveria, irascibile ed esigentissimo. In fabbrica, invece, si riposava dalle imperfezioni del mondo. In fabbrica la gente non cercava il potere sul prossimo, ma sulla ghisa e sull’acciaio. Ed era un potere che generava libertà, non schiavitù”.
Naturalmente esiste anche la ricerca di una spiegazione per la guerra in atto attraverso percorsi che spesso non collimano: “Il nazismo è forte, ma c’è un limite al suo potere. E dobbiamo tenerlo a mente. Il potere del nazismo sulle persone non è illimitato! Nella sostanza, in generale, Hitler non ha modificato la proporzione fra gli ingredienti dell’impasto tedesco, di quella loro pasta lievitata, bensì l’ordine. La feccia in cui vive il popolo, che è inevitabile nel capitalismo, il lerciume, ogni nefandezza che veniva taciuta, celata, tutte queste cose il nazismo le ha portate a galla, le ha fatte affiorare, le ha messe sotto gli occhi di tutti, mentre le cose buone, il buonsenso, la saggezza popolare — che sono il pane della vita – si sono depositate sul fondo, sono diventate invisibili, ma continuano a vivere e a esistere. Certamente il nazismo ha deformato e insozzato molti cuori, ma il popolo c’è. E ci sarà sempre”…
“No, non è così che si spiega quant’è accaduto in Germania! Lei sostiene che un manipolo di delinquenti con Hitler in testa ha fatto irruzione nella vita tedesca. Quante volte, però, nei momenti decisivi della sua storia, la Germania ha visto trionfare le forze reazionarie? Se non era un Friedrich era un Wilhelm Friedrich o un Wilhelm e basta. Dunque il punto non è il manipolo di scellerati con Hitler in testa; il punto sono i tratti salienti del militarismo prussiano, che sa sempre cavare dal cappello delinquenti e Überdelinquenti”.
Non può mancare l’amore, che mette in gioco quell’inestricabile miscuglio di ragione e sentimento, di cuore e di cervello che sancisce la relazione con l’altro attraverso la realizzazione di ciascuno di noi. “Rischiarati dai bagliori lontani, i suoi occhi brillavano; era davvero bellissima in quella luce tremolante, ora lugubre ora dolce. Anche lei doveva aver sentito, non con la mente né col cuore, ma con la pelle, le braccia, il collo, che lui respirava il suo odore, che le guardava la bella treccia che ricadeva sulle ginocchia, le braccia nude fino sopra il gomito, le gambe robuste. Ma non disse niente: sapeva che non c’erano parole per descrivere quello che stava nascendo fra di loro”.
Tuttavia l’amore può esplicitarsi anche con il “tradimento”. Infatti l’amore fecondo sparge i suoi frutti che, a loro volta, produrranno i semi per un’ampia condivisione di questo sentimento. Per fare questo occorre uscire dagli schemi “piccolo borghesi” del tradimento e della scappatella e avventurarsi fuori da questa logica con tutti i rischi che ne conseguono. E Grossman lo fa con Štrum, che la sera del sabato partì per la dacia: “Sul treno pensò a quanto era accaduto nei giorni appena trascorsi. Era un peccato che Čepyžin se ne fosse andato. Novikov, il colonnello che era passato da lui la sera prima, gli era piaciuto molto. Era contento di averlo conosciuto. Certo, meglio sarebbe stato conoscerlo una mezz’oretta dopo, così avrebbe potuto salutare Nina diversamente… Ma poco importava. Sarebbe ritornata il martedì seguente. E lui avrebbe di nuovo visto quella creatura splendida, giovane, adorabile.
Al pensiero di Nina si aggiungeva, altrettanto ostinato, quello per sua moglie. Se la immaginò sola e preoccupata per Tolja e ripensò ai tanti anni passati insieme”.
In questo coacervo di dubbi e incertezze, l’attrazione di Nina porta a costruire un castello di accuse contro la moglie Ljudmila anche se sa che ”Nel profondo della coscienza la logica di quelle accuse era sbagliata e di parte, menzognera e mendace. E vedere che la menzogna, che aveva sempre detestato, non solo si era insinuata nei rapporti con amici e parenti, ma aveva intorpidito le acque di fonte della sua ragione. Tuttavia, scendendo dalla banchina, si scoprì a domandarsi:
«Ma perché la menzogna deve essere il male? In che cosa è peggiore della verità?»”.
Gli uomini, le cose, i sentimenti, il tempo che scorre hanno come palcoscenico il paesaggio, e la steppa diventa sia un testimone oculare degli accadimenti sia l’attore protagonista da ammirare. “Quell’estate i tramonti della steppa erano particolarmente maestosi e sontuosi. Sulla steppa incombeva la polvere di milioni di piedi, ruote e cingolati, la polvere delle bombe che esplodevano, sospesa come un velo negli strati più alti e cristallini dell’aria insieme al respiro freddo dello spazio cosmico”.
La steppa si esprime con i colori, gli odori e i suoni che “non arrivano distinti all’orecchio umano, né vanno ascoltati uno per uno. I suoni della steppa sfiorano l’orecchio e arrivano diritti al cuore, riempiendolo di pace e serenità, ma anche di tristezza e angoscia”.
I suoni della steppa avvolgono e cullano i colori di un territorio che si veste in modo diverso a seconda del momento della giornata: “È enorme, la steppa. E come il cielo e il mare prendono colore al tramonto, così la terra dura e riarsa della steppa, grigiastra e giallognola durante il giorno, la sera cambia colore. […] La sera la steppa diventa rosa, poi blu, poi di un nero violastro”.
La trilogia della steppa si completa con gli odori che nascono dai colori e si accordano con i suoni: “Il calore del sole scalda le essenze racchiuse nella linfa delle varie erbe, di fiori e cespugli, che si posano come una nube sul fresco della terra, senza impregnarla, ma librandosi su di essa in volute piccole e lente”.
“Su tutto, poi, incombe il cielo della sera, con la terra che ci si riflette o col cielo che si riflette sulla terra, o con la terra e il cielo che si riflettono a vicenda come due enormi specchi, arricchendosi l’una con l’altro grazie al miracolo del duello fra buio e luce”.
(*) Vasilij Semënovič Grossman (Berdyčiv, 12 dicembre 1905 – Mosca, 14 settembre 1964) è stato un giornalista e scrittore sovietico.
Chiamata alle armi
Pȅtr Semënovič Vavilov si vide consegnare la chiamata alle armi nel momento meno opportuno: se al distretto militare avessero aspettato un altro paio di mesi, sarebbe certamente riuscito a lasciare la famiglia con cibo e legna per un anno.
Quando Maša Balašova attraversò la strada con un foglio bianco in mano puntando dritto verso casa sua, sentì una stretta al cuore. Vedendola sfilare sotto la sua finestra senza guardarci dentro, per un attimo Vavilov pensò che proseguisse; poi, però, gli tornò in mente che di giovani nelle case vicine non ne erano rimasti, e che ai vecchi non si portano avvisi di quel tipo. Difatti non era loro che cercava. Di lì a poco sentì un gran frastuono all’ingresso: nella penombra Maša doveva aver inciampato nel bilanciere, che era caduto a terra sbattendo contro il secchio.
Ogni tanto Maša Balašova passava a trovarli, la sera: era stata compagna di classe di sua figlia Nastja fino a poco prima, e avevano ancora le loro cose da dirsi. Di solito lo chiamava «zio Pȅtr», ma quella volta gli disse giusto: «Una firma qui per avvenuta consegna» e nemmeno fiatò con l’amica.
Vavilov si sedette al tavolo e firmò.
«Finito» disse, alzandosi.
E non si riferiva alla firma sul registro, ma alla sua vita familiare, che era finita, che era stata stroncata in quel momento esatto. La casa che doveva lasciare gli sembrò solida e bella. E meravigliosa, viva, una parente che aveva trascorso accanto a loro tutti quegli anni, gli sembrò la stufa che faceva troppo fumo nelle giornate umide di marzo, con i mattoni che spuntavano da sotto l’imbiancatura scrostata e con i fianchi gonfi per la vecchiaia. In inverno, quando rincasava, Vavilov si piazzava lì davanti, sgranava le dita intorpidite dal freddo e respirava il calore della stufa, mentre sotto il montone, la notte, della stufa sapeva sempre trovare i punti più caldi o più freschi. Quando si alzava col buio per andare a lavorare, per prima cosa si avvicinava alla stufa e cercava tentoni, con mano esperta, la scatola dei fiammiferi e le pezze da piedi che si erano asciugate durante la notte. Era tutto finito, sì: il tavolo con le mezzelune scure della padella rovente; la panchetta accanto la porta su cui sua moglie si sedeva a sbucciare le patate; la fessura sulle assi del pavimento vicino alla soglia, che i bambini usano per sbirciare la vita sotterranea di topi e scarafaggi; le tendine bianche alle finestre; il pentolone di ghisa talmente nero di fuliggine che di mattina nemmeno si vedeva, nel buio caldo della stufa; il davanzale con la piantina rossa nel vaso; lo strofinaccio appeso al chiodo… Gli era tutto caro e prezioso, in quel momento, così caro e prezioso come cari e preziosi sanno essere solo gli esseri umani. Dei suoi tre figli, il maggiore, Aleksej, era già in guerra; a casa restavano Nastja e Vanja, il piccolino di quattro anni, un bambino saggio e sciocco insieme che aveva soprannominato «samovar». E davvero gli assomigliava, a un samovar, panciuto e con le guance rosse com’era, con il pirolino che sempre gli spuntava dai pantaloni sbottonati e con i suoi sbuffi continui, seri e compresi.
A sedici anni Nastja già lavorava al kolchoz, e con i soldi si era comprata un vestito, un paio di scarpe e un basco di panno rosso che credeva elegantissimo. Se lo metteva e si guardava in uno specchio che per metà aveva perso l’argentatura, dunque si vedeva col cappello in testa, ma vedeva anche le dita che reggevano lo specchio: faccia e cappello, insomma, li vedeva riflessi, mentre le dita sembravano come dietro il vetro di una finestra. Ci avrebbe volentieri dormito, col basco, ma temeva di rovinarlo nel sonno; perciò lo teneva accanto a sé e al risveglio lo accarezzava subito. Quando Vavilov la vedeva uscire a passeggio con le amiche, tutta allegra e felice con il famigerato basco in testa, di solito si rattristava al pensiero che a guerra finita ci sarebbero state molte più ragazze che uomini da sposare.
La vita di Vavilov era tutta lì dentro. A quel tavolo Aleksej e i suoi amici avevano passato le notti a studiare algebra, geometria e fisica per entrare all’istituto agrario. A quel tavolo Nastja aveva letto con le amiche La letteratura più amata, un’antologia di racconti. A quel tavolo si erano seduti i figli dei vicini tornati da Mosca e da Gor’kij, e gli avevano raccontato della loro vita e del loro lavoro. «Embè?» aveva commentato la moglie quella volta. «Anche i nostri andranno in città a studiare da professori e da ingegneri».
Vavilov prese dal baule il fazzoletto rosso in cui teneva avvolti i documenti di tutti e gli atti di nascita dei figli, e tirò fuori il libretto militare. Con il certificato di Vanja e i documenti della moglie e della figlia di nuovo nel baule e i suoi nella tasca della giacca, sentì di essersi ormai staccato dalla famiglia. Nastja lo guardava con occhi diversi, indagatori. In quei pochi attimi era diventato un altro, per lei, e fra loro sembrava essere calato un velo invisibile. Quel giorno la moglie sarebbe tornata tardi: l’avevano mandata con altre donne a spianare la strada che portava alla stazione e su cui passavano i camion militari con il fieno e il grano per il fronte.
«Figlia mia, tocca a me» le disse Vavilov.
Calma, lei rispose.
«Per me e la mamma non ti devi preoccupare. Abbiamo il lavoro. Basta che torni intero» e dopo aver alzato gli occhi aggiunse: «Magari incontri Alȅša, e insieme vi passerà meglio».
Gente semplice
Da testimone di eventi importanti e terribili, la moglie del responsabile continuava a parlare, convinta com’era di conoscere la verità ultima, e cioè che il genere umano è sempre e comunque ipocrita, debole e bugiardo.
Certe persone riescono a vedere solo vizi e debolezze del prossimo. E non capiscono, invece, che c’è anche chi a prezzo di sofferenze enormi e di imprese importanti ottiene dei successi. Fra qualche tempo, quando guarderanno indietro verso anni di grande fatica, quando il fragore di un’epoca di sangue e di scosse epocali si sarà sopito e davanti agli occhi avranno i tumuli delle tante sepolture – monumenti a opere sovrumane degne giusto di qualche divinità –, forse diranno che in quegli anni vivevano solo titani, eroi, giganti dello spirito. Una visione nobile, ma ingenua del passato, cui fa difetto la verità.
La mannaia tedesca minacciava Stalingrado. E come Stalingrado minacciava anche la dedizione alla libertà, il sogno della giustizia, la gioia del lavoro, la fedeltà alla Patria e ai figli, l’amore materno, la sacralità stessa della vita.
L’ultima ora di Stalingrado, della Stalingrado di prima della guerra, non fu diversa dalle ore e dai giorni che l’avevano preceduta. Qualcuno carreggiava patate, altri facevano la fila per il pane, altri ancora parlavano delle tessere annonarie; al mercato si continuava a barattare e a vendere latte, pane, zucchero grezzo e stivali militari; nelle fabbriche chi era chiamato a lavorare non smetteva di farlo… Coloro che si è soliti definire «gente semplice», «lavoratori comuni» – la fonditrice, il macchinista della Centrale elettrica, i soldati volontari, gli impiegati, i medici, gli universitari, i bassi ranghi del partito – non sapevano ancora che, di lì a qualche ora, con la stessa semplicità con cui avevano lavorato giorno dopo giorno, molti di loro avrebbero compiuto gesta che le generazioni seguenti avrebbero definito immortali.
Questo perché la dedizione alla libertà, la gioia per il proprio lavoro, la fedeltà alla Patria e l’amore materno non sono un’esclusiva degli eroi. E in questo risiede la speranza del genere umano: sono le persone semplici a compiere le grandi imprese.
Griša Serpokryl
Il padre di Griša Serpokryl aveva un leucoma, per questo non era partito soldato. All’inizio della guerra un comandante di passaggio aveva chiesto di passare la notte da loro, ma poi si era guardato intorno, aveva scosso la testa e aveva detto: «Anzi no, cerco qualcosa di meglio». Per Griša, invece, quella casetta era meglio di tutti i palazzi e le chiese del mondo. Perché lì dentro lo amavano, lui, la sua timidezza e le sue orecchie grandi. La madre zoppicava sulla gamba più corta, ma andava comunque a rimboccargli le coperte sopra la stufa, e il padre gli puliva sempre il naso con il palmo ruvido. Anche in quel primo anno di guerra, a Pasqua, la madre gli aveva cotto un piccolo kulìč dentro a una lattina e gli aveva regalato un uovo dipinto, mentre per le feste di maggio il padre gli aveva portato dalla città una cintura gialla con la fibbia bianca.
Sapeva che gli altri ragazzini prendevano in giro la madre perché era zoppa, ma proprio per questo lui l’amava così tanto. Per il Primo Maggio i suoi genitori si erano vestiti bene, erano usciti e l‘avevano portato con sé; Griša era fierissimo di loro e della sua cintura nuova, mentre camminavano vicini. Il padre gli sembrava grande e forte, la madre bella ed elegante. E gliel’aveva anche detto: «Mamma, papà, come siete belli, come siete eleganti», e li aveva visti scambiarsi un’occhiata felice e sorridergli commossi, inteneriti.
Nessuno sapeva quanto li amasse, quanto fosse strenuo, dolce il suo amore per loro. Griša li aveva visti dopo il bombardamento, riversi, coperti con un panno grezzo e bruciato: il naso aguzzo del padre, l’orecchino a cerchio della madre, una ciocca dei suoi pochi capelli biondi… Nella sua testa la madre e il padre erano rimasti così – uniti, vicini, morti –, e con lo sguardo tenero e commosso che si erano scambiati dopo i suoi complimenti, lui con la giacca e gli stivali nuovi, lei col suo bel vestito marrone, il fazzoletto bianco, la collana tipica di quelle terre…
Non aveva nessuno a cui parlare del suo dolore, un dolore che nemmeno lui capiva, ma che era insostenibile: quei corpi morti e quei visi commossi e inteneriti, il giorno dell’ultimo Primo Maggio, erano tutt’uno nel suo cuore. La sua mente si era ottenebrata. Griša aveva iniziato a pensare che, se stava male, era perché poteva muoversi, parlare, masticare e mandare giù il cibo, e per questo si bloccava, paralizzato da quella sofferenza che gli offuscava il cervello. Probabilmente sarebbe anche morto a quel modo, senza parlare, rifiutando il cibo, stremato dall’orrore che ormai provava di fronte alla luce, alle corse e alle chiacchiere dei bambini, ai gridi degli uccelli, al vento. Quando lo avevano portato all’orfanatrofio, educatrici e insegnanti non erano riusciti a combinare nulla, con lui, non erano serviti libri, né disegni, e nemmeno la minestra di riso, la marmellata di albicocche o il cardellino nella gabbietta. E allora la dottoressa aveva disposto che lo ricoverassero in un ospedale dove lo avrebbero alimentato artificialmente.
La sera prima che lo trasferissero, invece, l’inserviente era entrata nella sua stanza per lavare il pavimento e l’aveva guardato a lungo senza dire nulla, dopo di che si era messa in ginocchio, gli aveva stretto al petto la testolina e aveva attaccato a dire, come usa in campagna: «Piccolino, bambino mio, non ti vuol nessuno, nessuno ti vuole bene…».
Lui aveva cominciato a gridare, a divincolarsi…
Allora lei l’aveva portato in braccio fino alla sua stanza, l’aveva adagiato sulla branda e gli era rimasta accanto per gran parte della notte, e lui le aveva parlato, aveva mangiato un po’ di pane e aveva bevuto un po’ di tè.
Il valore di ogni singolo individuo
Le famiglie di chi era rimasto alla Centrale elettrica erano sfollate di là dal Volga, e dunque ingegneri e operai non tornavano a casa a dormire, ma restavano tutti lì, nella StalGRES sotto legge marziale. Con quella vita che era da scapoli e da soldati insieme, con quella convivenza forzata fra gente che si conosceva da tempo per aver condiviso il reparto, le assemblee di produzione e di partito e le sedute del comitato di fabbrica, nel nuovo, minaccioso contesto di sibili di aerei nemici e scoppi di bombe e di granate quel gruppo di persone legate dal lavoro vide cambiare profondamente legami e rapporti umani.
In quel nuovo contesto, ognuno, persino chi aveva mansioni di rilevanza minore, divenne indispensabile per tutti, e l’interesse per il prossimo non si limitò più al lavoro, ma si ampliò, si fece più articolato, coinvolgendo decine di pieghe del carattere che nei rapporti professionali consueti venivano stirate.
In una città che era oramai la misura della fragilità e della precarietà dell’esistenza umana, il valore di ogni singolo individuo risaltava in tutta la sua potenza.
Amicizia, uguaglianza fraterna, rispetto premuroso e reciproco trovavano forma ed espressione nelle cose piccole e in quelle grandi.
Nikolaev, il responsabile di partito, era consapevole di tutto ciò che gravava sulle sue spalle. Eppure, proprio in quei giorni tragici e arroventati di settembre seppe trovare una parola per tutti: all’ingegner Kapustinskij disse che con la sua ulcera avrebbe fatto meglio a non fumare a stomaco vuoto; all’elettricista Suslov disse che ne aveva viste tante in vita sua, ma che aveva un cuore buono e profondo; dell’addetto alla sicurezza Golidze che era un tipo irascibile ma allegro, sensibile e attento agli altri; di Paramonov, il tecnico del secondo piano, disse che conosceva bene la letteratura e che avrebbe dovuto insegnare in una facoltà umanistica, e non armeggiare coi trasformatori; di Kasatkin, che era stato sfortunato in amore e per questo parlava male di famiglia e matrimonio: non era cattivo, però, e anzi gli piaceva scherzare e amava molto i bambini.
In quei giorni fu come se la differenza di età, professione e stato sociale che talvolta impediscono alle persone di avvicinarsi scomparissero, e chiunque lavorava alla Centrale elettrica sentì forte i legami veri – umani – della vita e si sentì parte di un’unica grande famiglia unita.
L’arte
Quando leggiamo libri cervellotici, quando cervellotica e complessa è la musica che ascoltiamo, o la pittura che guardiamo, che ci turba proprio perché inintelligibile, il pensiero che ci affligge è: quanto sono straordinari, complicati, difficili e incomprensibili le idee, le emozioni e le parole dei personaggi dei romanzi, i suoni di certe sinfonie, i colori di certa pittura! E quanto sono diversi da quelli che sperimento io insieme a chi mi sta accanto! È un mondo altro e ben poco ordinario, al cui cospetto noi e la nostra vita semplice ci sentiamo intimoriti; ragion per cui è senza alcuna gioia e senza emozione alcuna che leggiamo quei libri, ascoltiamo quella musica e guardiamo quelle tele. La trina complessa, pesante e invalicabile di quel tipo di arte è un’inferriata ruvida di ghisa fra l’uomo e il mondo.
Ci sono libri, invece, che fanno dire con gioia a chi li legge: “Anch’io ho pensato e provato qualcosa di simile e lo provo ancora; anch’io l’ho vissuto sulla mia pelle!”.
L’arte di questo tipo non separa l’uomo dal mondo, ma al mondo, alla vita, agli altri uomini lo unisce. L’arte di questo tipo non usa lenti colorate e “astruse” per guardare alla sua esistenza.
Quando leggiamo quelle pagine, è come se la vita entrasse dentro di noi, come se accogliessimo nel nostro sangue, nella nostra mente e nel nostro respiro tutta l’immensità e la complessità della vita umana.
Tanta semplicità, però, è la semplicità suprema della luce bianca che nasce dallo specchio cromatico delle onde luminose.
Tanta semplicità tersa, placida e profonda ha in sé la verità dell’arte autentica. È come acqua di sorgente che lascia vedere il fondo, i ciottoli, il verde, ma che oltre ad essere trasparenza è anche specchio: in quell’acqua l’uomo vede riflesso sé stesso e il mondo in cui lavora, combatte e vive. L’arte, insomma, combina la trasparenza del vetro alla potenza di uno specchio perfetto sull’universo.
La fabbrica e la famiglia
Il rispetto per gli scienziati, l’ordine e l’organizzazione Andreev li esprimeva a fine turno, riempiendo tutte le schede e i piani di lavoro che avrebbe dovuto compilare prima. Andreev fondeva l’acciaio secondo le sue personalissime regole e misure, aveva una sua percezione del tempo, della temperatura e delle proporzioni della carica fra ghisa e ferro di risulta. E siccome la tabella di marcia e le specifiche tecniche non sempre coincidevano con le sue, per rispetto per l’ordine e per la scienza Andreev le rimpiazzava con quelle richieste dal manuale, ma lo faceva dopo aver prodotto e consegnato ai reparti di forgiatura il suo ottimo acciaio.
Nei libri Andreev cercava una spiegazione per quello che non arrivava a capire da solo. Da quando sua moglie Varvara Aleksandrovna e la nuora avevano cominciato a non andare d’accordo, la vita in casa era diventata insostenibile: le due donne litigavano in continuazione. E, se possibile, i suoi tentativi di ridurle alla ragione avevano persino peggiorato le cose. Era stato allora che aveva preso in biblioteca il libro di Bebel La donna e il socialismo, sperando che lo aiutasse a sbrogliare il caos in famiglia: il titolo sembrava fare al caso suo. E invece parlava di tutt’altro.
Andreev aveva le sue idee quanto alle relazioni familiari. Per lui i rapporti fra suocera e nuora dovevano essere come quelli che vigevano all’interno di uno Stato e fra gli Stati. E i rapporti fra suocera e nuora erano la spiegazione esemplare di quanto accadeva fuori: le imperfezioni di casa erano le imperfezioni del mondo. «In più stare stretti è una disgrazia» pensava. «Ad averci spazio andrebbe meglio, ma mancano i soldi». E la mancanza di soldi e spazio era anche il primo motivo delle guerre fra Stati.
A casa Andreev era severo fino alla cattiveria, irascibile ed esigentissimo. In fabbrica, invece, si riposava dalle imperfezioni del mondo. In fabbrica la gente non cercava il potere sul prossimo, ma sulla ghisa e sull’acciaio. Ed era un potere che generava libertà, non schiavitù.
Andreev si vergognava che in famiglia litigassero tanto. Sua moglie, però, era molto fiera di lui, consapevole del rispetto che godeva fra colleghi e ingegneri.
In fabbrica c’erano molti giovani ingegneri e fonditori diplomati negli istituti tecnici o ai corsi specialistici. Lavoravano diversamente, rispetto ad Andreev: erano sempre in laboratorio, mandavano puntualmente ad analizzare i campioni, consultavano ogni due per tre lo schema delle procedure, verificavano la temperatura e il flusso di gas, non si staccavano da manuali e istruzioni varie e presenziavano a tutte le riunioni. Lavoravano bene. Tanto quanto Andreev.
La Germania nazista
Čepyžin fece un cenno rassegnato con la mano e disse:
«Il nazismo è forte, ma c’è un limite al suo potere. E dobbiamo tenerlo a mente. Il potere del nazismo sulle persone non è illimitato! Nella sostanza, in generale, Hitler non ha modificato la proporzione fra gli ingredienti dell’impasto tedesco, di quella loro pasta lievitata, bensì l’ordine. La feccia in cui vive il popolo, che è inevitabile nel capitalismo, il lerciume, ogni nefandezza che veniva taciuta, celata, tutte queste cose il nazismo le ha portate a galla, le ha fatte affiorare, le ha messe sotto gli occhi di tutti, mentre le cose buone, il buonsenso, la saggezza popolare – che sono il pane della vita – si sono depositate sul fondo, sono diventate invisibili, ma continuano a vivere e a esistere. Certamente il nazismo ha deformato e insozzato molti cuori, ma il popolo c’è. E ci sarà sempre».
Galvanizzato, guardò Štrum, gli prese la mano e continuò:
«Pensi a una qualche cittadina dove abitano persone note per la loro onestà e umanità, per l’amore che nutrono per il popolo, per la loro erudizione e bontà. Le conoscono tutti queste persone, anche i vecchi e i bambini. Sono il fiore all’occhiello della città, il suo fulcro: insegnano in scuole e università, scrivono libri, pubblicano sui giornali operai e sulle riviste scientifiche, si adoprano e combattono per la libertà del lavoro. E sono sotto gli occhi di tutti dalla mattina alla sera. Nelle fabbriche, nelle sale conferenze, per strada, nelle scuole, nelle piazze: sono dappertutto. Poi cala la notte, e per le strade esce altra gente, escono persone che in città conoscono in pochi, che hanno vite e lavori misteriosi e sporchi, che temono la luce, che si muovono di soppiatto, nel buio, fra le ombre delle case. Quello che è successo ora, però, è che la forza bruta e oscura di Hitler ha fatto irruzione nel mondo. E che chi prima portava la luce, ora finisce nei lager e nelle prigioni. Qualcuno muore armi in pugno, qualcun altro si nasconde. Di giorno nessuno vede più queste persone per strada, nelle scuole, nelle fabbriche o nelle manifestazioni operaie. I libri che hanno scritto finiscono al rogo. Certo, c’è chi abiura, prende le parti di Hitler e indossa la camicia bruna. Resta il fatto che chi si nascondeva nella notte ora ha guadagnato la luce e riempie il mondo del fragore delle sue nefandezze. E allora sembra che la ragione, la scienza, l’umanità e l’onore siano morti, scomparsi, distrutti, sembra che il popolo tedesco sia degenerato, che in toto non abbia più onore né onestà. E invece non è così! Non è così, capisce? La forza del buon senso, dell’etica, della bontà del popolo in quanto tali vivranno in eterno, e il nazismo nulla potrà per distruggerle».
E senza attendere che Štrum replicasse, continuò:
«Lo stesso vale per le singole persone. Perché in ognuno di noi c’è un po’ di tutto; molto resta inutilizzato, nascosto, e molto abbiamo di sbagliato, rozzo e primitivo. Spesso chi vive in condizioni sociali normali nemmeno conosce i sotterranei e gli scantinati del suo stesso essere. Alla prima catastrofe sociale, però, le lordure affiorano e si piazzano nelle stanze ben rassettate dei piani superiori!».
Štrum volle dire la sua.
«Dmitrij Petrovič, lei sostiene che dentro di noi c’è un po’ di tutto. Peccato, però, che con la sua stessa esistenza lei smentisca l’assunto. In lei ogni cosa è pura e tersa, lei non ha scantinati o sotterranei. Certo, dei presenti di solito non si parla, ma per confutare la sua tesi non c’è bisogno di scomodare Giordano Bruno o Černyševskij: basta guardarsi intorno. No, non è così che si spiega quant’è accaduto in Germania! Lei sostiene che un manipolo di delinquenti con Hitler in testa ha fatto irruzione nella vita tedesca. Quante volte, però, nei momenti decisivi della sua storia, la Germania ha visto trionfare le forze reazionarie? Se non era un Friedrich era un Wilhelm Friedrich o un Wilhelm e basta. Dunque il punto non è il manipolo di scellerati con Hitler in testa; il punto sono i tratti salienti del militarismo prussiano, che sa sempre cavare dal cappello delinquenti e Überdelinquenti. Un comunista che conosco bene e che ora è commissario al fronte, Krymov, una volta mi ha citato una frase di Marx sul ruolo delle forze reazionarie nella storia della Germania. Mi si è impressa nella memoria: “Con i nostri pastori alla testa, in una sola occasione ci trovammo in compagnia della libertà: nel giorno in cui la seppellimmo”. Nell’epoca dell’imperialismo le forze reazionarie hanno generato un Übermostro, Hitler, e alle elezioni tredici milioni di tedeschi gli hanno detto sì».
«Oggi è esattamente così: in Germania Hitler ha vinto. Capisco la sua riflessione» disse Čepyžin. «Ma è comunque innegabile che la morale del popolo, la bontà del popolo sono indistruttibili e più forti di Hitler e della sua mannaia. Il nazismo sarà annientato e l’uomo resterà umano. Ovunque, e non solo nell’Europa occupata: persino in Germania. La morale del popolo! È questa la misura del lavoro libero, utile, creativo; la sua ragion d’essere è ribadire l’uguaglianza nel lavoro, l’onestà e la libertà, fondandosi sulla convinzione che lavoro, uguaglianza e libertà sono un diritto di tutti su questa terra. La morale del popolo è semplice: quello che è un mio diritto sacro deve essere necessariamente un diritto sacro per tutti. Per il nazismo e Hitler è vero l’esatto contrario, e con furia e brutalità inaudite: il mio diritto è tale perché di questo stesso diritto privo altre persone e altri popoli, se non il mondo intero».
L’incontro fra un uomo e una donna
Krymov si sentì addosso gli occhi di qualcuno che si avvicinava quatto quatto. La nuora. Senza rendersene conto, senza pensarci, probabilmente la stava aspettando. Non si meravigliò, quando se la ritrovò accanto. La donna si sedette sui gradini d’ingresso, si abbracciò le ginocchia e si mise a guardare l’incendio anche lei.
Rischiarati dai bagliori lontani, i suoi occhi brillavano; era davvero bellissima in quella luce tremolante, ora lugubre ora dolce. Anche lei doveva aver sentito, non con la mente né col cuore, ma con la pelle, le braccia, il collo, che lui respirava il suo odore, che le guardava la bella treccia che ricadeva sulle ginocchia, le braccia nude fino sopra il gomito, le gambe robuste. Ma non disse niente: sapeva che non c’erano parole per descrivere quello che stava nascendo fra di loro.
Quell’uomo alto con le spalle larghe, accigliato, con un’espressione di quieta angoscia negli occhi scuri, non aveva niente dei giovani autisti che per un po’ d’amore le portavano scatolette, benzina e miglio cotto.
Non era timida, e nemmeno vergognosa o remissiva. Lottava per la vita e lo faceva brutalmente, come un uomo: spaccava la legna, arava, ferrava i cavalli, riparava un tetto o le gambe di un tavolo; capitava spesso che a fare il lavoro da donna – zappare l’orto, pascolare la vacca, badare ai più piccoli – fossero vecchi e bambini, e che a lei toccasse quello duro, da uomini. E infatti spegneva gli incidenti, cacciava i briganti dal granaio, andava in città a consegnare il frumento e a parlare con le autorità militari perché pensassero a riparare il mulino o a macinare il grano. Sapeva fregare la gente, e, se qualcuno provava a fregare lei, reagiva fregando a sua volta. E non fregava da femmina annacquando il latte o spacciandolo per fresco anche se era del giorno prima, ma da uomo, ed era una truffa astuta e sfacciata, la sua, roba da teste fine.
Se si arrabbiava, non vomitava una raffica di ingiurie come fanno le donne, ma imprecava con ponderazione, era colorita.
In quei giorni di guerre e ritirate, tra la polvere e il rumore, alla luce degli incendi notturni e con il sottofondo di Heinkel e Junkers, le sembrava strano ripensare alla sua giovinezza timida, taciturna.
Quell’uomo ingrigito la guardava senza dire niente, sapeva di alcol e aveva occhi complicati, ma decisi…
Anche lui si sentiva meglio, con lei accanto. E ci sarebbe rimasto volentieri un bel po’, perfino un paio di giorni, accanto a quella giovane donna bellissima… La mattina sarebbe andato nell’orto, poi nel campo, e la sera, alla luce del lume a petrolio, si sarebbe messo al tavolo e l’avrebbe guardata mentre faceva il letto con le sue braccia forti scurite dal sole, e gli occhi incantevoli di quella donna avrebbero ricambiato il suo sguardo con fiducia, con affetto…
Lei si alzò senza dire niente e si incamminò sulla sabbia chiara. Era forte ed era bella, aveva le due cose insieme.
Lui la guardò allontanarsi, ma sapeva che sarebbe tornata. E infatti tornò e disse:
«Venga, cosa sta lì da solo? S’è radunata un po’ di gente in quella casa».
Ragione e sentimento
La sera del sabato, Štrum partì per la dacia. Sul treno pensò a quanto era accaduto nei giorni appena trascorsi. Era un peccato che Čepyžin se ne fosse andato.
Novikov, il colonnello che era passato da lui la sera prima, gli era piaciuto molto. Era contento di averlo conosciuto. Certo, meglio sarebbe stato conoscerlo una mezz’oretta dopo, così avrebbe potuto salutare Nina diversamente… Ma poco importava. Sarebbe ritornata il martedì seguente. E lui avrebbe di nuovo visto quella creatura splendida, giovane, adorabile.
Al pensiero di Nina si aggiungeva, altrettanto ostinato, quello per sua moglie. Se la immaginò sola e preoccupata per Tolja e ripensò ai tanti anni passati insieme.
Quando si pettinava i capelli la mattina, Ljudmila diceva sempre: «Si invecchia, Viktor caro». Dopo una brutta lite, invece, si presentava nel suo studio stizzita e con le lacrime agli occhi. «Lo sai,» diceva «sono talmente abituata ad averti accanto che mi piace guardarti anche mentre litighiamo e quando non ci sei mi manca qualcosa…».
Quanti legami, quanti successi, e ansie, e amarezze, e delusioni, e fatica avevano condiviso.
Gli erano sempre sembrati così semplici, i rapporti fra le persone, così chiari e per niente complicati. Era così sicuro, quando spiegava a Tolja e a Nadja le leggi che regolano i rapporti umani, e poi, invece, non riusciva a sbrogliare i suoi, di sentimenti. Credeva nella logica del pensiero, quello sì! Il suo lavoro in laboratorio andava a braccetto con la teoria dei libri e dei suoi studi; teoria e pratica solo di rado collidevano o segnavano il passo, stupite, e comunque alla fine facevano sempre la pace e riprendevano a camminare fianco a fianco, perché da sole nulla potevano: maratoneta infaticabile la pratica, ma con in spalla la teoria – le sue ali, il suo sguardo acuminato.
La sua vita privata, invece, era sottosopra: un cieco che guidava chi gli occhi li aveva, un uomo senza gambe che pretendeva di caricarsi in spalla il compagno di viaggio orbo e chiedeva a lui di indicargli la strada.
La logica lo confondeva e basta, perché era il sentimento a generarla, e non la ricerca della verità, dunque la logica era ormai menzogna, non cercava la verità e piuttosto si sforzava di difendere l’errore. O forse no, non difendeva l’errore, ma la volontà di chi la esercitava. Sentiva di avere diverse logiche, Štrum: la logica della pietà, la logica della passione, la logica del dovere, la logica della bontà e quella del desiderio egoistico.
Ripensò allo stupore e alla rabbia che gli aveva suscitato in passato una frase di Lutero: «La ragione è la prima puttana del diavolo». E si disse che per la prima volta non era la ragione a guidare i suoi gesti, a governare i suoi pensieri.
Dio mio, che voglia aveva di baciare quella ragazza! Come poteva evitarlo, però?
Gli accadeva una cosa strana: più la logica del dovere insisteva a portarlo dalla sua parte, più quella del desiderio egoistico lo aizzava contro Ljudmila.
Ripensava alle loro liti, ripensava al caratteraccio della moglie, alle cattiverie che era capace di dirgli, alla sua mancanza di logica quando litigavano, alla sua ostinazione invincibile, estrema, all’astio che immancabilmente mostrava verso i suoi parenti, alla freddezza nei confronti di sua madre, agli accessi di avarizia che aveva quando scacciava in malo modo i mendicanti che si accostavano allo steccato della dacia: «Via, via, sciò,» gridava «state lontani da casa mia, che la notte scorsa ai vicini hanno portato via l’amaca!».
Il lavoro di Štrum, però, lo venerava. O forse no? Una volta, sette anni prima, durante una lite lei gli aveva detto: «Sono quattro anni che porto la stessa pelliccia e Tolja è il peggio vestito di tutta la scuola. Non la dovresti rifiutare, una seconda cattedra, ce l’anno tutti quelli che conosciamo, perché pensano anche alla famiglia, loro, e non soltanto alla ricerca…».
Avevano accumulato molti torti, in quegli anni, e anche molti passi falsi, molte offese, molti pensieri mai detti. Provò a farne una lista come un pubblico ministero, così da preparare per bene l’atto di accusa. Perché era quello che voleva: accusarla di tutto.
E la accusò.
Nel profondo della coscienza sapeva che la logica di quelle accuse era sbagliata e di parte, menzognera e mendace. E vedeva che la menzogna, che aveva sempre detestato, non solo si era insinuata nei rapporti con amici e parenti, ma aveva intorpidito le acque di fonte della sua ragione.
Tuttavia, scendendo dalla banchina, si scoprì a domandarsi:
«Ma perché la menzogna deve essere il male? In che cosa è peggiore della verità?».
La steppa
Faceva buio. Quell’estate i tramonti della steppa erano particolarmente maestosi e sontuosi. Sulla steppa incombeva la polvere di milioni di piedi, ruote e cingolati, la polvere delle bombe che esplodevano, sospesa come un velo negli strati più alti e cristallini dell’aria insieme al respiro freddo dello spazio cosmico.
Rifratti da quella polvere sottilissima, i raggi della sera toccavano terra in mille colori.
È enorme, la steppa. E come il cielo e il mare prendono colore al tramonto, così la terra dura e riarsa della steppa, grigiastra e giallognola durante il giorno, la sera cambia colore.
È questo che la rende simile al mare. La sera la steppa diventa rosa, poi blu, poi di un nero violastro.
Strepitosi sono anche gli odori; il calore del sole scalda le essenze racchiuse nella linfa delle varie erbe, di fiori e cespugli, che si posano come una nube sul fresco della terra, senza impregnarla, ma librandosi su di essa in volute piccole e lente.
E allora la terra tiepida profuma di artemisia o di fieno che inizia a seccare, e da una conca arriva una zaffata intensa di miele. Inoltrandosi nella steppa, da un anfratto sale l’odore umido di erbe appena spuntate o quello già asciutto e polveroso della paglia arsa al sole; o ancora, all’improvviso, l’odore non è più d’erba né di fumo, e nemmeno di artemisia, cocomeri o foglie amare di marasco, ma della carne stessa della terra: è un respiro misterioso che racchiude in sé la leggerezza della polvere, la pesantezza degli strati immobili e fossilizzati del terreno, il freddo tagliente dei fiumi e ruscelli nelle sue viscere.
Di sera la steppa non si veste solo di colori e odori: canta, anche. I suoni nella steppa non arrivano distinti all’orecchio umano, né vanno ascoltati uno per uno. I suoni della steppa sfiorano l’orecchio e arrivano diritti al cuore, riempiendolo di pace e serenità, ma anche di tristezza e angoscia.
Sono il frinire stanco, titubante dei grilli che sembrano chiedersi se valga davvero la pena di produrli, quei suoni serali; sono le starne che si danno la voce prima che cali la notte, i cigolii lontani delle ruote, il frusciare soffuso dell’erba che sta per cedere al sonno, cullata da un venticello fresco, l’affaccendarsi frettoloso di topi e roditori, il grattare delle ali dei coleotteri… Però, accanto ai suoni smorzati della vita che si avvia al riposo ce ne sono anche altri: i gridi furfanteschi delle civette, il ronzio cupo delle falene, il fruscio delle lucertole di vetro, i suoni della caccia e dei cacciatori che escono da tane, buchi, crepe e avvallamenti nella terra secca. Su tutto, poi, incombe il cielo della sera, con la terra che ci si riflette o col cielo che si riflette sulla terra, o con la terra e il cielo che si riflettono a vicenda come due enormi specchi, arricchendosi l’una con l’altro grazie al miracolo del duello fra buio e luce.
MA COSA SONO LE «SCOR-DATE»? NOTA PER CHI CAPITASSE QUI SOLTANTO ADESSO.
Per «scor-data» qui in “bottega” si intende il rimando a una persona o a un evento che il pensiero dominante e l’ignoranza che l’accompagna deformano, rammentano “a rovescio” o cancellano; a volte i temi possono essere più leggeri ché ogni tanto sorridere non fa male, anzi. Ovviamente assai diversi gli stili e le scelte per raccontare; a volte post brevi e magari solo un titolo, una citazione, una foto, un disegno. Comunque un gran lavoro. E si può fare meglio, specie se il nostro “collettivo di lavoro” si allargherà. Vi sentite chiamate/i “in causa”? Proprio così, questo è un bando di arruolamento nel nostro disarmato esercituccio. Grazie in anticipo a chi collaborerà, commenterà, linkerà, correggerà i nostri errori sempre possibili, segnalerà qualcun/qualcosa … o anche solo ci leggerà.



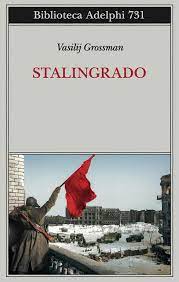
Lo sto leggendo, l’epopea di un popolo.
Naturalmente mi ha ricordato Guerra e pace, anche nello stile di scrittura
Avevo letto Vita e destino, ma mai avrei pensato che con Stalingrado avrei raggiunto lo stesso immenso tormentato piacere da lettore. Grazie Vasilij (e Giuseppe).