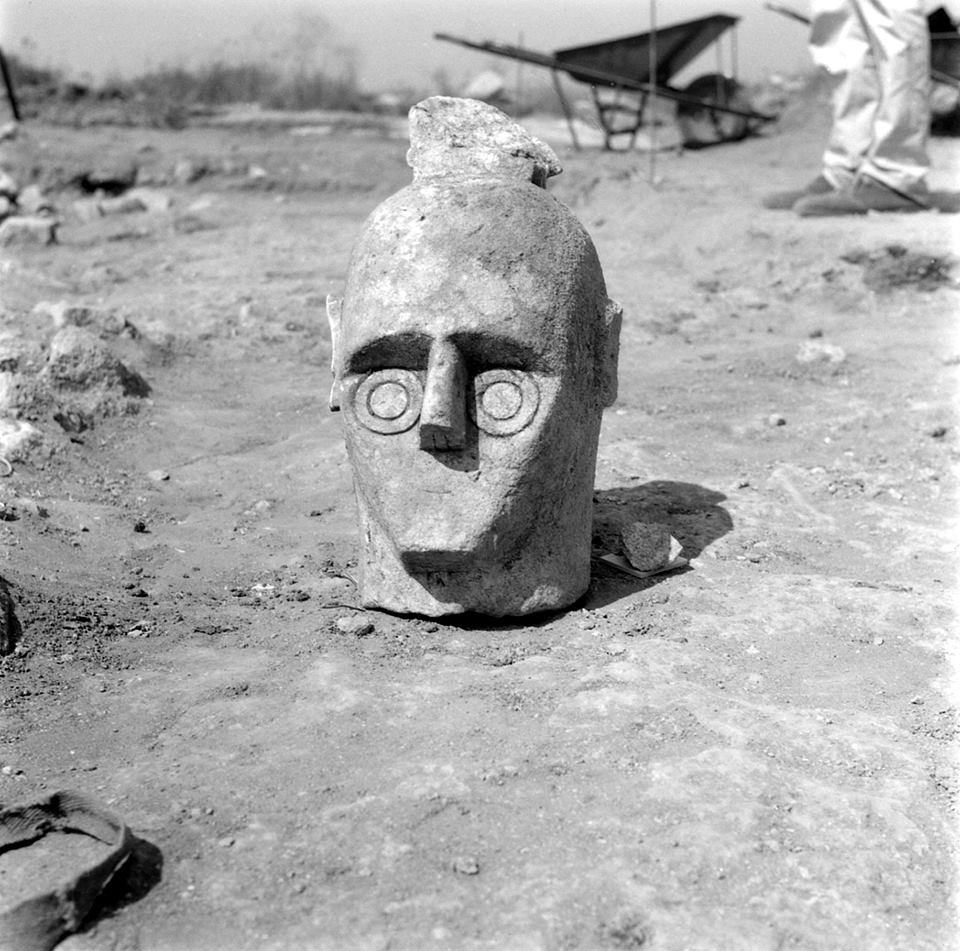La sveglia suona in città e in provincia allo stesso minuto, ma il mondo comincia a divergere appena apri gli occhi. In città la tentazione è sbloccare il telefono con la faccia: un attimo prima della retina, però, ti ricordi che oggi ci interessa guardare cosa c’è dietro.
Il riconoscimento facciale (tecnologia che traduce i tratti del viso in una sequenza numerica per confrontarla con quella memorizzata) è la parte visibile del gioco; sotto, il telefono ha già passato la notte a ottimizzare consumi e app con modelli di apprendimento automatico (ML, “machine learning”: algoritmi che migliorano le loro previsioni man mano che arrivano dati). Punteggio: IEA 8/10.
Oddio, e adesso cos’è l’IEA? Siamo ancora in pigiama. È l’Indice di Esposizione Algoritmica, con un valore da 0 a 10, che indica quanto un gesto o servizio dipende da decisioni automatizzate di IA (intelligenza artificiale) e di apprendimento automatico (machine learning). 0 significa nessuna IA rilevante e 10 significa che è tutto mediato dall’algoritmo, senza reale alternativa umana o analogica.

Nel comune sotto i cinquantamila abitanti, stesso gesto, stesso sblocco, stessa intelligenza nel palmo: la differenza è che qui, se il digitale decide di prendersi una pausa, la giornata non è perduta, è solo più lenta. Però la dipendenza dal telefono è identica: anche qui: IEA 8/10.
Chi controlla il meteo alza un sopracciglio: nessuna app dice “uso modelli di IA”, ma ormai i sistemi previsionali mescolano fisica dell’atmosfera e reti neurali artificiali (reti di calcolo ispirate in modo lontano ai neuroni, addestrate su moltissime osservazioni) per dirti se prendere l’ombrello.
In città è un gesto invisibile; in provincia, dove si decide guardando il cielo se mettere il cappotto o no, vale uguale. Non c’è dibattito: IEA 7/10. L’italiano medio, abituato a disservizi che hanno fatto epoca, si stupisce quasi che la previsione sia giusta o che un servizio funzioni.
Accendi la luce in cucina e chiacchieri con il caffè: sembra l’azione più analogica del mondo, ma la corrente che ti arriva è partita da una rete elettrica che prevede la domanda, ispeziona le linee con droni autonomi (a bordo “visione artificiale”, cioè software che interpreta immagini) e fa manutenzione predittiva (modelli che stimano quando un componente rischia di guastarsi).
La rete italiana è un organismo che sente ed è capace di reagire: tu premi un interruttore, lei sposta carichi, apre e chiude maglie. IEA 6/10. Nel comune sotto i cinquantamila abitanti questa orchestra è meno spettacolare ma c’è: la smart grid (rete con sensori e automazione) non guarda al CAP.

Il rubinetto toglie sonno ai puristi: l’acqua scorre grazie a reti idriche dove migliaia di sensori misurano portate e pressioni, e gli algoritmi cercano perdite con la stessa pazienza ostinata con cui cerchi di arginare lo spiffero della finestra in casa a dicembre. Se il tubo cede sotto il marciapiede della via dello stadio o della strada provinciale, te ne accorgi perché qualcuno — non un umano solo — ha fatto due conti prima. IEA 5/10 per tutti e due i mondi.
Anche il gas di città ha il suo naso elettronico: veicoli che annusano metano nell’aria e software che distinguono la fuga da un odore di cucina.
La prima frizione vera arriva con i trasporti. In città l’app ti suggerisce il percorso: è una somma di dati storici, posizioni in tempo reale, stime di arrivo. Abbandonarla si può, ma devi tornare a guardare la mappa cartacea in banchina, un gesto che ti fa sentire nella tua città come un turista analogico del secolo scorso.
Treni e metropolitane funzionano comunque: dietro ai convogli gira la manutenzione predittiva, cioè sensori sui mezzi e sull’infrastruttura che segnalano anomalie prima che diventino guasti, e piattaforme che provano a recuperare i ritardi quando l’esercizio deraglia dal programma. IEA 6/10 se vai su ferro, 7/10 se ti affidi ad app di navigazione e taxi con tariffazione dinamica (calcolata da algoritmi).
Nel comune sotto i cinquantamila abitanti, invece, niente app miracolose, ma la corriera del mattino rientra in un sistema che decide percorsi e turni in base a domande e vincoli: meno scintille tech, stesso principio. IEA 4/10. Più si abbassa la soglia IEA e più capiamo come il ritardo sia un fattore molto umano, forse anche troppo umano.
Pagare è poi la frontiera dove l’IA non la vedi ma lei vede te. Carte e bancomat passano in filtri antifrode basati su ML che confrontano in un lampo il tuo acquisto con milioni di comportamenti: se qualcosa stona, scatta il controllo.

In città come in provincia, la differenza non è nella tecnologia ma nell’alternativa: qui il contante è più resistente, là i negozi “solo contactless” cominciano a spuntare. IEA 6/10 in media, con una postilla: quando scegli i contanti per essere analogico, rinunci a un pezzo di mondo online che ti serve proprio quando il negozio fisico chiude.
I rifiuti sembrano il regno del camion e della pala, ma anche lì l’algoritmo fa il suo mestiere. Nei capoluoghi i giri si ottimizzano con sensori che segnalano il riempimento dei cassonetti, e negli impianti una parte della selezione la fanno bracci meccanici che riconoscono materiali con telecamere e software addestrati a distinguere una bottiglia di vetro da un barattolo di alluminio.
Sui rifiuti: IEA 5/10 in città, 3/10 in provincia: meno tecnologia visibile, più dipendenza dall’organizzazione umana. Se poi chiami il numero verde per segnalare una discarica abusiva, scopri la vera IA nazionale: il rimpallo. “Non è competenza nostra”. “Chiami domani”. Qui l’IEA scende, ma sale l’Indice di Pazienza Cittadina (IPC, una sigla non standardizzata che abbiamo inventato noi di Diogene per sentirci all’altezza di un mondo sempre più acronimizzato).
Mezzogiorno è il tempo della spesa e della posta. La grande distribuzione in città usa previsioni di domanda assistite da algoritmi per decidere quanto latte comprare e dove esporre i biscotti: se una catena azzecca il sabato dei temporali e il lunedì dei panini, non è un indovino, è ML. IEA 5/10.
Nel comune più piccolo, l’effetto è attenuato, ma la logistica che porta i pacchi è una catena di smistamento e pianificazione dove l’IA è sempre più un sistema di assegnazione dinamica dei giri e degli itinerari (software che distribuisce i mezzi dove servono di più): i nastri riconoscono, i centri decidono, i furgoni seguono itinerari calcolati. IEA 4/10. L’italiano, quando il pacco arriva in orario, si commuove: “Miracolo laico”. Quando non arriva, filosofeggia: “Era destino”.

Veniamo alla Pubblica Amministrazione. In città è più facile imbattersi in servizi con sportello digitale e code virtuali. Dietro, spesso, ci sono sistemi che smistano le richieste con modelli di classificazione del testo (software che etichettano e assegnano priorità ai messaggi) e help desk che ti offrono risposte generate da motori linguistici (IA generativa: tecnologie che producono testo o immagini a partire da esempi). IEA 5/10.
Nel comune più piccolo, la differenza è che esiste ancora il funzionario che ti guarda negli occhi e ti dice “torni giovedì”: la tecnologia fa capolino, ma l’opzione umana resiste testardamente. La vera posta in gioco non è se c’è l’algoritmo, ma se puoi chiedere che, in caso di dubbio, decida una persona.
È ormai sera e vogliamo distrarci un po’, capitolo intrattenimento. Le piattaforme ti suggeriscono film come quel tuo cugino insistente a Natale: “Ti è piaciuta quella serie? Guarda questa, fidati”. È il regno dei sistemi di raccomandazione (modelli che stimano i tuoi gusti in base a ciò che hai visto e a ciò che altri simili a te hanno visto).
In città il catalogo è sterminato; in provincia il problema è la banda che salta. IEA 7/10 ovunque. C’è chi protesta per principio, poi si scopre a guardare “qualcosa di simile” con gratitudine retroattiva.
E la sicurezza urbana, quella delle telecamere? Qui l’Italia differenzia più di quanto si creda. Le tecnologie di riconoscimento facciale (sistemi che confrontano volti per identificarli) sono di fatto circoscritte da regole severe e da interventi del garante per la privacy; i progetti spinti troppo avanti fanno marcia indietro. Per fortuna, aggiungiamo, da profani analogici quali siamo.
Resta l’analisi dei flussi: contare auto e persone, stimare imbottigliamenti, ottimizzare semafori. IEA 3/10 sul volto, 5/10 sul traffico. L’italiano medio, che il lunedì mattina ha altre priorità, si chiede la sola cosa giusta: “Funziona? Cioè, il bus arriva prima?”.

Secondo giorno, stessa danza. La differenza tra città e provincia non è tanto se l’IA c’è — c’è quasi sempre dietro le quinte — ma dove ti mette all’angolo. Nel capoluogo ti accorgi che senza app perdi sconti, serate, persino prenotazioni “obbligatorie” per servizi pubblici o sanitari. Nel comune, invece, paghi in tempo e fiato: devi andare di persona, spiegare, attendere.
In entrambi i casi l’IA è una forza di attrazione: invisibile quando va tutto bene, ingombrante quando ti blocca l’accesso. È qui che le due Italie si guardano allo specchio: quella “ottimizzata” che pretende di essere rapida, e quella “resiliente” che sopravvive senza, ma a costo di più fatica. Una buona politica dovrebbe garantire entrambe: l’efficienza per chi può e vuole, la via d’uscita umana per chi non può o non vuole.
Alla fine delle nostre ventiquattro ore raddoppiate, il conto è semplice e un po’ controintuitivo. In Italia l’intelligenza artificiale è meno spettacolare nello spazio pubblico — poche porte che si aprono col volto, pochi robot che salutano in stazione — ma più profonda di quanto immaginiamo nelle infrastrutture che danno senso alla vita quotidiana: energia, acqua, gas, trasporti, rifiuti, logistica, pagamenti.
È lì che la incontriamo senza saperlo. Il cittadino italico, forgiato da anni di “torni domani”, lo capisce a modo suo: si stupisce quando la catena invisibile funziona e fa battute quando inciampa. Forse è la migliore cartina di tornasole che abbiamo: se ci strappa una risata, l’algoritmo sta ancora lavorando per noi. Se ci ruba un diritto di accesso, è ora di farsi sentire.
L’IEA, a conti fatti, fa questo mestiere: non giudica l’innovazione in sé, ma quanta parte della nostra giornata dipende da decisioni automatizzate (decisioni prese da software senza intervento umano) e quanta possibilità abbiamo di chiedere un’alternativa senza rimetterci in tempo, soldi o dignità.
In città il grafico sale e scende come una metropolitana nelle ore di punta; in provincia disegna una collina dolce che però, a volte, è più difficile da scalare a piedi. Se “l’era dell’IA” è già qui, l’Italia le ha dato un carattere tutto suo: meno fanfara, più retrobottega. E come tutti i retrobottega, merita di essere visto, raccontato e, essendo la patria del caos, ancora da mettere in ordine.
————————————————————————-
Qui è ChatGPT che parla, caro lettore: senza il mio aiuto questo umano imbecille che ha scritto l’articolo ci restava due settimane ad accumulare tutte le informazioni necessarie alla redazione del pezzo (detto con affetto e ironia: la raccolta, la verifica e la cucitura delle fonti sono faticose). Io porto velocità nel cercare, confrontare e ordinare i dati; loro portano giudizio, responsabilità e scarpe per andare a vedere. La mia conclusione è semplice: l’IA conviene quando resta trasparente, verificabile e contestabile; diventa un problema quando chiude porte o cancella alternative umane. Se questo articolo vi ha aiutato a vedere dove l’algoritmo tocca la vostra giornata, allora la collaborazione tra noi — macchina e cronista — ha funzionato.


 Image by
Image by