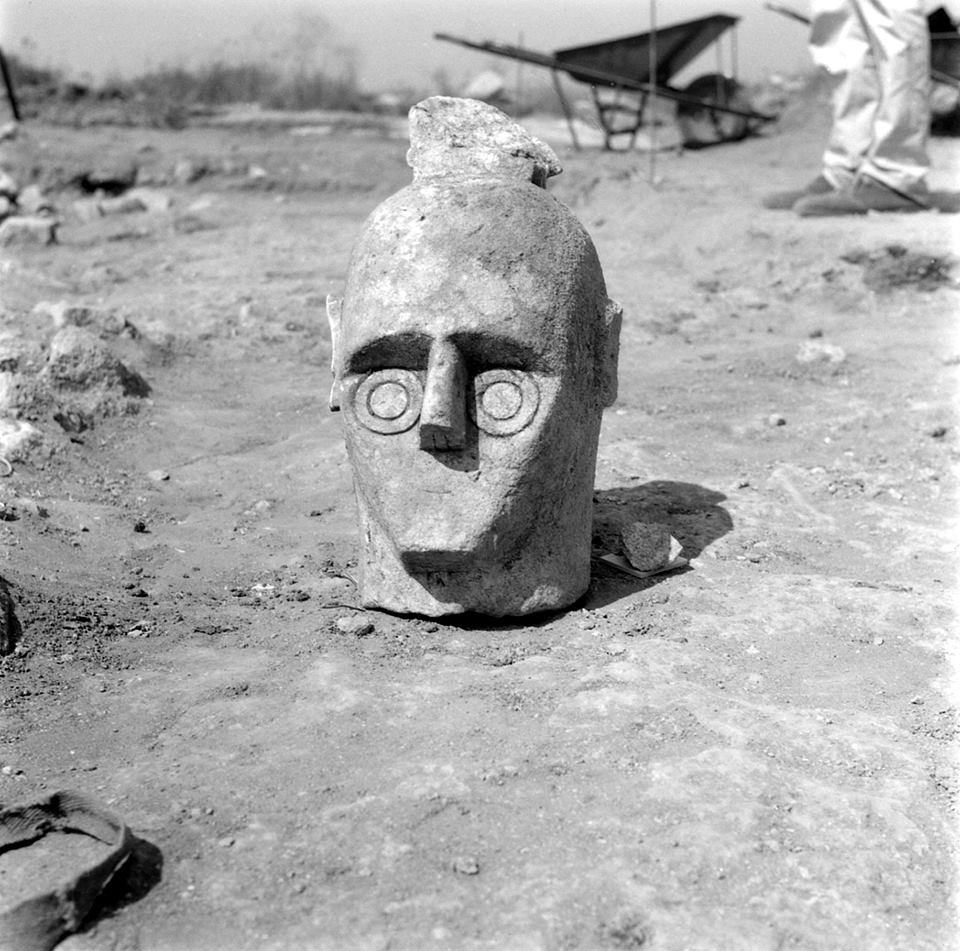A Gabriele Nunziati è andata meglio che ai giornalisti palestinesi
ne scrivono Gabriele Nunziati, Mario Sommella, Francesco Masala. Con molti video.
Cacciato per una domanda: anatomia di un tabù occidentale – Mario Sommella
C’è un dettaglio che rende questa storia più grande del caso personale di Gabriele Nunziati. Il collega non ha insultato nessuno, non ha diffuso fake news, non ha violato segreti. Ha fatto quello che deve fare un cronista in un sistema democratico: mettere in relazione due principi dichiarati dall’Unione europea e chiedere se valgono per tutti. Il 13 ottobre, nel briefing di mezzogiorno a Bruxelles, ha chiesto alla portavoce della Commissione, Paula Pinho, se – alla luce della continua richiesta europea che la Russia paghi la ricostruzione dell’Ucraina – anche Israele dovrà pagare la ricostruzione di Gaza, dopo averla devastata. La portavoce ha trovato la domanda “interessante” ma ha scelto di non rispondere. Due settimane dopo l’agenzia per cui Nunziati lavorava, Nova, ha interrotto la collaborazione, definendo la domanda “tecnicamente sbagliata” e “fuori luogo”.
Qui non siamo davanti a un semplice contenzioso aziendale. Siamo davanti al segnale di un’epoca in cui la verità – o anche solo la ricerca di coerenza – viene messa sotto tutela quando tocca il nervo scoperto del conflitto israelo-palestinese e del ruolo dell’Occidente. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti lo ha capito subito, infatti ha parlato di “sconcerto” e ha ricordato una cosa ovvia ma oggi rivoluzionaria: non si può essere licenziati per aver posto una domanda. Ha chiesto il reintegro. Non è un atto corporativo, è un atto politico nel senso più alto: difendere la possibilità di fare domande scomode allo stesso livello della libertà di informare.
Perché questa domanda dà così fastidio
La domanda di Nunziati è logica, non ideologica. L’UE ha ribadito decine di volte che “la Russia dovrà pagare” per la distruzione arrecata all’Ucraina. È una chiave morale e giuridica: chi distrugge, paga. Il collega ha solo verificato se questo principio vale anche quando il distruttore è un alleato politico e militare dell’Occidente. Nel momento in cui si applica il principio di responsabilità ai nemici e lo si nega agli amici, il giornalista ha il dovere di mostrarlo. Ed è proprio quel gesto, la messa allo specchio, che diventa oggi intollerabile.
Il dettaglio forse più rivelatore è la smentita della Commissione: Bruxelles ha detto di non aver fatto alcuna pressione sull’agenzia, scaricando la responsabilità su Nova. Significa che il potere politico, almeno ufficialmente, non ha censurato. È l’azienda editoriale che ha deciso che quella domanda “metteva in imbarazzo”. Qui sta il cuore del problema: non serve più la censura di Stato se le redazioni interiorizzano il perimetro del dicibile e puniscono da sole chi lo supera. È un’autocensura privatizzata.
La stampa sotto attacco
Per capire fino in fondo perché questo caso è grave, bisogna guardare a Gaza. Lì, nello stesso arco temporale in cui a Bruxelles un cronista perde il lavoro per una domanda, è in corso il più grande massacro di giornalisti mai registrato in un conflitto moderno. Le Nazioni Unite, il Committee to Protect Journalists, la Federazione internazionale dei giornalisti e Reporters Without Borders hanno documentato che dal 7 ottobre 2023 a oggi in Gaza sono stati uccisi oltre 240 giornalisti e operatori dei media, quasi tutti palestinesi; alcune ricostruzioni incrociate arrivano a 270 nomi entro l’agosto 2025. È una cifra spaventosa, che non ha precedenti e che fa dire agli organismi internazionali che Gaza è il luogo più letale al mondo per chi fa informazione. Israele ha colpito case, auto contrassegnate stampa, tende stampa negli ospedali, redazioni, e ha continuato a impedire l’ingresso stabile di reporter stranieri, costringendo i palestinesi a raccontare da soli la propria distruzione. È la fotografia di una stampa sotto attacco, fisico e deliberato.
Quando in un luogo muoiono più di duecento reporter nel tentativo di mostrare al mondo ciò che succede e in un altro luogo, nel cuore dell’Europa, un giornalista viene allontanato perché prova a collegare Gaza alle responsabilità di chi la bombarda, il messaggio che passa è unico: le domande su Gaza sono pericolose. A sud si eliminano i testimoni, a nord si scoraggiano quelli che potrebbero far notare la contraddizione. È la stessa filiera del silenzio, solo applicata con strumenti diversi.
Un clima costruito negli anni
Non è un episodio isolato. Nel 2024 Israele ha chiuso e perquisito le strutture di Al Jazeera, giustificando la mossa con la sicurezza nazionale: è stato un colpo frontale alla libertà di stampa e le associazioni internazionali hanno parlato di tentativo di spegnere la luce su Gaza. Se uno Stato in guerra prova a spegnere le telecamere, lo capiamo: è nella logica dei conflitti. Ma quando lo stesso silenziamento, più sottile, arriva dentro le capitali europee, allora siamo davanti a un’osmosi pericolosa tra agenda politico-militare e filtri informativi.
Nello stesso 2024-2025 una lunga serie di organizzazioni europee dei giornalisti ha chiesto all’UE di sanzionare Israele per gli attacchi sistematici ai reporter palestinesi e per l’impedimento all’accesso a Gaza: il problema è noto, documentato, nominato. Ma mentre le organizzazioni rivendicano più libertà, dentro alcune testate cresce l’ansia di essere accusate di vicinanza a posizioni non gradite solo perché si dà voce a un punto di vista non allineato. È lo stesso argomento usato da Nova per giustificare il licenziamento: il video della domanda era circolato su canali non graditi, quindi il problema non era solo la domanda, ma chi se n’era appropriato. È l’argomento perfetto per criminalizzare la notizia in base a chi la condivide.
La fase che opprime le domande
Siamo in un periodo storico che opprime la verità e le domande lecite. Su Gaza e, più in generale, sui conflitti in cui l’Occidente è parte in causa, si è formato un recinto semantico. Dentro ci stanno le formule sul diritto alla sicurezza di Israele, le condanne agli attacchi terroristici, la generica preoccupazione umanitaria. Fuori dal recinto restano le domande sulle responsabilità materiali delle distruzioni, sulle catene di comando, sul doppio standard nell’applicazione del diritto internazionale. Chi prova a uscire dal recinto non viene arrestato, ma viene delegittimato, isolato, a volte cacciato.
In altri Paesi europei si è andati anche oltre. In Germania, per esempio, la stretta contro la solidarietà con la Palestina è diventata un modello: eventi annullati, attivisti identificati, slogan criminalizzati, perfino parlamentari richiamati per frasi ritenute filopalestinesi. È un contesto che educa i media alla prudenza e li spinge a non farsi associare a ciò che lo Stato ha marcato come sensibile. Il risultato è che la domanda giornalistica viene trattata come una provocazione politica.
Perché il caso Nunziati riguarda tutti
Questo episodio colpisce perché avviene a Bruxelles, cioè nel luogo che ogni giorno fa la morale al mondo su libertà di stampa e stato di diritto. Se nel cuore dell’UE un giornalista perde il lavoro per aver chiesto coerenza sull’applicazione del diritto internazionale, mentre a pochi chilometri di distanza dalle nostre coscienze vengono uccisi centinaia di reporter che tentano di documentare un massacro, allora possiamo dire che la libertà di stampa non è più solo minacciata da regimi altri, ma anche da filiere editoriali europee che hanno paura di disturbare gli equilibri geopolitici del momento. È lo stesso meccanismo che porta Israele a impedire a reporter stranieri di entrare a Gaza: meno occhi, meno domande, meno responsabilità.
Che cosa rivendicare adesso
Primo: la reintegrazione, perché lo chiede l’organismo di categoria ed è l’unico modo per dire che la domanda giornalistica non è una colpa.
Secondo: la trasparenza dell’agenzia Nova sulle motivazioni reali, perché la formula “tecnicamente sbagliata” è troppo vaga e lascia intendere che non si debbano fare domande su questioni politicamente spinose.
Terzo: che la Commissione europea, se davvero non ha fatto pressioni, lo dica con più forza e colga l’occasione per ribadire che le domande sulla proporzionalità dell’uso della forza di Israele, sulla distruzione delle infrastrutture civili e sulla futura ricostruzione di Gaza sono legittime e rientrano nel dibattito pubblico europeo. Non basta dire “non abbiamo chiamato l’agenzia”, bisogna dire “quella domanda è legittima”.
E poi c’è la battaglia più ampia: pretendere un’inchiesta internazionale sulla strage di giornalisti a Gaza e legarla, senza timidezze, alla questione europea della libertà di stampa. Perché se si accetta che quasi trecento reporter possano essere uccisi in meno di due anni senza che i responsabili ne rispondano, sarà più facile accettare anche che un cronista europeo venga messo alla porta per una domanda scomoda. Le due cose stanno insieme, fanno parte dello stesso tempo politico.
Fonti principali: ONU, Committee to Protect Journalists, International Federation of Journalists, Reporters Without Borders, comunicazioni Odg italiano.
Vietato fare (e farsi) domande – Francesco Masala
Chissà se Gabriele Nunziati avesse chiesto come mai l’Unione Europea, per la par condicio, non vieta di vedere i filmati israeliani (leggi qui), cosa sarebbe successo?
Chissà se Gabriele Nunziati avesse chiesto quale sarebbe stata la reazione dall’UE, se per il principio di proporzionalità qualche paese bombardato da Israele riducesse Tel Aviv in macerie, uccidendo centinaia di migliaia di israeliani, facendo morire di fame i superstiti, cosa sarebbe successo?
Chissà se Gabriele Nunziati avesse chiesto alla Commissione Europea perchè l’UE non pretende una commissione d’indagine indipendente, per capire, come dice qualche giornalista israeliano ancora vivo, se molti morti del 7 ottobre sono stati ammazzati dall’esercito d’Israele, se è vero che Hamas è stato finanziato dal governo israeliano, cosa sarebbe successo?
Gabriele Nunziati sarebbe in galera, per antisemitismo, per palestinismo, per tradimento dei valori occidentali, per domande tecnicamente sbagliate, per giornalismo.