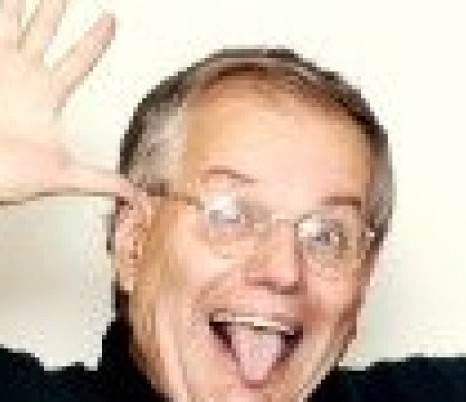Astronomia-Fs 5: tra catastrofi e possibilità
Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta (*)
COUNTDOWN VERSO APRILE 2026, IL CENTENARIO DELLA FANTASCIENZA – siamo a meno 6
A seguire una noticina della “bottega” su N. K. Jemisin
La Quinta Stagione: un mondo tra fantascienza e geologia planetaria ?
E se i processi tettonici fossero un ingrediente fondamentale per il worldbuilding?
“Ecco una terra.
È una terra ordinaria come tutte le terre. Montagne e altopiani, canyon e foci di fiumi: le solite cose. Usuale in tutto, tranne che per dimensioni e dinamismo. Si muove molto, questa terra. Come un vecchio che giace irrequieto nel letto, si solleva e sospira, si contrae e scoreggia, sbadiglia e deglutisce. Allora, gli abitanti di questo continente l’hanno chiamato l’Immoto. È una terra di pacata, amara ironia.
L’Immoto ha avuto altri nomi. Un tempo c’erano molte terre. Ora è un unico continente ininterrotto, ma in un imprecisato futuro tornerà a essere diviso.
Molto presto, in realtà.”
N. K. Jemisin è il modo in cui la scrittrice statunitense Nora Keita Jemisin firma le proprie opere. Tra il 2016 e il 2018 è entrata di diritto nel pantheon della narrativa fantastica grazie alla vittoria di ben tre premi Hugo consecutivi, uno per ciascuno dei romanzi della trilogia chiamata La terra spezzata (Broken Earth), cominciata con La Quinta Stagione (The Fifth Season) e continuata poi con Il portale degli obelischi(The Obelisk Gate) e Il cielo di pietra (The Stone Sky). Mai nessuno prima aveva ricevuto per tre volte di seguito il massimo riconoscimento assegnato da lettrici e lettori di fantascienza nella categoria del migliore romanzo, per di più con opere di una stessa trilogia. Si tratta di un successo davvero storico, perché Jemisin è stata anche la prima autrice afro-americana in assoluto a ottenere un Hugo per un romanzo.
La storia de La Quinta Stagione si svolge su un pianeta con un unico supercontinente, Immoto (Stillness), che ricorda la Pangea terrestre di circa 250 milioni di anni fa. Immoto è sconvolto da intensi terremoti e devastanti eruzioni vulcaniche, con il risultato che, con cadenza plurisecolare, va incontro alla cosiddetta Quinta Stagione, ovvero una catastrofica crisi climatica e ambientale. Che sia scatenata dalla cenere vulcanica che blocca la luce solare, dalla fioritura di alghe tossiche, dalle faglie tettoniche che possono fratturare il continente, senza trascurare l’inquinamento dell’industria mineraria che cerca di trarre vantaggio dalla situazione, gli abitanti del pianeta hanno una sola certezza: prima o poi, la Quinta Stagione arriverà. Di conseguenza, la loro cultura e la loro struttura sociale si sviluppano attorno all’imperativo di giungere preparati al momento cruciale. Fin dall’infanzia, a ogni persona viene assegnato un ruolo ben preciso finalizzato alla sopravvivenza della comunità, come procurarsi cibo e mettere al sicuro le scorte; chi non accetta queste rigide imposizioni è esiliato, abbandonato al proprio destino.
Esistono però delle persone, gli orogeni, che possiedono la misteriosa capacità di influire sui fenomeni geologici. Gli orogeni sono temuti e disprezzati perché diversi; alcuni sono imprigionati e costretti a utilizzare il loro potere per favorire i ricchi e i governanti. Come scrisse nel 2016 sul quotidiano The New York Times Annalee Newitz, saggista e autrice a sua volta di opere di fantascienza, questo scenario “dovrebbe risultare familiare a qualsiasi abitante della Terra che segue l’attualità, intessuta com’è dalle crescenti minacce ambientali e dall’oppressione delle minoranze”.
A sinistra, l’illustrazione di copertina della prima edizione italiana di La Quinta Stagione di N. K. Jemisin, pubblicata nel 2019, è un progetto grafico originale di Lauren Panepinto. Fonte: https://www.oscarmondadori.it/libri/la-quinta-stagione-la-terra-spezzata-libro-1-n-k-jemisin/
A destra, ritratto dell’autrice N. K. Jemisin. Credit: MacArthur Foundation/CC BY-NC 4.0. Fonte: https://news.cornell.edu/stories/2023/09/n-k-jemisin-speak-imagining-better-future
Newitz sottolinea inoltre come La Quinta Stagione dia spazio a discipline scientifiche spesso marginalizzate nella letteratura speculativa, come geofisica e planetologia: benché trasfigurate in un’opera al confine tra fantascienza e fantasy, esse diventano protagoniste della narrazione, assumendo un ruolo di grande rilievo. Non è possibile scindere le vicende e i caratteri dei personaggi dall’ambiente in cui si trovano e che ne ha plasmato la psiche. Analogamente, per comprendere le proprietà e i comportamenti dei corpi celesti del Sistema Solare, come i pianeti rocciosi, le lune ghiacciate dei pianeti giganti, gli asteroidi e le comete, è necessario decifrare i processi fisico-chimici che avvengono al loro interno e sulla loro superficie.
Proprio di questo si occupano i planetologi Alice Lucchetti e Maurizio Pajola, personalità di spicco nell’ambito della geologia planetaria. Entrambi formatisi in Astronomia a Padova e oggi ricercatori dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) nella stessa città, Lucchetti e Pajola offrono due prospettive complementari e dettagliate sui pianeti e i corpi minori del Sistema solare.
Durante il suo dottorato in scienze e tecnologie spaziali, Lucchetti si è dedicata alla caratterizzazione dei satelliti ghiacciati di Giove, soprattutto Callisto, Europa e Ganimede; inoltre ha collaborato alla missione Rosetta dell’agenzia spaziale europea ESA, esaminando le immagini dall’orbiter e dal lander Philae della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Al momento è coinvolta in missioni ESA come JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), DART (Double Asteroid Redirection Test), LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids) e HERA (dal nome della dea greca Era), per le quali svolge l’analisi dei dati provenienti da camere e spettrometri. Il lavoro di ricerca di Pajola, dottore in astronautica e scienze da satellite, si incentra invece su Marte, con particolare attenzione alla geomorfologia e alla selezione dei siti di atterraggio per le missioni spaziali, e anche sulla valutazione della distribuzione dei massi su comete come la già ricordata 67P e 103P/Hartley 2, nonché sul monitoraggio e la determinazione della composizione degli asteroidi.
“Lo studio delle superfici planetarie”, spiega Lucchetti, “si fonda sulla raccolta di immagini multifiltro e sulla spettrometria: si tratta di un approccio combinato, che estende la finestra di osservazione dal visibile all’infrarosso, permettendo di investigare aspetti sia geomorfologici sia composizionali”. Le immagini sono un utile strumento diagnostico per riconoscere fratture, frane, crateri d’impatto, strutture vulcaniche e depositi di ghiaccio o polvere. Confrontando le stesse aree tramite immagini prese in tempi diversi è possibile rilevare cambiamenti superficiali, ricavando così informazioni preziose sui processi in atto.
Maurizio Pajola, a sinistra, e Alice Lucchetti, a destra, ricercatore e ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova. Credit: INAF. Fonte: https://www.media.inaf.it/2024/07/30/dart-analisi-massi/
Per esempio, il conteggio dei crateri costituisce il metodo principale per stimare l’età relativa di una superficie: croste molto craterizzate, come quella di Callisto, riflettono una lunga esposizione agli impatti, motivo per cui si attribuisce loro un’età avanzata; mentre quelle con la presenza di meno crateri, come nel caso di Europa, vengono ritenute geologicamente più giovani, a causa di modifiche della superficie (resurfacing) successive agli impatti. Inoltre, nei satelliti ghiacciati la morfologia dei crateri (a scodella, con anelli di picchi, con duomi o picchi centrali) è collegata alla stratigrafia sottocrostale; nello specifico, strati ghiacciati o porosi appena sotto la superficie possono essere l’esito di processi di diapirismo e/o di criovulcanismo, che provocano la risalita di materiale liquido e ghiacciato dal sottosuolo. Le fratture, tensionali (come quelle di Ganimede) o compressive (come quelle di Mercurio), registrano poi la storia deformativa dell’oggetto considerato, di modo che la prevalenza dell’una o dell’altra tipologia aiuta a ricostruire i movimenti tettonici passati. Le frane, infine, non solo testimoniano l’instabilità superficiale rispetto all’azione di forze esogene, ma forniscono anche indizi sulla composizione interna: frane che raggiungono distanze maggiori dal fronte di distaccamento possono essere spinte da materiali volatili presenti nel sottosuolo.
“Tra i satelliti ghiacciati”, continua Lucchetti, “il caso più emblematico è indubbiamente quello di Encelado, una delle lune di Saturno. Le osservazioni della sonda Cassini hanno infatti mostrato una superficie ricoperta da uno spesso guscio di ghiaccio che si assottiglia verso il polo sud, dove quattro fratture principali, le tiger stripes (“strisce di tigre”, come quelle del manto del grande felino asiatico), emettono ciclicamente getti di vapore d’acqua, polvere e particelle di ghiaccio. Questi pennacchi, chiamati plumes, sono simili ai geyser terrestri e derivano dalle pressioni interne dell’oceano salino sotterraneo, riscaldato e mantenuto liquido dall’azione mareale di Saturno. Al contrario, il polo nord appare molto più statico, in quanto segnato da crateri, ma privo di fratture”.
“Anche l’ambiente di Marte”, aggiunge Pajola, “è estremamente complesso. La sua storia idrologica evidenzia come, nel corso dell’era Noachiana (quella più antica, datata a circa quattro miliardi di anni fa), il pianeta ospitasse un ciclo dell’acqua attivo con fiumi, laghi e possibili bacini oceanici; le foci a delta e le reti fluviali ramificate tuttora visibili sono tracce del processo di run-off (movimento superficiale di masse d’acqua liquida), innescato dall’erosione delle montagne da cui nascevano gli alvei. La progressiva scomparsa dell’acqua ha dato luogo a veri e propri cataclismi, come il rilascio improvviso di grandi volumi d’acqua da bacini sotterranei o ghiaccio intrappolato e la formazione di giganteschi outflow channels, ovvero canali di deflusso il cui scorrere verso settentrione è stato favorito dalla dicotomia crostale tra i due emisferi marziani, quello sud elevato rispetto a quello nord depresso”.
La successiva perdita del campo magnetico planetario ha reso Marte più vulnerabile al bombardamento da parte delle particelle cariche del vento solare: l’idrogeno, più volatile, è stato velocemente disperso nello spazio, mentre l’ossigeno si è legato alle rocce, arricchendole di ossidi di ferro e conferendo al pianeta la sua tipica tonalità rossa. L’atmosfera marziana residua, composta per circa il 95% da anidride carbonica e avente una densità nettamente inferiore a quella terrestre, rende critiche le condizioni aerodinamiche dei sistemi di atterraggio, causando notevoli difficoltà pratiche per l’esplorazione. A ciò si sommano i venti e le periodiche tempeste globali, che possono avvolgere l’intero pianeta per settimane o mesi, sollevando enormi quantità di polvere. D’altro canto, i dust devils, vortici locali di polvere, rappresentano un fenomeno ambivalente: pur essendo generalmente pericolosi per i rover, hanno talvolta provveduto a ripulirne i pannelli solari, incrementandone pertanto l’efficienza energetica. “Per tutte queste ragioni”, conclude Pajola, “i siti di atterraggio sono scelti con estrema cautela, evitando zone di transizione tra terre alte e bacini bassi, e regioni soggette a frane o a forti venti”.
Le superfici di Encelado, satellite di Saturno (a sinistra), il pianeta Marte (al centro), l’asteroide Bennu (a destra), studiate tra gli altri da Alice Lucchetti e Maurizio Pajola. Encelado – Credit: NASA/JPL/Space Science Institute. Fonte: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Italy/Cassini_trova_le_tracce_di_un_oceano_sulla_luna_di_Saturno_Enceladus. Marte – Credit: NASA / JPL / MSSS / ESA / DLR / FU-Berlin /J. Cowart, CC BY-SA 3.0 IGO. Fonte: https://news.utexas.edu/2019/12/16/3d-print-a-piece-of-mars-for-the-holidays/. Bennu – Credit: NASA/Goddard/University of Arizona. Fonte: https://www.nasa.gov/news-release/nasas-newly-arrived-osiris-rex-spacecraft-already-discovers-water-on-asteroid/
L’indagine sugli asteroidi completa il quadro. “La fascia principale tra Marte e Giove”, racconta Pajola, “è sede di corpi che possono essere perturbati dalle risonanze gravitazionali, soprattutto con Giove, e da interazioni planetarie che possono portarli su traiettorie di tipo NEO (Near Earth Object). Alcuni di questi asteroidi, classificati come PHA (Potentially Hazardous Asteroids), intersecano l’orbita terrestre a una distanza tale da poter arrecare danni significativi in un eventuale impatto; ecco perché, oltre al monitoraggio costante dalla Terra, missioni spaziali come DART e HERA esplorano strategie per deviarne la traiettoria e rafforzare la difesa planetaria. Ma gli asteroidi non rappresentano soltanto una minaccia: quelli di tipo carbonaceo, come Bennu e Ryugu, contengono infatti molecole organiche complesse, tra cui le basi azotate e i precursori degli amminoacidi, ovvero i mattoni essenziali per la vita terrestre. È quindi probabile che gli asteroidi abbiano contribuito a trasportare parte di questo materiale organico sulla Terra primordiale”.
L’attività di ricerca condotta da Alice Lucchetti e Maurizio Pajola attesta quanto la planetologia comparata sia fondamentale. Confrontare fratture, crateri, depositi criogenici, processi di erosione e movimenti di massa su corpi diversi aiuta a isolare i meccanismi fisici e chimici alla base dei fenomeni geologici osservati anche sulla Terra. Ma non solo: essa induce a ragionare sull’origine della vita e sulla capacità delle società — immaginarie o reali — di adattarsi a mondi instabili, in bilico tra catastrofe e possibilità, come quello di La Quinta Stagione.
Ulteriori ringraziamenti per la stesura dell’articolo vanno a Costanza Rossi, Matteo Massironi, Filippo Tusberti, Joel Beccarelli, Pietro Fraccaroli, Giovanni Munaretto.
Riccardo Pozzobon ripreso nel 2021 durante la missione PANGAEA dell’agenzia spaziale europea ESA a Lanzarote, isola dell’arcipelago della Canarie, nel 2021. Credits: ESA / A.Romeo. Fonte: https://blogs.esa.int/caves/2025/09/11/a-tribute-to-dr-riccardo-pozzobon/
Desideriamo rendere omaggio in queste ultime righe a Riccardo Pozzobon, stimato amico e collega di Alice Lucchetti e Maurizio Pajola, scomparso il 2 settembre scorso durante una missione di ricerca in Alaska, negli Stati Uniti. Riccardo ha illuminato, con la sua passione e la sua competenza, la strada verso la conoscenza della geologia planetaria, lasciando un segno indelebile nel lavoro scientifico del suo gruppo di ricerca. Oltre al suo impegno accademico, ricordiamo la sua umanità e la dedizione alla famiglia. Esprimiamo perciò la nostra più profonda vicinanza alla compagna e al figlio, che ne custodiranno per sempre l’eredità di pensiero e l’influenza nelle loro vite. Per sostenerli in questo momento così difficile, è attiva una raccolta fondi online grazie all’aiuto dell’Associazione La Venta. La cifra raccolta va direttamente alla famiglia, senza intermediari:
https://buonacausa.org/cause/riccardopozzobon
Nus, 3 ottobre 2025
ASTROGLOSSARIO
resurfacing: in geologia planetaria, indica il processo per cui la superficie di un corpo planetario viene modificata in modo che le caratteristiche più antiche vengono cancellate o sepolte da nuovo materiale, risultando in una superficie dall’aspetto più giovane. Questi rimodellamento può avvenire attraverso vari meccanismi, endogeni come l’attività tettonica e il vulcanismo, oppure esogeni come impatti.
run-off: il movimento dell’acqua liquida o di altri fluidi superficiali che scorre sulla superficie di un corpo planetario, come un pianeta o una luna, senza infiltrarsi nel sottosuolo e contribuendo, per esempio, al trasporto di sedimenti e all’erosione del paesaggio.
outflow channels: strutture geologiche visibili sulle superfici di copri planetari che si ritiene siano state scolpite dal rapido e massiccio deflusso di grandi volumi di acqua liquida, come inondazioni di portata imponente.
Riferimenti bibliografici
Internet Speculative Fiction Database: N. K. Jemisin, The Fifth Season, tutte le edizioni
Google Scholar: paper scientifici di Alice Lucchetti
Google Scholar: paper scientifici di Maurizio Pajola
Media INAF: articoli divulgativi sulle ricerche di Alice Lucchetti
Media INAF: articoli divulgativi sulle ricerche di Maurizio Pajola
Il Bo Live: “Una vita per la ricerca”, articolo in ricordo di Riccardo Pozzobon
ESA Caves & Pangaea Blog: “A tribute to Dr Riccardo Pozzobon”
Clicca qui per leggere le altre puntate della rubrica Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta (che comunque trovate anche in “bottega”)
(*) Puntata per puntata riprendiamo la rubrica mensile “Astronomia da fantascienza” dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (www.oavda.it › news › astronomia-da-fantascienz..) : ci accompagnerà verso il centenario della letteratura di fantascienza di aprile 2026. Era infatti l’ aprile 1926 quando uscì nelle edicole statunitensi il numero 1 di Amazing Stories, la prima rivista di fantascienza a definirsi tale. La rubrica è curata dalll’astrofisica e divulgatrice Camilla Pianta, in collaborazione con la ricercatrice Martina Giagio e con Andrea Bernagozzi (che più di qualche volta avete incontrato in “bottega”). Qui trovi l’intro che spiega il contesto.
Una noticina della “bottega” su N. K. Jemisin
Nora Keita Jemisin: «E così un giorno, quando la lotta sarà finita, potremo guarire. Quel giorno, almeno, ognuno di noi potrà sognare liberamente».
In “bottega” trovate solo tre articoli che hanno al centro Jemisin.
Il primo è Quando sarà finita (del 2015) ripreso dal blog «Lunanuvola» di Maria G. Di Rienzo che si conclude così, riprendendo un suo discorso pubblico (nel 2014) dove risponde anche ai bullismo online, con il suo corollario di minacce di stupro e di morte: «E così un giorno, quando la lotta sarà finita, potremo guarire. Quel giorno, almeno, ognuno di noi potrà sognare liberamente».
Qual è la terribile colpa di N. K. Jemisin? è donna, è nera, usa la sua scrittura per esplorare identità, sessualità, potere, violenza…
In un articolo del 2018 invece – Un dito a forma di missile – sempre Maria G. Di Rienzo riporta queste parole di Jemisin, dopo che ha vinto il terzo Premio Hugo consecutivo: «Questo è l’anno in cui arrivo a sorridere a tutti i bastian contrari: a ogni singolo mediocre, insicuro aspirante che concentra la sua bocca nel suggerire che io non ho niente a che fare con questo palcoscenico, che la gente come me non ha la capacità di guadagnare una simile onorificenza, che quando vincono loro è meritocrazia, ma quando vinciamo noi è politica identitaria. Sono in grado di sorridere a queste persone e di sollevare un enorme dito a forma di missile nella loro direzione». Quell’ anno furono le donne a vincere tutti i premi più importanti dell’Hugo (il cui simbolo appunto è un missile).
Sulla qualità della scrittura di N. K. Jemisin diverso il parere di Bianca Menichelli: cfr Della serie “La vertigine delle liste”.