Dossier manifestazione NUDM: in viaggio verso Roma e non solo
In questo piccolo dossier troverete:
1 – il comunicato di NUDM per la manifestazione nazionale;
2 – un articolo tratto da ND – NOIDONNE nel quale Tiziana Bartolini dialoga con Giorgia Serughetti;
3 – un articolo dal sito inGenere di Monica Cerutti a 30 anni dalla conferenza di Pechino;
4 – un articolo dal sito Ti spiego il dato di Donata Columbro e Roberta Caviglià
NON UNA DI MENO / 22 NOVEMBRE CORTEO NAZIONALE A ROMA
‘Sabotiamo guerre e patriarcato’ è lo slogan della manifestazione contro la violenza patriarcale e il riarmo
 Mercoledi, 19/11/2025 – 22 novembre 2025
Mercoledi, 19/11/2025 – 22 novembre 2025SABOTIAMO GUERRE E PATRIARCATO
Corteo nazionale di Non Una di Meno contro la violenza patriarcale e il riarmo
ROMA: Piazza della Repubblica ore 14:30
In occasione della
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE / 25 novembre 2025
cortei, presidi e flash mob in tutte le cittàI dati dell’Osservatorio nazionale di Non Una di Meno registrano 76 femminicidi e 67 tentati femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, 2 suicidi indotti di due ragazzi trans, 1 suicidio indotto di una persona non binaria, 1 suicidio indotto di un ragazzo. Non si tratta di un’emergenza ma di un fenomeno endemico e strutturale che richiede strumenti di intervento sociale e culturale.Il governo risponde con la legge sui femminicidi e l’inasprimento delle pene ma agisce “contro” la prevenzione della violenza: il Piano istituzionale antiviolenza attacca i centri antiviolenza e la loro storia femminista, il DL Valditara vieta l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e la subordina al consenso dei genitori, il DL Disforia impedisce i percorsi di affermazione di genere di bambin3 e adolescenti.
La manovra finanziaria libera risorse per la riconversione bellica a scapito di donne, persone trans*, precarie, migranti che pagheranno doppiamente il Piano di Riarmo, con i salari da fame, il part time imposto e i tagli ai servizi e al welfare.
La manifestazione nazionale a Roma sarà aperta dalle donne dei centri antiviolenza. Nel corso del corteo si svolgeranno azioni comunicative sui temi della mobilitazione:
· Per un’antiviolenza femminista e transfemminista, finanziata e libera dal ricatto dei bandi e dalla neutralizzazione
· Per una scuola libera da condizionamenti e diktat, per la libertà di ricerca e di insegnamento, per l’educazione sessuo-affettiva dalla scuola dell’infanzia all’università
· Contro la manovra finanziaria. Né complici né vittime della conversione bellica!
· Per il diritto all’autodeterminazione dei corpi e dei popoli
 PERCORSO
PERCORSO
· Piazza della Repubblica
· Viale Luigi Einaudi
· Piazza dei Cinquecento
· Via Cavour
· Piazza dell’Esquilino
· Via Liberiana
· Piazza di Santa Maria Maggiore
· Via Merulana
· Piazza di Porta San Giovanni
LIBERE, AUTODETERMINATE E VIGILI: IL MOVIMENTO NON SI ARRENDE ALLA POTENZA DEI NEOCONSERVATORI
Con Giorgia Serughetti ragioniamo sui pericoli reali per le donne di arretrare sul terreno dei diritti conquistati che le forze reazionarie provano a cancellare, anche manipolando le parole d’ordine del femminismo
Giovedi, 13/11/2025 –
“Penso che l’autodeterminazione continui ad animare molti desideri, lotte, capacità delle donne di auto-organizzarsi e di fare movimento; ma non c’è dubbio che il contesto internazionale è di un attacco frontale all’autodeterminazione, soprattutto sul versante delle libertà sessuali e riproduttive che è diventato un fronte di lotta su cui si misurano da un lato le forze di una destra reazionaria con tendenze autoritarie che mira apertamente a riportare i corpi delle donne sotto controllo e dall’altro i movimenti femministi”. Giorgia Serughetti, Docente di Filosofia politica all’Università Bicocca di Milano, fotografa l’attualità in prospettiva femminista sullo ‘stato di salute’ dell’autodeterminazione, condizione imprescindibile per una vera libertà delle donne.
Rispetto alla violenza di questo attacco, come reagiscono le donne e i movimenti?
“In alcuni casi, soprattutto in passato, sono riusciti a tenere l’argine. Penso alla forza che ha avuto il movimento delle donne in Polonia contro i tentativi del partito Diritto e Giustizia di restringere le libertà giuridicamente riconosciute in materia di interruzione di gravidanza o all’annullamento della sentenza Roe v. Wade nel 2022 in USA, che ha di fatto eliminato il diritto costituzionale all’aborto. Le donne ovunque hanno continuato le loro battaglie e tuttavia si trovano sempre più spesso di fronte a forze sempre più grandi, a governi che rispondono all’agenda politica dei movimenti ultraconservatori che rappresentano un bacino di consenso elettorale e hanno ramificazioni internazionali attraverso cui trasferiscono da un paese all’altro parole d’ordine, pacchetti comunicativi e strategie di lotta anti-abortista. Dunque il desiderio di autodeterminazione è più vivo che mai ma, scontrandosi con un contrattacco formidabile, sembra in affanno. La realtà è che i nemici si sono fatti più forti. Per certi versi quello che sembra essere carente sul versante delle lotte femministe è una pari capacità di muoversi con una mobilitazione transnazionale senza, contemporaneamente, dimenticare il livello locale. Tornando in Italia, e considerando la saldezza del governo di destra, non possiamo sottovalutare i temi delle politiche che coinvolgono le libertà delle donne a livello territoriale. Quindi il compito è impegnativo, ma dobbiamo essere capaci di stare a tutti questi livelli”.
Tra le strategie di queste forze ultraconservatrici c’è anche l’appropriazione di quelle che erano parole del femminismo…
“È chiara la strategia di appropriazione e distorsione del lessico progressista e femminista per condurre battaglie che vanno, appunto, nella direzione della restrizione dei diritti e della libertà delle donne. Il caso dell’aborto è particolarmente significativo, se osserviamo le campagne dei gruppi Pro Vita e simili che fanno leva su significanti positivi, come la salute delle donne oppure sull’aborto selettivo alludendo al femminicidio. O, ancora, quando evocano la violenza contro i bambini per bloccare strategie di educazione all’affettività e alla sessualità. Un uso propagandistico di parole d’ordine femministe, ma rovesciate nel loro significato; alle spalle di questa strategia comunicativa ci sono decenni in cui i movimenti, soprattutto anti-abortisti, hanno lavorato per appropriarsi del linguaggio dei diritti studiando il modo di invertire il significato e facendolo apparire come un ampliamento delle libertà. Per cui sostengono che il riconoscimento giuridico dell’embrione e del feto sarebbe l’allargamento di un diritto, quando in realtà è un passaggio propedeutico alla restrizione della libertà delle donne di accedere all’interruzione volontaria della gravidanza. Meloni e Roccella aderiscono a questa risignificazione e, infatti, parlano di aggiungere un diritto accentuando quanto prevede la legge 194 circa la prevenzione dell’aborto, ma non intervenendo sulla sua piena applicazione che è minata dall’obiezione di coscienza, così rispondendo alle pressioni di gruppi religiosi e neoconservatori che sostengono il governo. Sarebbe necessario ragionare sulla revisione della norma per metterla al riparo da questi attacchi, ma oggi non ci sono le condizioni nel Parlamento”.
Veniamo così al tema di queste donne di destra e di potere alle quali non si può certo dire che non siano autodeterminate. Che ne pensi?
“Sono sicuramente donne emancipate, anche con una misura di autodeterminazione, e non c’è dubbio che portino avanti modelli di forza femminile, di successo e di capacità femminile di farsi valere nel mondo. Le agende politiche di queste donne – oltre a Meloni penso a Marine Le Pen o a Alice Weidel – sono reazionarie; apparentemente è un paradosso che donne emancipate parlino di famiglia tradizionale. In realtà il paradosso viene meno se si considera che queste donne rappresentano la propria come un’ascesa individuale, non come un’impresa collettiva. Giorgia Meloni vuole affermare la sua come la storia di una donna che non ha avuto bisogno di quelle che l’hanno preceduta e che hanno aperto la strada anche a lei; essenzialmente si rappresenta come una donna che ce l’ha fatta da sola, per i propri meriti. Non riconoscendo un attivismo delle donne prima di lei, di fatto non pensa il suo come ruolo vocato a produrre emancipazione collettiva da tradurre, quindi, in opportunità nel diritto o nelle infrastrutture sociali per l’autodeterminazione di tutte. Considerando la sua avventura individuale, vuole dire che ‘se vuoi puoi’, che tu, donna singola, ti liberi da sola e che puoi autodeterminarti per tante ragioni che possono andare dal vantaggio che ti dà la nascita fino a speciali talenti personali. Al contrario l’idea è di costruire condizioni di possibilità per l’autodeterminazione di tutte. Lo scarto, in fondo, è proprio tra l’individuale e il collettivo. È qui, secondo me, che si svela la ragione di questo apparente paradosso e che in prima battuta può apparire semplicemente una contraddizione in termini. Sei in grado di conquistare il potere dimostrando la forza delle donne e tuttavia fai tua l’agenda di un partito che parla ancora di famiglia tradizionale e di ruoli di genere che di fatto sono gerarchici, anche se questo discorso reazionario non viene più sbandierato. Lo puoi fare nella misura in cui pensi che, certo, le donne ce la possono fare però ce la devono fare da sole. Per tutte le altre, alla fine, il modello che resta preferibile in cui trovare sicurezza è ancora quello della famiglia, quindi un ruolo ancillare. Con buona pace delle politiche delle pari opportunità, che mostrano la debolezza delle donne mentre il modello di successo è un modello di forza”.
Questa analisi dovrebbe sollecitare un ripensamento delle politiche di inclusione per le donne?
“Credo che le norme antidiscriminatorie, per capirci quelle che normalmente sono chiamate ‘quote’ ma che in realtà sono norme di riequilibrio, siano un tassello nell’ambito di un quadro di politiche più complessivo che deve articolare in una stessa visione sia norme per il riequilibrio della rappresentanza sia provvedimenti per la redistribuzione del reddito, per l’avanzamento economico e sociale accanto a iniziative sul versante culturale. La filosofa Nancy Fraser ha parlato di una giustizia di genere che deve essere tridimensionale: rappresentanza, riconoscimento e redistribuzione; tre elementi che, insieme, possono garantire il cambiamento. Non credo, quindi, che sia il caso di buttare a mare le norme di riequilibrio, non solo perché la necessità di far avanzare le donne in un momento di particolare difficoltà richiede misure straordinarie, ma anche perché rimane un argine in questo nostro mondo che tende a ‘tornare uomo’ appena si smette di lottare”.
Osservando le giovani nate nel terzo millennio, ritieni che sentano l’autodeterminazione come un tema importante?
“Penso che alcune idee per le più giovani siano veramente acquisite; per esempio in materia sessuale e riproduttiva, per molte è semplicemente un’ovvietà e non sarebbero disposte ad accettare niente di diverso rispetto a quanto danno per acquisito. In più vedo alcuni temi che stanno particolarmente a cuore alle giovani, come il diritto di poter abitare lo spazio pubblico senza essere minacciate nella propria incolumità, sentono molto il tema delle molestie di strada. ‘Riprendiamoci la notte’ è stata una battaglia storica del femminismo e trovo significativo sentire con quanta enfasi le più giovani si identifichino nel rifiuto di quel tipo di limitazione della loro libertà. È più difficile, invece, portarle a parlare dei problemi che riguardano la coppia con i comportamenti controllanti, soprattutto attraverso i social. Le adolescenti sono più vulnerabili a messaggi culturali particolarmente pericolosi che arrivano dalla rete, iniziative di controllo e abusanti sono scambiate per atteggiamenti di cura. Per le giovani la nuova frontiera di consapevolezza capace di aggregare intorno a interessi collettivi sono le battaglie legate all’identità, del ‘chi siamo’ e del ‘cosa vogliamo’ in termini anche di redistribuzione, di conquista di possibilità materiali e di vite più giuste. Il problema è essenzialmente quello della frammentazione e, per fare un esempio, richiamo il movimento lgbtqia+ : sappiamo che tutte le diverse identità possono rivendicare una specificità che non necessariamente solidarizza con l’altra. Il tema, quindi, è anche la capacità di costruire collettività evitando una deriva che porta all’individualizzazione delle lotte. L’incapacità di articolare lotte più vaste può diventare un problema alimentando una conflittualità a tratti davvero distruttiva che, in sostanza, è venuta generandosi tra pezzi di movimento femminista, pezzi di movimento lgbtqia+ o tra femminismi”.
Questa difficoltà, oggi, a mantenere uno sguardo largo richiama alla mente quello che invece avveniva 30 anni fa, a Pechino 95: grande condivisione internazionale. Cosa è rimasto?
“Tutto sommato mi fa impressione che, almeno in Italia, questo trentennale sia passato relativamente in sordina, ed è successo perché non esiste un clima politico accogliente rispetto a questa celebrazione. Quella di Pechino è stata una rottura gigantesca dal punto di vista del peso assunto dai temi posti al centro dal monumento femminista nelle agende delle organizzazioni internazionali e, quindi, a cascata nelle agende dei Paesi che sono parte delle Nazioni Unite e che presero parte alla Conferenza. Paesi che negli anni successivi hanno tradotto in politiche le indicazioni di empowerment e gender mainstreaming. Un trentennale passato un po’ in sordina anche perché molto di quanto previsto in quell’agenda è stato tradotto in termini di azione politica, purtroppo i risultati non sono all’altezza di quello che ci si aspettava. È vero che all’epoca si respirava un’aria di progresso che sembrava inarrestabile e i diritti sembravano destinati ad essere ampliati; in molti casi la vita delle donne è davvero migliorata, però non c’è dubbio che la sensazione, oggi, sia di una rivoluzione interrotta. D’altro canto questo anniversario cade in un anno in cui Donald Trump, da presidente degli Stati Uniti, delegittima le Nazioni Unite e Pechino 95 è stata, appunto, una Conferenza ONU”.
Guardando al futuro, quanto sei preoccupata per l’autodeterminazione delle donne, per le libertà?
“Naturalmente esistono luci nel buio. Penso a Zohran Mamdani che vince a New York con una squadra di donne mostrando la possibilità anche di convincere l’elettorato dell’importanza di rivendicare diritti sociali, come ci sono alcune vittorie sparse nel mondo di forze politiche di sinistra, qualche volta anche radicali, talvolta anche guidate da donne. Tra le luci ci sono sicuramente anche i movimenti femministi che non si danno per vinti e lottano, riuscendo anche ad avere un peso sulla scena nazionale e internazionale. Tuttavia la sensazione è che la saldatura tra grandi poteri economici e questa politica con tendenze neoautoritarie rischia di produrre poteri di peso in un misura tale che difficilmente le forze democratiche oggi in campo saranno in grado di contrastare, arginandone l’aggressività e rovesciando il discorso nel segno progressista”.
Questo articolo è parte del progetto ‘Pratiche di cittadinanza in dialogo con il futuro’ dell’Associazione NOIDONNE TrePuntoZero sostenuto con i fondi dell’8xMille della Chiesa Valdese. Tutti i materiali del progetto sono raccolti qui
A 30 anni dalla Conferenza di Pechino, la 69esima Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne ha ribadito l’importanza di adottare un approccio di genere nell’uso dell’Ai e delle tecnologie digitali, promuovendo la parità a tutti i livelli. Il resoconto nelle parole della rappresentante del Comitato italiano di UN Women, che per la prima volta ha preso parte alla Csw
La parità a 30 anni da Pechino

Quest’anno il tradizionale appuntamento a marzo della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (Commission on the Status of Women, Csw), la sessantanovesima, aveva una valenza particolare.
Si celebrava Pechino +30, vale a dire i 30 anni dalla Quarta conferenza mondiale delle donne di Pechino del 1995, in cui si erano affermati i concetti di ‘empowerment’ e ‘mainstreaming’. L’obiettivo era fare il punto sull’attuazione della sua agenda in un momento particolarmente complesso come quello attuale, in cui assistiamo a spinte reazionarie da parte di diversi governi che vorrebbero fare piazza pulita delle politiche di genere, facendole passare per un disvalore.
In un contesto così difficile, ero molto curiosa di capire che aria si fosse respirata in questa prima volta alla Csw come rappresentante di UN Women Italy, insieme alla sua presidente, Darya Majidi, e alla collega del board nazionale, Katja Besseghini.
Il nostro Comitato è infatti nato ufficialmente solo nel mese di ottobre dell’anno scorso, con lo scopo di sostenere la missione di UN Women in Italia.
È stata dunque una grande opportunità, a pochi mesi dalla sua nascita, poter seguire da vicino i lavori della Csw69. La prima emozione è stata quella di poter partecipare all’apertura dei lavori nella sala dell’Assemblea generale dell’ONU e sentire le parole di reazione ferma, di fronte al tentativo di far arretrare i diritti delle donne, da parte del Segretario generale, Antonio Guterres, che ha parlato di un “pushback to pushback”, vale a dire un “respingimento del respingimento”, e della Direttrice esecutiva di UN Women, Sima Bahous.
Altrettanto risoluti gli interventi delle delegate che hanno sottolineato l’importanza dei diritti delle donne in tutti i paesi, di un approccio intersezionale alle politiche, e richiedere che siano previste più candidate per il prossimo rinnovo della carica di Segretario generale – che finora non è mai stata ricoperta da una donna, impegno che poi è stato ripreso nella risoluzione finale.
Non meno coinvolgente è stato poter visitare il quartier generale di UN Women e incontrare chi sta seguendo i progetti centralmente e anche su territori particolarmente critici, come Sabine Freizer Gunes, rappresentante di UN Women Ucraina, e Maryse Rebecca Guimond, rappresentante di UN Women presso i territori palestinesi.
Le parole di quest’ultima ci hanno angosciato più di quanto potessimo già esserlo, ma ci hanno restituito anche l’importanza del contributo che può portare un’organizzazione come UN Women, facendo leva su aspetti che nelle emergenze umanitarie di questo tipo potrebbero essere dimenticati, come l’importanza di far arrivare nei territori occupati gli assorbenti intimi, insieme ai viveri.
Non è un caso se una delle sei azioni strategiche dell’agenda Pechino +30 è proprio “aumentare la partecipazione significativa delle donne in tutti gli aspetti della pace e della sicurezza e finanziare le organizzazioni femminili in situazioni di crisi e conflitto”. Questione assolutamente all’ordine del giorno nel periodo che stiamo vivendo.
Le altre cinque priorità, per le quali si invita a passare all’azione, toccano le aree che possiamo considerare tradizionalmente di attenzione nelle politiche di genere:
-
investire nei sistemi di protezione sociale, nei servizi pubblici e nei servizi di assistenza per dare alle donne e alle ragazze le opportunità che meritano;
-
adottare, attuare e finanziare leggi e politiche nazionali che sanciscano l’impunità zero nei confronti della violenza contro le donne e sostenere le organizzazioni femminili locali;
-
attuare leggi e politiche, applicare misure speciali temporanee, come quote, per aumentare il numero di donne in posizioni decisionali in politica, nel mondo degli affari e nelle istituzioni;
-
dare priorità alle donne e alle ragazze nell’azione per il clima, aumentando gli investimenti nella loro leadership e nell’accesso a lavori verdi, come nell’agricoltura sostenibile, nelle energie rinnovabili e nell’assistenza;
-
sostenere il Global Digital Compact e promuovere politiche per colmare il divario digitale di genere, garantendo pari accesso e leadership a tutte le donne e le ragazze nel campo della tecnologia.
L’ultima area strategica citata è in realtà la prima che viene indicata, auspicando una rivoluzione digitale per tutte le donne e le ragazze. Obiettivo assolutamente imprescindibile, perché sappiamo che questo ambito può essere decisivo per il raggiungimento della parità di genere o al contrario può inesorabilmente aumentare i divari attualmente esistenti, non solo quello digitale.
Questo tema viene ripreso in un punto specifico del documento di dichiarazione politica elaborato dalla Csw69, dove si legge che è fondamentale “sfruttare il potenziale della tecnologia e dell’innovazione e colmare i divari digitali all’interno e tra i paesi, incluso il divario digitale di genere, nonché ampliare le opportunità di apprendimento digitale, alfabetizzazione e sviluppo delle capacità e affrontare i rischi e le sfide emergenti dall’uso delle tecnologie, nel pieno rispetto dei diritti umani di tutte le donne e le ragazze, sia online che offline, e integrare una prospettiva di genere nelle tecnologie digitali, inclusa l’intelligenza artificiale”.
Viene dunque anche considerata l’altra faccia della medaglia, vale a dire la necessità di contrastare l’utilizzo delle tecnologie digitali come potenziali strumenti per attuare molestie e violenze.
A mio avviso poteva tuttavia esser maggiormente sottolineato come le nuove tecnologie, e in particolare l’intelligenza artificiale, possano rappresentare uno dei principali elementi di novità per passare all’azione, partendo dalla constatazione che nei trent’anni dalla Conferenza di Pechino nessun paese ha raggiunto la parità di genere.
L’altra questione giustamente ripresa nel documento è quella del lavoro femminile non retribuito: “riconoscere, ridurre e ridistribuire la quota sproporzionata di lavoro domestico e di cura non retribuito delle donne e delle ragazze, promuovendo l’equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne all’interno della famiglia e promuovendo l’equilibrio tra lavoro e vita privata, tra l’altro, dando priorità agli investimenti pubblici per sviluppare ed espandere sistemi di cura integrati, comprese le politiche di congedo per cura, la fornitura di servizi di assistenza e supporto universali durante tutto il corso della vita e il giusto riconoscimento, rappresentanza, remunerazione e ricompensa degli operatori socio-assistenziali”.
Tanti dunque gli spunti emersi, che si integrano nell’alveo delle riflessioni finora sviluppate, riconoscendo anche la necessità di un ripensamento generale con la sottoscrizione di un Patto per il futuro, volto a esplorare opzioni per far si che la Commissione si impegni maggiormente a migliorare la condizione delle donne, attraverso un processo intergovernativo inclusivo che preveda la partecipazione di tutti gli stati membri, e riaffermando al contempo il mandato della Commissione.
Una rivisitazione critica di ciò che è stato fatto finora, con un’attenzione più marcata all’impatto delle azioni intraprese, non sminuisce in ogni caso il valore che la Csw continua a esercitare.
Vedere e incontrare donne e uomini provenienti da ogni continente mi ha fatto toccare con mano la straordinaria forza collettiva che possiamo mettere in atto per costruire un mondo diverso, equo e di pace, lontano dagli scenari che oggi sembrano imporsi in maniera irreversibile, partendo da un protagonismo inedito della società civile.
UN Women Italy si sta muovendo in questa direzione. Come ha affermato Sima Bahous nella sessione conclusiva: “il nostro compito ora è quello di portare questa energia da queste sale ai luoghi in cui le donne e le ragazze vivono le loro vite”. E aggiungo, facendo uno scatto in avanti rispetto al passato, non chiudendosi in una posizione difensiva.
“Se proteggessero le donne come proteggono i dati saremmo tutte al sicuro”
Lo ha detto la scorsa settimana Cristina Mollica, professoressa di statistica all’università Sapienza, durante un evento dedicato a Ilaria Sula, vittima di femminicidio per mano di uno studente dello stesso ateneo.
Ma in che senso le istituzioni proteggono più i dati delle donne?
Ogni volta che faccio un intervento sul tema e parlo di come ci sia poca integrazione tra le banche dati governative, osservo facce piene di stupore. Perché mi rendo conto che il resto del mondo non funziona così: in azienda, ma anche nel settore umanitario, dove mi sono formata, per portare avanti qualsiasi progetto bisogna fare una valutazione dello stato dell’arte, poi un monitoraggio della realizzazione dell’intervento, e infine una verifica dell’impatto delle azioni messe in atto.
I dati vengono raccolti prima, durante e dopo.
Nonostante gli enormi passi avanti fatti dalle leggi che vengono approvate nel nostro paese, non ultima la fondamentale legge sul consenso votata alla camera stamattina, sembra che mettere insieme i dati per verificarne l’efficacia ed eventualmente colmare le mancanze (anche di fondi), sia sempre l’ultimo dei pensieri.
Ecco perché i risultati che sta avendo la campagna Dati Bene Comune sulla violenza di genere sono una buona notizia: più di 20mila persone chiedono dati disaggregati, trasparenti e accessibili.
Perché i dati sono bene comune
Quando abbiamo lanciato la prima campagna Dati Bene Comune, nel 2020, sembrava incredibile che 50mila persone condividessero la nostra battaglia per dati trasparenti, pubblici e utilizzabili per verificare le politiche pubbliche delle istituzioni, o lo sembrava a noi, piccolo gruppo di nerd dei dati. Ma la questione all’epoca riguardava la nostra salute e prendere decisioni quotidiane fondamentali come poter portare i bambini a scuola o andare in ufficio il giorno dopo: chiedevamo infatti i dati sull’algoritmo che colorava le regioni d’Italia durante la pandemia, quell’algoritmo che decideva il nostro diritto a uscire o meno di casa, di comune, di regione.
Quando abbiamo deciso di lanciare una campagna per dire ai ministeri (interno e giustizia) che i dati sulla violenza di genere non li possono tenere chiusi nei cassetti ma li devono pubblicare, ci siamo riuniti (onData, info.nodes, Transparency International, Period Think Tank, Action Aid) e abbiamo pensato come prima cosa di coinvolgere altre associazioni. Come quelle che lavorano sul territorio, a partire da D.i.Re – Donne in rete contro la violenza di genere, e poi tutte quelle da cui stiamo ricevendo l’adesione. Tante alleate per contare e misurare in modo efficace la violenza di genere.
Ventimila firme (ma ci arriviamo a 50mila, di nuovo? Dai!) sono anche un modo per dare sostegno a chi all’interno delle istituzioni li vuole questi dati.
Penso alla prima firmataria della legge 53 del 2022, la senatrice Pd Valeria Valente, che, portando avanti questo lavoro durante il precedente mandato della Commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi, ha messo nero su bianco che i dati sulla violenza di genere dovrebbero essere prodotti in modo diverso, raccontati in modo diverso, rispetto a quello che veniva fatto fino a quel momento. E la Commissione, che accoglie nelle sue audizioni le istanze delle associazioni e della società civile, continua oggi a fare un lavoro prezioso, e quando si tratta di raccolta dati va sostenuta.
Unisciti alla campagna, e se collabori con un’associazione o un ente che vuole aderire firmando la lettera d’intenti, scrivici.
Il libro di Donata Columbro ‘Perché contare i femminicidi è un atto politico?’ affronta la carenza di dati pubblici sui femminicidi e l’importanza di contare e raccontare le storie delle donne vittime di violenza. L’autrice sostiene che contare i femminicidi è un atto politico di rivolta contro il potere patriarcale.
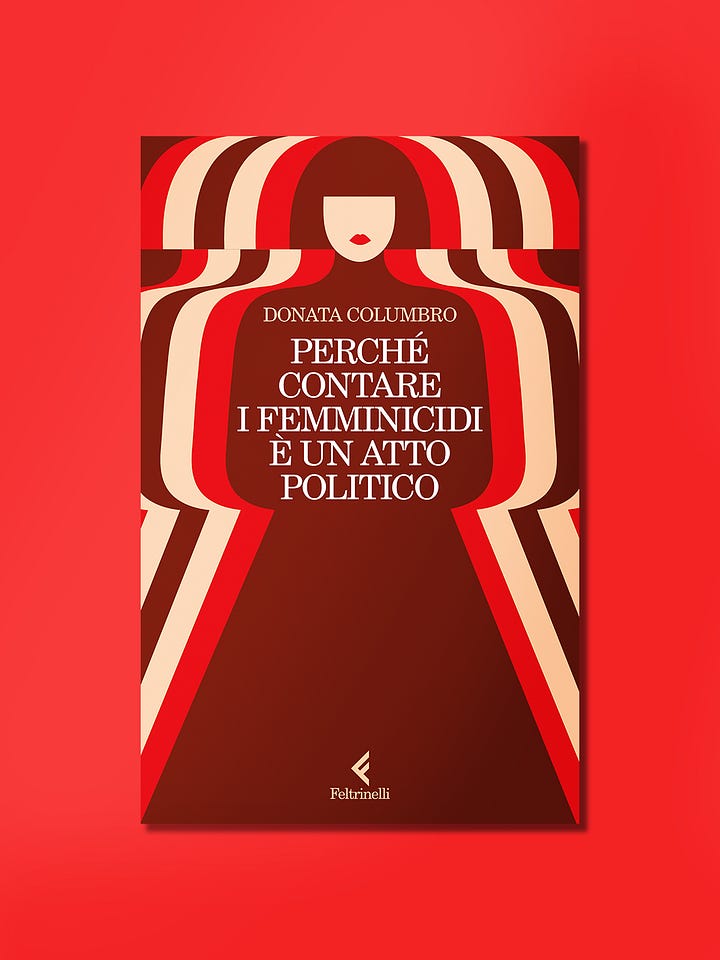
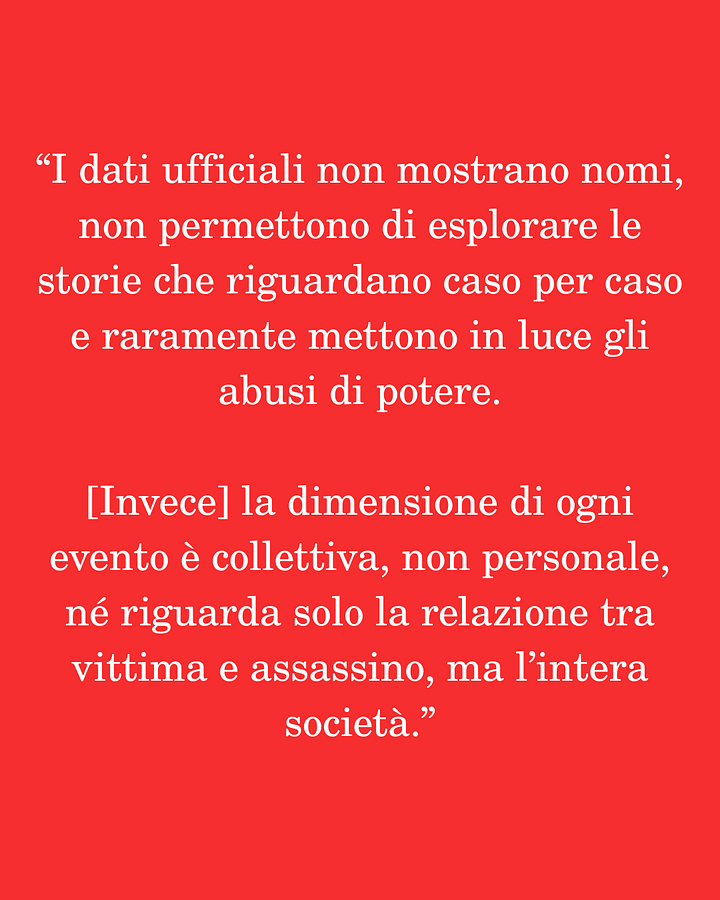
Se ce l’hai già, e se ti va, lasciami una recensione su Amazon o Goodreads <3

