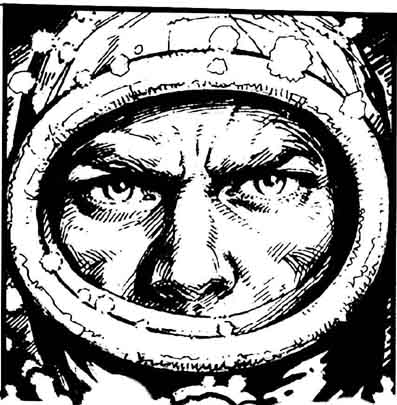Quando il Gioco insegna la pace
Fabrizio Melodia, noto «Astrofilosofo» si aggira dai wargames più antichi ai moderni strumenti di comprensione
Antica lezione su un’anfora greca
Su un’anfora a figure nere del VI secolo avanti Cristo, il ceramista Exekias immortalò una scena sorprendente: i leggendari guerrieri Achille e Aiace, eroi dell’Iliade, intenti a un gioco da tavolo durante l’assedio di Troia. Non stavano affilando spade o preparando strategie belliche, ma giocavano alla “pettèia”, una specie di dama dove si catturavano i pezzi nemici. Quella scena antica racchiude una verità profonda: guerra e gioco hanno sempre intrattenuto una relazione complessa e contraddittoria.
L’evoluzione del Wargaming: dalla Prussia al mondo
La storia moderna dei wargames inizia nel XVII secolo, quando gli scacchi cominciarono a essere studiati come modello della guerra e della politica. Ma fu nel 1803 che il matematico Johann Christian Ludwig Hellwig creò “Das Kriegsspiel” (Il gioco della guerra), dove pedine che emulano truppe e artiglieria si muovevano su plancie colorate rappresentanti diversi terreni.
Il vero punto di svolta arrivò nel 1824 con Georg Heinrich Rudolf Johann von Reiswitz, che perfezionò il “kriegsspiel” paterno introducendo un elemento rivoluzionario: i dadi per risolvere i conflitti. Come spiega Jon Peterson in “Playing at the World”, questo segnò il passaggio dalla previsione alla simulazione: “Una previsione è giusta o sbagliata, ma una simulazione non è nessuna di queste cose: è una mera finzione che deriva da un insieme di dati che approssimano, con maggiore o minore realismo, una certa circostanza”.
H. G. Wells e la profezia inascoltata
Nel 1913, lo scrittore H.G. Wells pubblicò “Little Wars”, pioniere dei wargames con miniature. La sua speranza era educativa: “Vi basteranno tre o quattro partite a Little Wars per capire che errore madornale sarebbe una Great War”. Wells sperava che il suo gioco di guerra educasse alla pace ed evitasse la guerra mondiale che, tragicamente, scoppiò proprio l’anno successivo.
Il paradosso del Gioco: simulare per comprendere
I giochi di guerra commerciali che si svilupparono dopo la Seconda Guerra Mondiale mostravano una tendenza interessante: evitavano deliberatamente gli scenari contemporanei, dai bombardamenti della guerra mondiale alle minacce atomiche della Guerra Fredda. Il gioco cercava rifugio in un passato più remoto, in una guerra ancora “convenzionale” e apparentemente gestibile.
Lo storico Johan Huizinga, nel suo fondamentale “Homo Ludens” (1938), sosteneva che la guerra del passato, a differenza della “guerra totale” contemporanea, fosse effettivamente un gioco: qualcosa governato da regole condivise e svolto in uno specifico “cerchio magico”. Due anni dopo la pubblicazione del libro, l’esercito nazista invase i neutrali Paesi Bassi, dimostrando quanto fosse cambiata la natura del conflitto.
“Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di
cultura, per quanto possa essere definito insufficientemente,
presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali non
hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare.
Anzi si può affermare senz’altro che la civiltà umana non ha
aggiunto al concetto stesso di gioco una caratteristica
essenziale. Gli animali giocano proprio come gli uomini; tutte
le caratteristiche fondamentali del gioco sono realizzate in
quello degli animali”, scriveva Huizinga.
Dai Wargames ai giochi di ruolo: una rivoluzione quasi pacifista
L’evoluzione più significativa arrivò nel 1974 con *Dungeons & Dragons* di Gary Gygax e Dave Arneson, nato dal wargame medievale *Chainmail*. Per Gygax, fervente pacifista, l’ambientazione fantasy era un modo per allontanarsi dalla Guerra del Vietnam e da una comunità di wargaming che Jon Peterson definisce “un movimento giovanile conservatore” negli anni ’60.
Giochi come medicina sociale
Oggi comprendiamo meglio il potenziale terapeutico e educativo dei giochi strategici:
Contro l’azzardopatia
I giochi di strategia insegnano che le conseguenze derivano dalle scelte, non dal caso. Sviluppano il pensiero critico e la pianificazione a lungo termine, competenze essenziali per resistere alle seduzioni del gioco d’azzardo.
Comprensione dei conflitti
I moderni giochi cooperativi e i “serious games” permettono di esplorare dinamiche complesse senza le conseguenze reali del conflitto. Attraverso la simulazione, i giocatori possono comprendere:
– Le conseguenze a cascata delle decisioni
– L’importanza della diplomazia
– Il costo umano ed economico dei conflitti
– L’interconnessione globale
Educazione all’empatia
I giochi di ruolo permettono di “abitare” prospettive diverse, sviluppando comprensione per punti di vista differenti e riducendo la tendenza alla demonizzazione del “nemico”.
Limiti della simulazione nell’era contemporanea
Come avvertiva già nel 1968 il giornalista Andrew Wilson in “The Bomb and the Computer”, dobbiamo guardarci dalla fede eccessiva nelle capacità predittive dei wargames. Wilson metteva in guardia dall’approccio puramente quantitativo dei wargame computerizzati, che trascura elementi non quantificabili come il fattore umano.
Oggi, con il collasso dei sistemi climatici e degli ecosistemi, anche i modelli matematici più sofisticati mostrano i loro limiti. La realtà rimane sempre più complessa di qualsiasi simulazione.
Verso un futuro di gioco consapevole
I giochi non possono prevenire le guerre, ma possono certamente contribuire a una cultura di pace attraverso:
– Educazione alle conseguenze: mostrando che ogni azione ha ripercussioni
– Sviluppo dell’empatia: permettendo di comprendere prospettive diverse
– Promozione della cooperazione: privilegiando soluzioni collaborative
– Stimolo al pensiero critico: contro semplificazioni e propaganda
Come ci insegna quella antica anfora di Exekias, forse il momento più umano dei grandi guerrieri non era quando brandivano le armi, ma quando giocavano insieme, riconoscendo nell’avversario un compagno di gioco piuttosto che un nemico da annientare.
Per approfondire:
Libri:
– Peterson, Jon. “Playing at the World” (seconda edizione). The MIT Press, 2024
– Huizinga, Johan. “Homo Ludens”. Einaudi, 1973
– Wells, H.G. “Little Wars”. 1913 (disponibile gratuitamente online)
– Wilson, Andrew. *The Bomb and the Computer*. 1968
Riviste Specializzate:
– *Games & Culture* (rivista accademica sui game studies)
– *Simulation & Gaming* (ricerca sulla simulazione e i giochi educativi)
Organizzazioni:
– Games for Change (organizzazione per i serious games)
– International Simulation and Gaming Association (ISAGA)