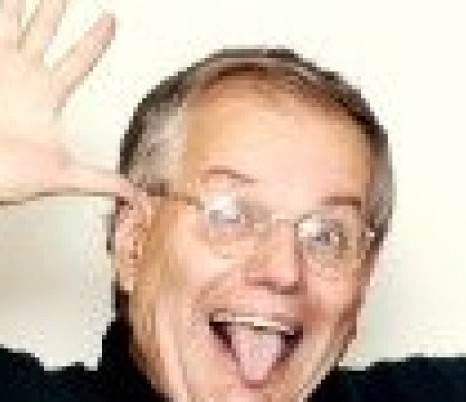Sudan: genocidio fuori campo
L’oro, il Mar Rosso e le vite che non contano.
di Mario Sommella (*)
Genocidi a geometria variabile
Nell’ultimo anno il dibattito pubblico è stato costellato di parole enormi: “genocidio”, “crimini di guerra”, “pulizia etnica”. Si discute, spesso in modo strumentale, di Gaza e della Palestina; si invocano i tribunali internazionali, si litiga sui numeri, si prova perfino a stabilire una gerarchia del dolore. Ma mentre il mondo si accapiglia su ciò che vuole o non vuole vedere, c’è un altro genocidio che si consuma quasi nel silenzio: quello in Sudan.
Non è una tragedia minore. È semplicemente un genocidio che cade fuori dall’inquadratura: troppe poche telecamere, troppo nero il colore dei corpi massacrati, troppo evidente l’intreccio tra rapina di risorse, neocolonialismo, interessi militari e finanziari di mezzo mondo.
Dal 2023 ad oggi, la guerra tra le Forze Armate Sudanesi (SAF) e le milizie paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) ha ucciso decine di migliaia di persone e spinto alla fuga oltre 12 milioni di esseri umani: la più grande crisi di sfollamento al mondo, con più di 8 milioni di profughi interni e milioni di rifugiati nei paesi vicini.
Alcune stime parlano ormai di oltre 150 mila morti complessivi, solo nell’ultima fase del conflitto.
Eppure, nelle scalette dei telegiornali, questa guerra quasi non esiste.
Dal Darfur a El Fasher: un genocidio annunciato
Per capire che cosa sta accadendo oggi, bisogna tornare al Darfur, inizio anni Duemila: il governo di Omar al-Bashir arma le milizie arabe janjāwīd per reprimere la ribellione delle popolazioni non arabe. Villaggi rasi al suolo, stupri di massa, deportazioni: un’intera regione trasformata in laboratorio di pulizia etnica. La comunità internazionale arriverà a parlare di genocidio, gli Stati Uniti lo dichiarano formalmente nel 2004, ma la macchina di morte non verrà mai davvero smantellata.
Quelle milizie, nel frattempo, cambiano uniforme: si trasformano nelle Rapid Support Forces guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti. La sigla cambia, la logica no.
Quando nell’aprile 2023 esplode la guerra aperta tra l’esercito regolare di Abdel Fattah al-Burhan e le RSF, il copione è già scritto: le città diventano fronti di battaglia, i civili bersaglio quotidiano di bombardamenti, esecuzioni sommarie, violenze sessuali, saccheggi. Amnesty International parla di “diffuse violazioni del diritto internazionale” da parte di entrambe le parti, documentando attacchi indiscriminati, stupri usati come arma di guerra, blocchi degli aiuti umanitari.
Il caso di El Fasher, capitale del Nord Darfur, è simbolico. Per oltre un anno la città è rimasta sotto assedio, ultimo bastione governativo in una regione largamente controllata dalle RSF. Intorno, campi di sfollati già saturi; dentro, fame, malattie, mancanza di acqua e cure. Le Nazioni Unite e le ONG hanno lanciato per mesi l’allarme sul rischio di un massacro su base etnica.
Quando le RSF hanno preso la città, alla fine del 2025, i racconti convergono: migliaia di civili uccisi, esecuzioni di massa, stupri, fosse comuni, famiglie intere scomparse nella fuga verso Tawila e altre località già esauste.
È questo che significa genocidio: non solo uccisioni su larga scala, ma la volontà di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo identificato per etnia, appartenenza comunitaria, origine. In Darfur, come già vent’anni fa, il bersaglio sono le popolazioni non arabe: Masalit, Fur, e altre comunità accusate di “non appartenere” a un ordine sociale costruito sul dominio delle élite arabe armate.
La Convenzione tradita: quando chiamare le cose col loro nome diventa pericoloso
Dal 1948 esiste una Convenzione ONU che definisce il genocidio come il compimento, con intenzione distruttiva, di atti quali uccisioni, gravi lesioni fisiche o mentali, imposizione di condizioni di vita destinate a portare alla distruzione di un gruppo, impedimento delle nascite, deportazione dei bambini. È un testo che si cita spesso, ma che si applica pochissimo.
In Sudan la parola “genocidio” resta accuratamente schermata dal linguaggio diplomatico. L’ONU parla di “rischio elevato”, di “indicatori allarmanti”, di “violazioni massicce”. Ma non si spinge a definire giuridicamente ciò che Accordi e rapporti sul campo ormai descrivono come campagne sistematiche di pulizia etnica.
La differenza non è solo semantica. Se un genocidio viene riconosciuto come tale dagli organi competenti, scattano obblighi internazionali: protezione della popolazione, missioni di interposizione, sanzioni vincolanti, giurisdizione penale sui responsabili. Se resta nel limbo del “rischio”, ci si limita a raccomandazioni, appelli, dichiarazioni indignate. Intanto si continua a morire.
Il Sudan è il caso esemplare di come la comunità internazionale scelga le parole in base alla convenienza politica, non alla realtà dei fatti. L’etichetta di genocidio è un’arma morale potente: si usa – o si evita – a seconda di chi sono le vittime e di chi arma i carnefici.
La maledizione dell’oro: quando un Paese ricco deve restare povero
Il Sudan potrebbe essere uno dei paesi più prosperi dell’Africa: possiede enormi terre coltivabili, abbondanti risorse idriche sotterranee, un patrimonio zootecnico enorme. Soprattutto, è diventato uno dei principali produttori di oro al mondo.
Ma nel sistema neoliberale globale, le ricchezze naturali di un paese fragile non sono una benedizione: sono una condanna. Le miniere d’oro in Darfur e in altre regioni sono finite sotto il controllo diretto delle RSF e di reti di società di comodo collegate alla famiglia di Hemedti. Indagini di Global Witness e di altre organizzazioni hanno mostrato come il metallo prezioso venga estratto in condizioni brutali, spesso da lavoratori poverissimi o bambini, quindi contrabbandato verso gli Emirati Arabi Uniti e altri hub, dove entra nel mercato globale ripulito da ogni traccia di sangue.
In cambio dell’oro, arrivano armi, veicoli militari, denaro liquido. Un vero modello di investimento neocoloniale: le milizie si finanziano trasformando una risorsa nazionale in carburante per la guerra; le élite economiche e finanziarie esterne assicurano a sé stesse profitti stellari, mentre il paese sprofonda nel caos.
Il Sudan non è un’anomalia, è un caso scuola. Lo stesso schema si è visto nel Congo per coltan e altri minerali tecnologici, in altri contesti africani per petrolio, diamanti, gas. La guerra non è un incidente sul cammino dello sviluppo: è un dispositivo funzionale alla rapina, che rende impossibile la costruzione di uno Stato sovrano, costringendo la popolazione a sopravvivere in una precarietà permanente.
Mar Rosso, Port Sudan e la geopolitica della frammentazione
A rendere il paese ancora più strategico c’è la geografia: il Sudan si affaccia sul Mar Rosso, attraverso il porto di Port Sudan, crocevia essenziale per le rotte commerciali e militari che collegano Mediterraneo, Golfo Persico e Oceano Indiano. Chi controlla quel tratto di costa influisce sugli equilibri di sicurezza di Egitto, Arabia Saudita, Israele, Iran, Turchia, nonché sulle ambizioni russe di avere una base stabile nella regione.
Attorno al conflitto interno si muove così un vero condominio di potenze: gli Emirati Arabi Uniti accusati di armare e finanziare le RSF, mentre Egitto, Arabia Saudita, Turchia, Iran e altri attori regionali sostengono in varia misura l’esercito regolare.
Anche potenze europee giocano partite ambigue: rapporti di Amnesty International hanno documentato, ad esempio, l’uso in Sudan di sistemi d’arma prodotti in paesi UE e giunti sul teatro di guerra tramite stati intermedi, in potenziale violazione di embargo e norme sul controllo degli armamenti.
In questa logica, la frammentazione del Sudan non è un rischio collaterale, ma una prospettiva appetibile. Un paese spezzato in più entità deboli, magari con “cripto-Stati” controllati da milizie economico-militari, è più facile da gestire per chi è interessato solo a corridoi logistici, basi militari e contratti sulle risorse. La tragedia del Sud Sudan, nato nel 2011 e già precipitato in una nuova guerra civile, è un avvertimento che nessuno sembra voler ascoltare.
Negrofobia integrata: perché questo genocidio non “fa notizia”
Perché, nonostante i numeri e la brutalità documentata, quello sudanese resta un genocidio fuori campo?
C’è una componente di cinismo geopolitico: ammettere la portata del massacro significherebbe interrogare la complicità diretta e indiretta di governi occidentali, monarchie del Golfo, alleati strategici come Israele nella catena economica e militare che alimenta il conflitto. È più comodo ridurre tutto a “guerre tribali”, fatalismo africano, conflitti “troppo complicati”.
Ma c’è anche qualcosa di più profondo: una gerarchia razziale delle vite. Le vite nere del Sudan – come quelle del Congo, del Sahel, di tante altre periferie – vengono percepite come intrinsecamente meno degne di lutto e di attenzione. La loro morte è considerata, in fondo, “normale”: un rumore di fondo della storia, non una rottura insopportabile dell’ordine morale.
Quello che alcuni studiosi chiamano “negrofobia integrata” si traduce nella pratica in questo: una strage di civili europei o mediorientali inquadrati nel conflitto “giusto” riempie le prime pagine; un milione di sfrattati dalla fame e dalle bombe in Darfur scivola nei trafiletti, quando va bene, o nelle statistiche nascoste nei report umanitari.
Lo stesso doppio standard si vede nella gestione dei rifugiati: le frontiere si aprono – tra mille ipocrisie – per alcune categorie di profughi, mentre i sudanesi che attraversano il deserto e il mare vengono abbandonati nelle prigioni libiche, respinti, ricacciati nell’invisibilità.
Genocidio come dispositivo economico e politico
Il Sudan dimostra che il genocidio non è solo un eccesso di violenza, ma un dispositivo politico-economico. Eliminare, terrorizzare, sfollare un gruppo significa liberare territori, romperne i legami sociali, disarticolare qualunque forma di resistenza organizzata. Significa creare spazi vuoti da riempire con miniere, basi, corridoi energetici, agricoltura d’esportazione.
Le RSF non sono semplicemente una banda di predoni; sono un attore politico-militare moderno, con un proprio network di imprese, banche, società di facciata, conti offshore. Indagini dell’ONU, di Global Witness, di The Sentry ricostruiscono una rete che incrocia l’industria dell’oro, del trasporto, della sicurezza privata, con ramificazioni soprattutto negli Emirati Arabi Uniti.
Dall’altra parte, l’esercito regolare non è un campione di democrazia: bombardamenti indiscriminati, violenze su civili, uso strumentale della fame e dell’assedio come arma sono prassi consolidate.
Il popolo sudanese, che nel 2018-2019 aveva riempito le piazze reclamando “libertà, pace e giustizia” e aperto una breccia rivoluzionaria nel continente, oggi è schiacciato tra due apparati armati che si spartiscono il paese e le sue ricchezze.
Rompe il silenzio chi rifiuta la gerarchia del dolore
Raccontare il genocidio in Sudan non significa “spostare l’attenzione” da Gaza, né attenuare la gravità del massacro del popolo palestinese. Significa, al contrario, rifiutare l’idea che la solidarietà sia un gioco a somma zero, dove un dolore cancella l’altro.
Il filo che unisce Darfur e Gaza, Congo e Cisgiordania, Yemen e Ucraina non è una contabilità macabra di vittime, ma la struttura di fondo: un ordine mondiale in cui la vita vale in proporzione al suo peso politico, alla sua utilità economica, alla sua compatibilità con i disegni delle potenze.
Parlare del Sudan, nominarlo, seguirne le vicende, dare spazio alle voci sudanesi in diaspora, significa incrinare questa gerarchia. Significa ricordare che nessun genocidio è “periferico”, che nessuna guerra di rapina può essere normalizzata in nome del realismo geopolitico.
La prima forma di complicità è il silenzio.
La prima forma di resistenza è rompere quel silenzio, chiamare le cose col loro nome, mettere in fila i nessi tra oro, armi, frontiere, razzismo, potere. Il genocidio sudanese, oggi, è anche questo: una prova della nostra capacità – o incapacità – di guardare oltre il perimetro rassicurante delle vite considerate “importanti”.
Chi pretende di difendere i diritti umani solo quando gli conviene, chi parla di “vita sacra” solo a intermittenza, non sta difendendo nessuno: sta semplicemente scegliendo da che parte della rapina stare.
(*) ripreso da «Un blog di Rivoluzionari Ottimisti. Quando l’ingiustizia si fa legge, ribellarsi diventa un dovere»: mariosommella.wordpress.com
In “bottega” cfr Atrocità e uccisioni di massa in Sudan, Il traffico di armi continua ad alimentare il conflitto in Sudan …, Sudan: peggio della guerra il silenzio (di Alex Zanotelli) e Dal dimenticato Sudan
LA VIGNETTA di Mauro Biani è “vecchia” e i numeri cambiano (in peggio) ma purtroppo la logica resta uguale: nel pianeta dei ricchi si finge di non vedere cosa accade in Sudan.