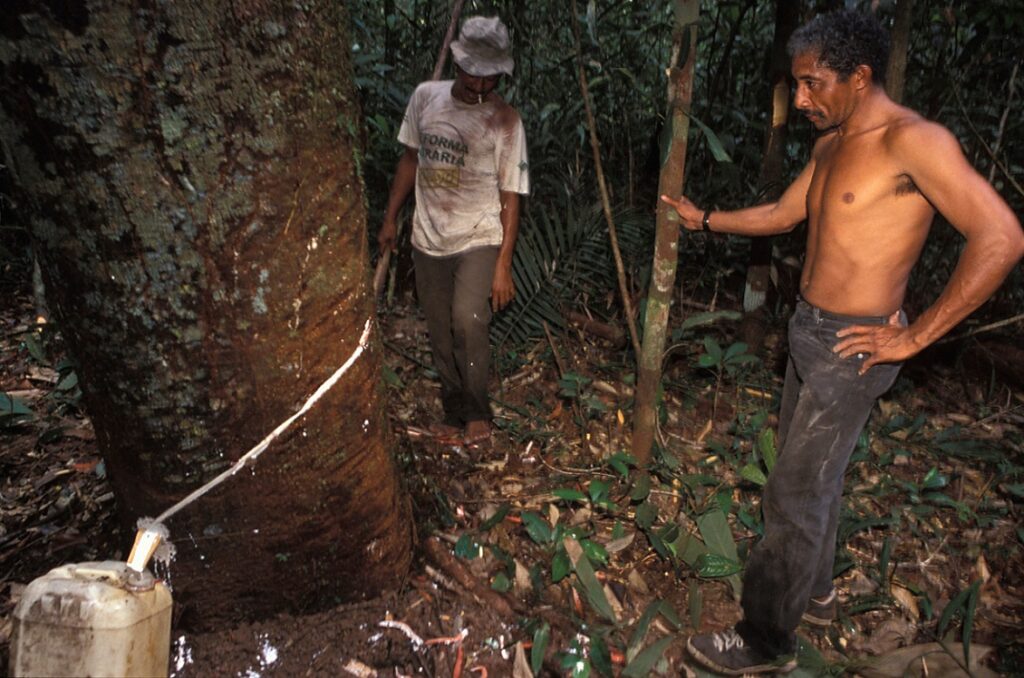Per la prima volta nella sua storia, la Conferenza delle Parti (COP) dell’ONU sui cambiamenti climatici si svolge nel cuore dell’Amazzonia, a Belém, cadendo peraltro in una ricorrenza doppiamente simbolica: vent’anni dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e dieci anni dall’adozione dell’Accordo di Parigi.
Un passaggio che impone un bilancio complessivo della diplomazia climatica internazionale e della sua reale capacità di produrre risultati. Le azioni di mitigazione e adattamento finora messe in campo restano insufficienti, frammentate e diluite dallo stesso impianto decadente del summit sul clima più importante al mondo.
La COP30 arriva dopo cicli negoziali contraddittori e spesso deludenti. Il pessimo accordo raggiunto a Baku durante la COP29 rappresenta, sotto molti aspetti, il punto più basso degli sforzi multilaterali dell’ultimo decennio: i Paesi industrializzati non sono riusciti a garantire ai Paesi più vulnerabili le risorse finanziarie necessarie per decarbonizzare le loro economie e fronteggiare perdite e danni sempre più estesi.
A indebolire ulteriormente il quadro contribuisce l’atteggiamento marcatamente defilato di attori cruciali come Stati Uniti e Russia, di fatto quasi assenti dal tavolo negoziale già da qualche anno, in un contesto politico globale attraversato da retoriche negazioniste, minimizzanti o fuorvianti.
Perché le COP sono ormai incapaci di produrre risultati significativi?
L’analisi delle ultime conferenze mostra un insieme di problemi ricorrenti che non dipendono da singole presidenze o contesti politici contingenti, ma da limiti strutturali del processo negoziale. Non è un caso che, negli ultimi anni, si siano tenute sempre più spesso in parallelo al G20, al quale i leader mondiali danno chiaramente precedenza.
Ma è sempre stato così? Non proprio. Dopo la pandemia, il trend di disinteresse e di crisi delle COP ha preso una sorta di “corsia preferenziale”. Da Glasgow a Baku sono infatti emersi gli stessi nodi irrisolti che, sommati, spiegano perché questi incontri siano diventati forum capaci di produrre Dichiarazioni Finali vaghe e risultati politici limitati, spesso distanti dagli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi.
Il negazionismo climatico dilagante
Innanzitutto, a monte, occorrerebbe chiedersi come si sia giunti a un clima politico in cui sempre più leader di potenze globali bollano la crisi climatica come “una truffa”. È infatti dentro questa spirale di negazionismo retorico che prende forma la paralisi del multilateralismo climatico: dal periodo post-pandemico, e quindi dalla COP26 di Glasgow, il divario tra obiettivi scientifici e decisioni politiche è emerso in modo incontestabile, e l’impasse negoziale è diventata evidente e impossibile da ignorare.
Da quando Trump ha annunciato l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, e la Casa Bianca non invia rappresentanti di alto livello alla COP30, i principali responsabili delle emissioni globali (Cina, India e Russia) hanno seguito questo trend.
Allo stesso tempo, un numero crescente di leader internazionali ha scelto di non partecipare a questi incontri, mentre altri, come Milei, hanno ritirato la propria delegazione durante il loro svolgimento. Il G20 (che si tiene in contemporanea) è diventato la priorità per molti di questi leader, mentre le COP sono ormai percepite come negoziati “di Serie B”.
Tale assenteismo ha poi portato alcuni Paesi, come la Papua Nuova Guinea, a disertare i colloqui, definendo il meeting “una perdita di tempo” incapace di produrre risultati tangibili per i piccoli Stati insulari: una sfiducia “di riflesso” da parte di Paesi che avrebbero tutto l’interesse a rafforzare il processo multilaterale.
Su questo sfondo si sono consolidati gli annacquamenti linguistici che hanno caratterizzato le ultime conferenze: il caso più emblematico risale alla COP26 di Glasgow, quando nella versione finale del Glasgow Climate Pact il riferimento originario al phase out (uscita completa) dal carbone fu modificato all’ultimo minuto, su richiesta decisiva di India e Cina, con l’avallo di altri Paesi produttori, in phase down (diminuzione graduale).
Le conferenze successive hanno accentuato questa tendenza: alla COP27 di Sharm el-Sheikh non si era riusciti né a ripristinare il riferimento al phase out né ad estenderlo a petrolio e gas. La COP28 di Dubai aveva adottato una formula ancora più vaga, parlando di “transitioning away from fossil fuels”, un’espressione che lasciava ampio margine interpretativo e che aveva confermato la difficoltà di adottare un linguaggio coerente con la necessità di eliminare progressivamente l’impiego dei combustibili fossili.
Il paradosso del principio del consenso
È evidente come un altro degli elementi più critici della struttura delle COP sia il principio del consenso: le decisioni si adottano senza voto e solo in assenza di obiezioni esplicite.
Parliamo infatti di un meccanismo pensato per garantire inclusività che, seppur richieda l’unanimità per ogni decisione, nella pratica consegna potere di veto a un pugno di Paesi contrari, da sempre capaci di annacquare o bloccare qualsiasi avanzamento.
Anche un singolo Stato è quindi in grado di bloccare compromessi raggiunti dopo giorni di negoziato.
Va ricordato che il consenso non è mai stato formalmente codificato nel regime climatico: le Rules of Procedure della Convenzione quadro sul cambiamento climatico del 1992 non sono state approvate in via definitiva e lasciano aperta la possibilità, almeno sulla carta, di ricorrere al voto a maggioranza qualificata in caso di mancato accordo.
Eppure, nella prassi, il consenso è diventato l’unica via percorribile, cristallizzando un meccanismo che produce stalli ricorrenti e impedisce decisioni tempestive in un contesto che richiederebbe capacità di adattamento e rapidità.
A questo si aggiunge la trasformazione delle COP in eventi di dimensioni sempre più imponenti, con decine di migliaia di partecipanti, una molteplicità di iniziative parallele e un’agenda che si dilata ben oltre il negoziato vero e proprio. Il risultato è un processo dispersivo, una sorta di “fiera” in cui l’attenzione politica e mediatica si concentra spesso sugli annunci più simbolici, mentre il lavoro tecnico fatica a procedere.
L’assenza di vincoli giuridici stringenti rende poi gli impegni climatici sostanzialmente volontari, facilmente aggirabili e spesso scollegati dagli obiettivi fissati dalla scienza.
Negli ultimi anni non sono mancati tentativi di rendere il sistema più snello: per la COP30 di Belém, la presidenza brasiliana ha istituito i “COP30 Circles”, gruppi di lavoro che operano in parallelo ai negoziati ufficiali per facilitare il dialogo su temi specifici.
Ma si tratta di iniziative legate alla volontà delle singole presidenze, prive di un fondamento giuridico stabile e quindi incapaci di incidere in modo duraturo.
Finché non si affronterà la questione procedurale, questi incontri continueranno a produrre decisioni tardive, annacquate e disallineate con l’urgenza indicata dalla scienza. Non è un caso che nelle ultime COP si sia assistito alla proliferazione di accordi multilaterali settoriali (BOGA, Accordo sulla deforestazione al 2030, ecc.), evidenziando una progressiva frammentazione dell’azione climatica internazionale.
L’impasse dei fondi per il clima
A tutto questo si somma la persistente asimmetria tra Nord e Sud del mondo, irrisolta fin dai tempi di Kyoto: le economie più fragili e vulnerabili chiedono risorse, strumenti e trasferimenti tecnologici che le economie avanzate non hanno mai fornito nella misura promessa, alimentando sfiducia e tensioni diplomatiche.
La COP27 di Sharm el-Sheikh, nonostante l’importante risultato dell’istituzione del Fondo per i danni causati dal cambiamento climatico (Loss and Damage Fund, richiesto da oltre trent’anni dai Paesi vulnerabili), non era riuscita a definirne né la struttura né la governance.
Originariamente pensato come fondo di risarcimento finanziato dalle grandi economie storicamente responsabili del surriscaldamento globale, sul fronte finanziario è rimasto sostanzialmente paralizzato: i soli 768 milioni di dollari mobilitati coprono appena lo 0,2% dei bisogni annuali stimati per i Paesi vulnerabili (che oscillano tra i 100 e i 600 miliardi di dollari).
A Baku, durante la COP29, il clima di pessimismo era palpabile e l’assenza di leadership da parte delle principali economie ha ulteriormente compromesso i negoziati. La discussione sugli impegni finanziari post-2025 si è arenata di fronte alla distanza incolmabile tra risorse necessarie e disponibilità effettive.
Da oltre quindici anni i Paesi sviluppati promettono risorse che non arrivano, o arrivano in forma discontinua, imprevedibile e spesso contabilizzate in modo opaco. Anche il Green Climate Fund, che avrebbe dovuto rappresentare il principale motore finanziario per mitigazione e adattamento nei Paesi in via di sviluppo, continua a soffrire di una cronica insufficienza di capitali: i cicli di rifinanziamento procedono a rilento, alcuni Stati accumulano ritardi pluriennali nei versamenti e la capacità effettiva di sostenere progetti su larga scala è limitata da procedure lente e farraginose.
Location emblematiche e “lobbismo fossile”
Diciamocelo: cosa ci si potrebbe aspettare da conferenze ospitate in Paesi così legati all’estrazione e all’esportazione di fonti fossili? Le COP di Dubai e Baku, capitali di petrolio e gas, o quella di Sharm el-Sheikh in Egitto (Paese che, tra l’altro, viola costantemente i diritti umani) sono pessimi biglietti da visita.
Queste leadership controverse hanno aperto le porte alla crescente presenza delle lobby fossili all’interno dei negoziati, che hanno progressivamente condizionato il linguaggio e la stessa struttura del processo decisionale.
L’obbligo introdotto nel 2023 di dichiarare pubblicamente chi si rappresenta ai tavoli della conferenza ha reso visibile ciò che per anni avveniva nell’ombra: alla COP28 di Dubai sono stati registrati 2.456 lobbisti dei combustibili fossili, più delle delegazioni di molti Paesi e quasi il doppio dei rappresentanti complessivi delle dieci nazioni più vulnerabili al cambiamento climatico.
Una sproporzione che rivela il grado di permeabilità di queste conferenze agli interessi industriali e che, in alcuni casi, arriva a coinvolgere direttamente i governi.
L’Italia, ad esempio, alla COP29 di Baku, ha accreditato oltre 20 lobbisti nazionali del settore oil & gas, includendo nelle proprie delegazioni Eni, Saipem, Snam e altri soggetti i cui modelli di business restano strutturalmente dipendenti dall’espansione delle fonti fossili.
La contraddizione è evidente: gli stessi governi chiamati a stabilire calendari credibili di fuoriuscita dai combustibili fossili portano al tavolo gli attori più interessati a ritardare o diluire tali impegni. Il risultato è un processo negoziale inquinato dall’interno, in cui i termini più ambiziosi vengono sistematicamente sterilizzati, il riferimento esplicito al phase out scompare o viene diluito in formule vaghe e i testi finali si trasformano in compromessi calibrati per non disturbare chi contribuisce maggiormente alla crisi climatica.
Quale futuro per le COP?
La crisi delle Conferenze delle Parti non appare come un incidente di percorso, ma come il segnale di un logoramento profondo del multilateralismo climatico. È un sistema nato trent’anni fa, in un contesto geopolitico completamente diverso, che oggi fatica a reggere la velocità e la scala dell’emergenza.
Eppure, per quanto imperfetti, questi incontri restano l’unica arena universale in cui quasi duecento Stati possono confrontarsi su un tema che non conosce confini. Il rischio, ora, è che questa architettura perda gradualmente rilevanza senza che venga costruita un’alternativa credibile.
La COP30 di Belém arriva quindi in un momento in cui la diplomazia climatica è chiamata non solo a prendere decisioni, ma a dimostrare di essere ancora in grado di prenderle.
Se non riuscirà a colmare il divario tra scienza e politica, tra ambizioni dichiarate e strumenti reali, tra urgenza e capacità decisionale, il processo rischierà di trasformarsi definitivamente in una vetrina.