Ricordo di Milan Kundera (anche con un film)
con un suo racconto (ripreso da sagarana.net), nelle parole di Francesco M. Cataluccio e Carlos Fuentes, in un documentario (sottotitolato in italiano), su Arte.tv, e in un gran film, in italiano (tratto da Lo scherzo di Milan Kundera, per la regia di Jaromil Jires)
CHE I VECCHI MORTI CEDANO IL POSTO AI GIOVANI MORTI – Milan Kundera
1
Stava tornando a casa lungo la strada della cittadina boema dove, ormai da alcuni anni, viveva rassegnato a una vita non troppo movimentata, ai pettegolezzi dei vicini e alla monotona rozzezza che lo circondava sul lavoro, e camminava così distrattamente (come si passeggia su una strada fatta centinaia di volte) che quasi non si era accorto di lei. Lei, invece, l’aveva riconosciuto già da lontano e, andandogli incontro, lo aveva guardato con un leggero sorriso che solo all’ultimo istante, quando si erano ormai quasi superati, attivò l’impianto di segnalazione della sua memoria e lo scosse dalla sua sonnolenza.
“Non l’avevo proprio riconosciuta” si scusò, ma era una scusa stupida che li portava di colpo a un argomento increscioso del quale sarebbe stato più prudente tacere: non si vedevano da quindici anni e, nel frattempo, erano invecchiati entrambi. “Sono tanto cambiata?” gli chiese lei, e lui rispose di no e, pur trattandosi di una bugia, non era una vera bugia perché quel leggero sorriso (che esprimeva, con pudore e sobrietà, un’eterna capacità di entusiasmarsi) era giunto fin lì dalla distanza di molti anni del tutto identico, e lo aveva confuso: gli aveva fatto tornare alla memoria l’antico aspetto della donna con tanta chiarezza che dovette fare un certo sforzo per allontanarlo e vederla così com’era in quel momento: una donna già quasi anziana.
Le chiese dove stesse andando e che programmi avesse, e lei gli rispose di aver dovuto sbrigare una faccenda e che adesso aveva solo da aspettare il treno che in serata l’avrebbe riportata a Praga. Lui espresse la sua gioia per quel loro incontro inaspettato e, trovandosi entrambi d’accordo (e a piena ragione) sul fatto che i due caffè della città erano sporchi e troppo affollati, lui la invitò nel proprio monocamera non lontano da lì, dove ci sarebbero stati caffè e tè, e soprattutto pulizia e tranquillità.
2
Per lei, la giornata era andata male fin dall’inizio. Suo marito (erano già passati trent’anni da quando avevano abitato lì, appena sposati, per poi trasferirsi a Praga dove lui era morto dieci anni prima), per uno strano desiderio espresso nelle sue ultime volontà, era stato sepolto nel cimitero locale. Allora lei aveva pagato la tomba per dieci anni, ma alcuni giorni prima si era accorta con terrore che il termine era scaduto e che si era dimenticata di rinnovare la concessione. All’inizio aveva pensato di scrivere alla direzione del cimitero, ma poi, riflettendo su come siano interminabili e vani questi scambi epistolari con gli uffici amministrativi, era venuta di persona.
La strada fino alla tomba del marito la conosceva a memoria, eppure quel giorno aveva l’impressione di essere in quel cimitero per la prima volta. Non riusciva a trovare la tomba e le sembrava di essersi smarrita. Ci aveva messo un po’ di tempo per capire: lì dove prima c’era la lapide di arenaria grigia col nome del marito a lettere d’oro, proprio in quello stesso posto (aveva riconosciuto con certezza le due tombe accanto), c’era adesso una lapide di marmo nero con sopra, a lettere d’oro, un nome del tutto diverso.
Turbata, era andata negli uffici della direzione. Lì le avevano detto che, alla scadenza della concessione, le tombe venivano liquidate automaticamente. Lei li aveva rimproverati per non averla informata per tempo che doveva rinnovare la concessione, e loro per tutta risposta le avevano detto che in quel cimitero c’era poco spazio e che i vecchi morti devono cedere il posto ai giovani morti. Lei si era indignata e, trattenendo il pianto, aveva detto loro che non sapevano dove stessero l’umanità e il rispetto per l’uomo, ma poi aveva capito che era inutile discutere. Così come non aveva potuto impedire la morte del marito, era impotente anche davanti a questa sua seconda morte, questa morte di un “vecchio morto” che adesso non poteva più esistere nemmeno come morto.
Si era diretta verso il centro della città e al suo dolore avevano cominciato presto a mescolarsi il timore e la preoccupazione di come spiegare al figlio la scomparsa della tomba del padre e giustificare davanti a lui la propria dimenticanza. Alla fine le era caduta addosso la stanchezza: non sapeva come passare le lunghe ore prima della partenza del treno, perché lì non conosceva più nessuno, e non c’era nulla che la spingesse a una passeggiata sentimentale, perché in tutti quegli anni la città era troppo cambiata, e i luoghi un tempo noti le mostravano ora un volto totalmente estraneo. Accettò quindi con gratitudine l’invito del vecchio conoscente (semidimenticato) incontrato per caso: poté lavarsi le mani in bagno e sedersi poi in una morbida poltrona (le facevano male le gambe), esaminare la stanza e ascoltare, oltre la tenda che separava la stanza dall’angolo cottura, il gorgoglio dell’acqua messa a bollire per il caffè.
3
Lui aveva compiuto da poco trentacinque anni, e proprio allora si era improvvisamente accorto che sulla sommità del cranio i capelli avevano cominciato molto visibilmente a diradarsi. Non era ancora la calvizie, ma già la si poteva immaginare benissimo (sotto i capelli si intravedeva la pelle), peggio ancora, appariva del tutto sicura e imminente. Certo, è ridicolo trasformare il diradarsi dei capelli in un problema esistenziale, ma lui si era reso conto che, con la calvizie, sarebbe mutato anche il suo viso, e che quindi la vita di uno dei suoi aspetti (ed evidentemente il migliore) era sul punto di terminare.
E gli erano venute alla mente tristi considerazioni su un possibile bilancio di quel suo aspetto (capelluto) che lo stava abbandonando, un bilancio di ciò che aveva realmente vissuto e fatto, e lo paralizzava la consapevolezza di aver fatto ben poco; quando ci pensava, sentiva di arrossire; sì, si vergognava: perché vivere così a lungo sulla terra e avere così poche esperienze è una cosa vergognosa.
Che cosa intendeva esattamente, quando diceva di aver avuto poche esperienze? Si riferiva ai viaggi, al lavoro, a un’attività pubblica, allo sport, alle donne? Naturalmente si riferiva a tutte queste cose insieme, ma soprattutto alle donne perché, se in altri campi la sua vita era povera, certo se ne rammaricava, ma non doveva dare la colpa necessariamente a se stesso: non poteva farci nulla se il suo lavoro era noioso e senza prospettive; non poteva farci nulla se per viaggiare non aveva né i soldi né il beneplacito della sezione quadri; e infine non poteva farci nulla se a vent’anni si era rotto il menisco e aveva dovuto rinunciare agli sport che gli piacevano. In compenso, il regno delle donne era per lui un regno di relativa libertà, e perciò qui non aveva scusanti; qui poteva far sfoggio di tutta la sua ricchezza; le donne erano diventate per lui l’unico vero criterio per misurare la densità della propria vita.
Il guaio era che neanche con le donne gli era andata molto bene: fino ai venticinque anni (pur essendo un bel ragazzo) era stato bloccato dalla tremarella; poi si era innamorato, si era sposato e per sette anni aveva cercato di convincersi che in un’unica donna era possibile trovare l’infinito dell’erotismo; poi aveva divorziato, l’apologetica della monogamia (e l’illusione dell’infinito) si era dissolta e, al suo posto, era sopravvenuta una piacevole e audace voglia di donne (della variegata finitezza del loro numero), purtroppo però fortemente frenata da una cattiva situazione economica (doveva pagare all’ex moglie gli alimenti per un figlio che aveva il permesso di vedere una o due volte all’anno) e dalle condizioni di vita di una piccola città dove la curiosità dei vicini è tanto smisurata quanto è esiguo il numero delle donne a disposizione.
Poi il tempo era passato molto velocemente e, all’improvviso, si era ritrovato in bagno davanti allo specchio ovale sopra al lavandino: con la mano destra teneva alto sulla testa uno specchietto tondo e osservava inebetito la calvizie incipiente; di colpo (senza preavviso) quella vista lo aveva posto di fronte alla banale verità che non è possibile recuperare ciò che abbiamo perso. Si era ritrovato addosso un cattivo umore cronico e gli erano venute anche idee di suicidio. Naturalmente (ed è necessario sottolinearlo, per non vedere in lui un isterico o uno sciocco) si rendeva conto della loro comicità e sapeva bene che non le avrebbe mai messe in atto (aveva riso tra sé della propria lettera di commiato: Non potevo rassegnarmi alla calvizie. Addio!), ma è sufficiente che idee simili, anche se platoniche, gli siano potute venire. Cerchiamo di capirlo: si facevano sentire in lui un po’ come in un maratoneta si fa sentire l’irresistibile desiderio di abbandonare la gara quando, a metà percorso, è sicuro che ormai perderà ignominiosamente (e anzi, per colpa sua, per errori suoi). Anche lui considerava persa la propria gara e non aveva più voglia di correre.
E adesso si chinava sul tavolinetto basso e posava una tazzina di caffè davanti al divano (dove poi si sedette lui stesso), poi mise la seconda tazza davanti alla comoda poltrona occupata dall’ospite, e intanto si ripeteva che c’era una particolare malignità nell’aver incontrato questa donna, di cui un tempo era stato follemente innamorato e che aveva perso (per colpa sua, per errori suoi), proprio in un simile stato d’animo, quando ormai non era più possibile rimediare a nulla.
4
Lei non avrebbe mai immaginato di apparirgli come quella che gli era sfuggita; rivedeva sempre la notte passata assieme, ricordava il suo aspetto di allora (aveva vent’anni, non sapeva vestirsi, arrossiva e la divertiva con quei suoi modi da adolescente), e ricordava anche se stessa (allora aveva quasi quarant’anni e un certo desiderio di bellezza la spingeva tra le braccia di sconosciuti, ma allo stesso tempo la allontanava da loro; perché aveva sempre immaginato che la propria vita dovesse assomigliare a una bella danza, e aveva paura di trasformare le proprie infedeltà coniugali in un’orribile abitudine).
Si, si era imposta la bellezza come la gente si impone dei comandamenti morali; se nella sua vita avesse visto la bruttezza, sarebbe caduta nella disperazione. E adesso, conscia del fatto che dopo quindici anni doveva necessariamente apparire vecchia agli occhi del suo ospite (con tutte le bruttezze che ciò comporta), volle aprire in fretta davanti al viso un ventaglio immaginario, e lo investì perciò con una serie di domande incalzanti: gli chiese com’era capitato lì; gli chiese del suo lavoro; elogiò la gradevolezza del suo appartamentino, la vista dalla finestra sui tetti della città (gli disse che, certo, non era niente di speciale, ma ispirava un senso di ariosità, di libertà); nominò gli autori di alcune riproduzioni di impressionisti incorniciate alle pareti (non fu difficile: erano le stesse riproduzioni a buon mercato che certo troverete sempre negli appartamenti degli intellettuali cechi senza soldi), poi si alzò addirittura dalla poltrona e, con la tazzina in mano, si curvò su una piccola scrivania dove c’era un portaritratti con alcune fotografie (non le sfuggì il fatto che tra di esse non ci fosse nessuna foto di giovane donna), e chiese se il viso di donna anziana in una foto fosse quello di sua madre (lui rispose di sì).
Lui a sua volta le domandò a che cosa avesse alluso quando, al momento del loro incontro, aveva parlato di “una faccenda” da risolvere in città. Lei non aveva nessuna voglia di parlare del cimitero (lì, al quinto piano, si sentiva non solo al di sopra dei tetti, ma anche piacevolmente al di sopra della propria vita); ma, alle sue dirette insistenze, finì per confessare (con estrema concisione, essendole sempre stata estranea la spudoratezza di una sincerità avventata) che aveva abitato in quella città molti anni prima, che lì era sepolto suo marito (della scomparsa della tomba tacque) e che da dieci anni veniva sempre lì con il figlio il giorno dei morti.
5
“Tutti gli anni?” Questa scoperta lo rattristò, e di nuovo rifletté sulla malignità della cosa; se l’avesse incontrata sei anni prima, quando si era trasferito in quella città, forse sarebbe stato ancora possibile salvare ogni cosa: lei non sarebbe stata così segnata dall’età e il suo aspetto non sarebbe stato così diverso dall’immagine della donna che lui aveva amato quindici anni prima; sarebbe stato ancora nelle sue forze superare la differenza e vedere le due immagini (quella passata e quella presente) come un’immagine sola. Adesso, invece, erano disperatamente lontane.
Lei aveva finito di bere il caffè, parlava, e lui cercava di stabilire con precisione la misura di quel suo mutamento, che gliela faceva sfuggire per la seconda volta: il viso si era coperto di rughe (inutilmente lo strato di cipria cercava di negarlo); il collo era avvizzito (inutilmente il colletto alto cercava di nasconderlo); le guance erano cascanti; i capelli (ma questo era quasi bello!) si erano fatti grigi; ciò che più attirava la sua attenzione erano però le mani (che purtroppo né la cipria né il rossetto possono migliorare): su di esse erano affiorate trecce di vene azzurrine che le avevano trasformate in mani maschili.
Il rimpianto si mescolò in lui alla rabbia e gli venne voglia di annegare nell’alcol il ritardo di quell’incontro; le chiese se non avesse voglia di un cognac (nell’armadietto al di là della tenda c’era una bottiglia iniziata); lei gli rispose di no, e a lui tornò in mente che anche quindici anni prima lei non beveva, forse proprio perché non voleva che l’alcol togliesse ai suoi modi una misuratezza di buon gusto. E quando vide il gesto delicato della mano col quale rifiutava l’offerta del cognac, si rese conto che in lei quel fascino del buon gusto, l’incanto e la grazia che un tempo l’avevano rapito erano sempre gli stessi, anche se nascosti sotto la maschera dell’età, e sempre così seducenti anche se prigionieri dietro una robusta grata.
L’idea che lei fosse imprigionata dietro la grata dell’età lo riempì di una pietà immensa, e questa pietà gliela riavvicinò (quella donna un tempo abbagliante, davanti alla quale la sua lingua era legata) ed ebbe voglia di chiacchierare con lei come con un’amica, a lungo, nell’azzurrognola malinconia della rassegnazione. E davvero incominciò a parlare (e persino a lungo), e alla fine arrivò a toccare quelle idee pessimistiche che negli ultimi tempi lo assalivano. Tacque, naturalmente, dell’incipiente calvizie (come del resto lei aveva taciuto della scomparsa della tomba); la visione della calvizie si trasformò però in sentenze semifilosofiche su come il tempo corra più veloce dell’uomo, su quanto sia terribile la vita, poiché in essa tutto porta già il segno dell’inevitabile dissoluzione, e in sentenze analoghe sulle quali si aspettava dalla sua ospite un’eco partecipe; ma aspettò invano.
“Sono discorsi che non mi piacciono” disse lei quasi bruscamente. “Tutto ciò che lei dice è tremendamente superficiale”.
6
Non le piacevano i discorsi sull’invecchiamento e sulla morte perché implicavano quella bruttezza fisica che le ripugnava. Ripeté più volte al proprio ospite, quasi arrabbiata, che quel suo modo di pensare era superficiale; l’uomo, diceva, è qualcosa di più che un semplice corpo che deperisce, l’essenziale è l’opera dell’uomo, ciò che egli lascia quaggiù per gli altri. Non era da oggi che difendeva quel concetto; le era venuto in aiuto per la prima volta trent’anni prima, quando si era innamorata del suo futuro marito, più vecchio di lei di diciannove anni; non aveva mai smesso di stimarlo sinceramente (al di là di tutte le infedeltà che peraltro lui o non conosceva o non voleva conoscere) e aveva cercato di convincere se stessa che l’intelligenza e il valore del marito compensavano interamente il pesante fardello dei suoi anni.
“Ma quale opera, la prego! Quale opera lasciamo qui?” protestò il padrone di casa con un sorriso amaro.
Lei non volle chiamare in causa il marito morto, pur credendo fermamente nel valore duraturo di tutto ciò che egli aveva fatto; si limitò perciò a dire che ogni uomo quaggiù crea una qualche opera, foss’anche la più modesta, e che in essa e soltanto in essa è il suo valore; poi prese a parlare di sé, del suo lavoro in una casa della cultura alla periferia di Praga, delle conferenze e delle serate di poesia che organizzava, parlò (con un’enfasi che a lui parve eccessiva) dei “visi riconoscenti” del pubblico; e subito dopo si mise a spiegare com’è bello avere un figlio e vedere i propri tratti (il figlio le assomigliava) trasformarsi in un viso di uomo, e com’è bello dargli tutto ciò che una madre può dare a un figlio e poi scomparire in silenzio dietro alla sua vita.
Non era stato un caso se si era messa a parlare del figlio, perché quel giorno il figlio continuava a tornarle in mente e a ricordarle con rimprovero l’insuccesso del mattino al cimitero; era strano; non aveva mai permesso a nessun uomo di imporle la propria volontà, e suo figlio invece l’aveva imbrigliata senza che lei neppure sapesse come. In effetti, quel giorno l’insuccesso al cimitero l’aveva scossa così tanto soprattutto perché si sentiva colpevole davanti a lui e temeva i suoi rimproveri. Naturalmente, già da molto aveva il sospetto che, se il figlio sorvegliava così gelosamente il modo in cui la madre rispettava la memoria di suo padre (era infatti proprio lui che insisteva ogni anno, il giorno dei morti, perché non dimenticassero di andare al cimitero!), ciò non dipendeva tanto dall’amore verso il padre morto, quanto piuttosto dal desiderio di terrorizzare la madre, di relegarla nei debiti confini della vedovanza; perché era così, anche se lui non l’aveva mai riconosciuto e lei aveva cercato (senza successo) di ignorarlo: gli ripugnava l’idea che la madre potesse avere ancora una sua vita sessuale, gli ripugnava tutto ciò che in lei (anche come possibilità, come virtualità) restava di sessuale; e poiché l’idea della sessualità è legata all’idea della giovinezza, al figlio ripugnava tutto ciò che in lei ancora rimaneva di giovanile; non era più un bambino, e l’aria giovanile della madre (unita all’aggressività delle sollecitudini materne) gli intralciava spiacevolmente i rapporti con la giovinezza delle ragazze che avevano cominciato a interessarlo; voleva avere una madre vecchia, solo da una madre così avrebbe potuto sopportare l’amore, solo una madre così lui avrebbe potuto amare. E lei, pur rendendosi conto a volte che in tal modo il figlio la spingeva verso la tomba, alla fine gli si era sottomessa, aveva capitolato sotto la sua pressione e aveva persino idealizzato quella capitolazione, convincendosi che la bellezza della sua vita era proprio in quella silenziosa scomparsa dietro un’altra vita. In nome di questa idealizzazione (senza la quale, del resto, le rughe del viso le avrebbero bruciato molto di più) discuteva ora col suo ospite con un ardore così inaspettato.
Ma il suo ospite si protese all’improvviso sul tavolino che li separava, le carezzò una mano e disse: “Perdoni i miei discorsi. Lo sa che sono sempre stato uno sciocco”.
7
La loro discussione non l’aveva irritato, anzi, la visitatrice gli aveva confermato una volta di più la sua identicità; nella sua protesta contro i discorsi pessimistici (ma non era forse soprattutto una protesta contro la bruttezza e il cattivo gusto?) lui aveva riconosciuto la donna che conosceva, e la sua mente si riempì ancor di più dell’antica immagine di lei e della loro antica storia, ed egli desiderò solo una cosa, che nulla spezzasse quell’azzurra atmosfera così favorevole alla conversazione (per questo le aveva accarezzato la mano e si era definito uno sciocco), desiderò poterle raccontare ciò che in quel momento gli sembrava la cosa più importante: la loro avventura comune; era infatti convinto di aver vissuto con lei qualcosa di molto particolare, una cosa che lei nemmeno immaginava e per la quale con grande sforzo lui avrebbe cercato le parole precise.
Non ricordava neanche più in che modo l’avesse conosciuta, doveva essere capitata un giorno nel suo gruppo di compagni di università, ma il piccolo e sperduto caffè praghese dove si erano visti da soli per la prima volta, quello se lo rammentava bene: sedeva di fronte a lei nel séparé felpato, angosciato e silenzioso, ma allo stesso tempo inebriato dai leggeri segnali con cui lei gli manifestava il suo favore. Aveva cercato poi di immaginare (pur non azzardandosi a sperare nella realizzazione delle proprie fantasie) quello che avrebbe fatto quando lui l’avesse baciata, spogliata e amata, ma non c’era riuscito. Si, era strano: aveva cercato migliaia di volte di immaginarsela mentre faceva l’amore, ma inutilmente: il suo volto lo guardava sempre con lo stesso leggero sorriso tranquillo, e lui non riusciva (nemmeno sforzando al massimo la fantasia) a deformare quel volto con la smorfia dell’esaltazione amorosa. Lei si sottraeva totalmente alla sua fantasia.
Era stata una situazione che non si era mai più ripetuta nella sua vita: quella volta si era trovato faccia a faccia con l’inimmaginabile. Era evidentemente appena uscito da quel brevissimo periodo della vita (un periodo paradisiaco) in cui l’immaginazione non è ancora sufficientemente satura di esperienza, non è prigioniera della routine, le sue conoscenze e le sue capacità sono limitate, per cui ancora esiste l’inimmaginabile; e quando l’inimmaginabile è sul punto di trasformarsi in realtà (senza la mediazione dell’immaginabile, senza il ponticello delle immagini), l’uomo è in trappola e viene preso dalla vertigine. Una vertigine simile lo aveva davvero colto quando, dopo una serie di altri incontri durante i quali non era mai riuscito a decidersi a nulla, lei aveva cominciato con eloquente curiosità a fargli domande precise sulla sua camera alla casa dello studente, quasi obbligandolo a invitarvela.
La cameretta che divideva con un compagno, il quale in cambio di un bicchierino di rum gli aveva promesso di tornare dopo mezzanotte, somigliava poco al monocamera di oggi: due letti di ferro, due sedie, un armadio, un’accecante lampadina senza paralume, un disordine terribile. La riordinò e, alle sette (faceva parte della sua eleganza essere puntuale), lei bussò alla porta. Era settembre e cominciava lentamente a imbrunire. Si sedettero sul bordo del letto di ferro e si baciarono. Poi si fece sempre più buio, e lui decise di non accendere la luce, perché era contento che lei non potesse vederlo e sperava che il buio alleggerisse l’imbarazzo quando si sarebbe spogliato davanti a lei. (Se ancora ancora se la cavava a sbottonare la camicetta alle donne, davanti a loro si spogliava con una fretta piena di vergogna). Quella volta, però, esitò a lungo prima di slacciarle il primo bottone (gli sembrava che per iniziare a spogliare una donna dovesse esistere una tecnica raffinata ed elegante, nota solo agli uomini esperti, e temeva di tradire la propria inesperienza), e alla fine fu lei ad alzarsi e a domandare con un sorriso:
“Non è meglio che mi tolga questa corazza?…”, e cominciò a spogliarsi; ma era buio e lui vedeva solo le ombre dei suoi movimenti. Si spogliò anche lui precipitosamente e ritrovò una certa sicurezza solo quando (grazie alla pazienza di lei) cominciarono a fare l’amore. Lui la guardava in viso, ma nella penombra non riusciva a cogliere la sua espressione e non distingueva nemmeno i suoi lineamenti. Gli dispiaceva che fosse buio, ma gli sembrava assurdo alzarsi in quel momento e andare alla porta a girare l’interruttore, sicché continuò inutilmente a sforzare gli occhi: ma non la riconosceva; gli sembrava di far l’amore con qualcun altro; con una persona falsa o con una persona totalmente astratta e priva di individualità.
Poi lei gli si mise sopra (e anche allora di lei vedeva solo l’ombra eretta) e, agitando i fianchi, gli disse qualcosa a bassa voce, bisbigliando, ma non era chiaro se stesse parlando a lui o solo a se stessa. Non distinguendo le sue parole, lui le chiese di ripeterle. Lei gli bisbigliò ancora qualcosa, ma lui, anche quando la strinse di nuovo a sé, non riuscì a capire.
8
Ascoltava il suo ospite sempre più presa da particolari da tempo dimenticati: ad esempio, che quel giorno portava un tailleur celestino di un leggero tessuto estivo che, diceva lui, la faceva apparire intoccabile come un angelo (sì, ora ricordava quel tailleur), oppure che aveva, infilato nei capelli, un grande pettine d’osso che, diceva lui, le dava un’aria aristocratica e all’antica, o che al caffè ordinava sempre un tè al rum (sua unica concessione ai vizi dell’alcol), e tutto ciò la trasportava piacevolmente lontano dal cimitero, lontano dalla tomba scomparsa, lontano dalle piante dei piedi indolenzite, lontano dalla casa della cultura e lontano dagli occhi pieni di rimprovero del figlio. Ecco, le venne da pensare, anche se oggi sono come sono, io non ho vissuto invano se un pezzo della mia giovinezza continua a vivere in quest’uomo; e subito dopo pensò che questa era l’ennesima conferma della sua idea: il valore di un uomo è nella sua capacità di superare se stesso, di uscire da sé, di essere negli altri e per gli altri.
Lo ascoltava e non si opponeva quando lui, di tanto in tanto, le accarezzava la mano; quelle carezze si fondevano con l’umore dolce della conversazione e avevano in sé una disarmante indefinitezza (a chi appartenevano? alla donna della quale si parlava o alla donna alla quale si parlava?); del resto, l’uomo che l’accarezzava le piaceva; si diceva persino che le piaceva più del ragazzo di quindici anni prima, i cui modi adolescenti, se ben ricordava, erano stati un po’ fastidiosi.
Quando giunse, nel suo racconto, al momento in cui l’ombra di lei si ergeva dimenandosi sopra di lui e lui cercava vanamente di capire i suoi sussurri, egli tacque un istante e lei (ingenuamente, come se lui conoscesse quelle parole e volesse ricordargliele dopo tanti anni come un segreto dimenticato) chiese piano: “E cosa dicevo?”.
9
“Non lo so” rispose lui. Non lo sapeva; lei quella volta era sfuggita non solo alla sua immaginazione ma anche ai suoi sensi; era sfuggita alla sua vista e al suo udito. Quando nella cameretta della casa dello studente lui aveva acceso la luce, lei era già vestita, tutto in lei era nuovamente levigato, splendido, perfetto, e lui cercò invano un legame tra il suo viso illuminato e il viso che un istante prima intuiva nel buio. Quello stesso giorno, non si erano ancora separati che già lui la richiamava alla memoria; si sforzava di immaginare che aspetto avessero avuto il suo viso (invisibile) e il suo (invisibile) corpo un istante prima, mentre facevano l’amore. Ma senza successo; lei continuava a sottrarsi alla sua fantasia.
Si ripromise la prossima volta di fare l’amore in piena luce. Solo che non ci fu più nessuna prossima volta. Da allora lei lo aveva evitato con abilità e tatto, e lui era caduto preda dell’incertezza e della disperazione: certo, era stato bello fare l’amore, ma sapeva anche quanto lui fosse stato un disastro prima e se ne vergognava; ora, in quel suo evitarlo, sentiva una condanna e non osò più insistere per raggiungerla.
“Mi dica, perché da quella volta cominciò a evitarmi?”
“La prego,” disse lei con voce tenerissima “è una cosa di tanto tempo fa, come posso saperlo…”, e alle sue insistenze dichiarò: “Non dovrebbe tornare sempre sul passato. Basta già tutto il tempo che siamo costretti a dedicargli contro la nostra volontà”. L’aveva detto solo per respingere in qualche modo le sue insistenze (e forse l’ultima frase, detta con un leggero sospiro, si riferiva alla visita della mattina al cimitero), ma nella sua dichiarazione lui percepì qualcosa di diverso: come se quelle parole avessero dovuto bruscamente e intenzionalmente chiarire (il fatto evidente) che non c’erano due donne (quella di una volta e quella di oggi), ma una sola e unica donna, e che questa donna, che quindici anni prima gli era sfuggita, adesso era lì, era a portata di mano.
“Ha ragione, il presente è più importante” disse con un’intonazione significativa e fissandole il viso, dove la bocca socchiusa in un sorriso lasciava intravedere una bianca fila di denti; in quel momento gli balenò un ricordo: quella volta nella cameretta della casa dello studente lei si era messa in bocca le sue dita e gliele aveva morse fino a fargli male, e intanto lui le tastava tutto l’interno della bocca; e ancor oggi ricordava che da un lato, in fondo, le mancavano tutti i denti superiori; (la cosa allora non l’aveva infastidito, anzi, quella piccola imperfezione faceva parte di quella sua età che lo affascinava e lo eccitava). Adesso, però, guardando lo spiraglio che si apriva tra i denti e l’angolo della bocca, vide che i denti erano straordinariamente bianchi e non ne mancava nessuno, e ne fu scombussolato: ancora una volta le due immagini si staccavano l’una dall’altra, ma lui non voleva permetterlo, voleva con tutte le sue forze farle nuovamente coincidere, e perciò disse: “Davvero non ha voglia di un cognac?”, e quando lei, con un sorriso pieno di fascino e sollevando leggermente le sopracciglia, scosse la testa, andò dietro la tenda, prese la bottiglia del cognac, l’avvicinò alle labbra e bevve velocemente. Poi pensò che lei avrebbe potuto riconoscere dall’alito il suo comportamento segreto, prese perciò due bicchierini, la bottiglia, e portò il tutto nella stanza. Di nuovo lei scosse la testa. “Almeno simbolicamente” disse lui riempiendo i due bicchieri. Poi brindò: “Perché io parli di lei solo al presente!”. Vuotò il bicchiere, lei si bagnò appena le labbra, lui le si sedette accanto sull’orlo della poltrona e le prese la mano.
10
Quand’era andata nel suo appartamentino, lei non immaginava che si sarebbe potuti giungere a quel tipo di contatto, e in un primo momento provò paura; come se quel contatto fosse arrivato prima che lei avesse avuto modo di prepararsi (aveva perso già da tempo quello stato di preparazione permanente, conosciuto dalla donna matura); (in questa paura potremmo forse trovare qualcosa della paura di un’adolescente che riceve il primo bacio, perché, se la fanciulla non è ancora pronta e lei non è più pronta, questo “più” e questo “ancora” sono segretamente legati insieme, così come sono legate le stranezze della vecchiaia e dell’infanzia). Poi lui la fece passare dalla poltrona al divano, la strinse a sé, le accarezzò tutto il corpo e lei nelle sue mani si sentì informe e molle (sì, molle: perché già da tempo il suo corpo era stato abbandonato da quella sovrana sensualità che dona prontamente alla muscolatura il ritmo delle contrazioni e dei rilassamenti e l’attività di cento movimenti delicati).
L’attimo di paura presto si dileguò nelle sue carezze e lei, ormai lontana dalla bella donna matura che era stata un tempo, ritornava ora ad essa con velocità vertiginosa, ritornava alla sua vanità, alla sua coscienza, e ritornava all’antica certezza della donna eroticamente esperta; e poiché era una certezza a lungo non provata, la sentì ora molto più intensamente di quanto non le fosse mai accaduto; il suo corpo, un istante prima ancora sorpreso, spaventato, passivo, molle, riprese vita, ora rispondeva all’ospite con le proprie carezze, e lei sentiva la precisione e la sapienza di quelle carezze e se ne beava; quelle carezze, il modo in cui appoggiò il viso sul corpo di lui, i movimenti delicati con i quali il suo busto rispondeva all’abbraccio, tutto ciò lei non lo ritrovava affatto come qualcosa di semplicemente appreso, qualcosa che lei sapeva e che ora eseguiva con fredda soddisfazione, ma come qualcosa di connaturato in cui lei si confondeva con ebbrezza e con passione, come se quella fosse stata una terra familiare, la terraferma (ah, la terraferma della bellezza!), da dove era stata bandita ma dove ora faceva il suo trionfale ritorno.
Suo figlio era adesso infinitamente lontano; certo, quando l’ospite l’aveva afferrata, lo aveva scorto, come un ammonimento, in un angolo della mente, ma poi era subito scomparso, e a perdita d’occhio non erano rimasti che lei e l’uomo che l’accarezzava e l’abbracciava. Ma quando lui posò la sua bocca su quella di lei e con la lingua cercò di aprirle le labbra, in quel momento tutto all’improvviso si capovolse: si ridestò. Strinse forte i denti (sentiva l’amara estraneità della dentiera, premuta contro il palato, e aveva la sensazione che le riempisse tutta la bocca), poi lo allontanò con dolcezza e gli disse: “No. Davvero, la prego, meglio di no”.
E poiché lui insisteva, lo afferrò per i polsi e ripeté il proprio rifiuto; poi gli disse (le era difficile parlare, ma sapeva di doverlo fare se voleva che lui le desse retta) che era tardi per fare l’amore; gli ricordò la propria età; se avessero fatto l’amore, lui avrebbe provato disgusto per lei e lei sarebbe stata disperata perché ciò che lui le aveva raccontato di loro due era per lei infinitamente bello e importante; il suo corpo era mortale e si sarebbe consumato, ma lei ora sapeva che di esso sarebbe rimasto qualcosa di immateriale, qualcosa di simile a un raggio che splende anche quando la stella è spenta; che importava invecchiare, se la sua giovinezza si era conservata intatta in un altro! “Lei ha costruito dentro di sé il mio monumento. Non dobbiamo permettere che venga distrutto. Cerchi di capirmi” si difese. “Non deve. No, non deve”.
11
Lui le assicurò che era ancora bella, che in realtà nulla era cambiato, che una persona rimane sempre la stessa, ma sapeva di ingannarla e che era lei ad aver ragione: conosceva bene la propria ipersensibilità alle cose fisiche, il proprio ribrezzo, sempre più forte di anno in anno, per i difetti esteriori del corpo femminile, che negli ultimi tempi lo aveva rivolto a donne sempre più giovani e quindi, come si rendeva conto amaramente, anche più vuote e più stupide; sì, non c’era alcun dubbio: se l’avesse costretta all’amore fisico, tutto sarebbe finito nel disgusto, e quel disgusto avrebbe poi schizzato di fango non solo l’istante presente, ma anche l’immagine della donna un tempo amata, l’immagine conservata nella memoria come un gioiello.
Lo sapeva bene, ma non erano che pensieri, e i pensieri non significano nulla di fronte al desiderio, che conosceva un’unica realtà: la donna la cui inaccessibilità e inimmaginabilità di allora lo aveva tormentato per quindici interi anni, quella donna era lì, finalmente poteva vederla in piena luce, finalmente nel suo corpo di oggi poteva leggere il suo corpo di allora, nel suo viso di oggi il suo viso di allora. Finalmente avrebbe potuto leggere la sua (inimmaginabile) mimica, il suo spasimo, nel momento dell’amore.
La prese tra le braccia e la guardò negli occhi: “Non cerchi di resistermi. E’ insensato cercare di resistere”.
12
Lei però scosse il capo, perché sapeva che non era insensato resistergli, perché conosceva bene gli uomini e il loro comportamento verso il corpo femminile, sapeva bene che in amore anche il più ardente idealismo non avrebbe privato la superficie del corpo del suo terribile potere; certo, lei aveva ancora una bella figura, che aveva conservato le sue proporzioni originali e, soprattutto vestita, mostrava un aspetto molto giovanile, ma sapeva che, nel momento in cui si sarebbe spogliata, avrebbe messo a nudo le rughe del collo e avrebbe svelato la lunga cicatrice di un’operazione allo stomaco subita dieci anni prima.
E a mano a mano che ritornava in lei la coscienza del proprio aspetto fisico attuale, dal quale un attimo prima era riuscita a fuggire, dalle profondità della strada salivano alla finestra della stanza (che fino ad allora le era sembrata a un’altezza sicura sopra la sua vita) le angosce della mattina, inondavano la stanza, si posavano sulle riproduzioni sottovetro, sulla poltrona, sul tavolo, sulla tazzina vuota del caffè, e sul loro corteo dominava il viso del figlio; quando lo vide, arrossì e si rifugiò in se stessa: che ingenua! era stata lì lì per fuggire dal percorso che lui le aveva fissato e lungo il quale lei aveva fino ad ora camminato col sorriso sulle labbra e con discorsi entusiasti, era stata (almeno per un istante) lì lì per fuggire, e adesso doveva docilmente ritornare e riconoscere che quello era l’unico percorso che le si addicesse. Il viso del figlio era così beffardo che lei, nella sua vergogna, si sentiva diventare sempre più piccola davanti a lui, fino a ridursi, umiliata, alla sola cicatrice che aveva sullo stomaco.
Il suo ospite la teneva per le spalle ripetendole:
“È insensato cercare di resistermi”, e lei scuoteva il capo, ma del tutto meccanicamente, perché davanti agli occhi non aveva l’ospite ma i propri tratti giovanili sul viso del figlio-nemico che lei tanto più odiava quanto più si sentiva piccola e umiliata. Lo udiva rimproverarle la scomparsa della tomba, e allora in lei, dal caos della memoria, spuntò illogica una frase che gli gettò rabbiosamente in faccia: Ragazzo, i vecchi morti devono cedere il posto ai giovani morti!
13
Lui non poteva dubitare minimamente del fatto che tutto sarebbe finito nel disgusto, se già adesso lo stesso sguardo che posava su di lei (uno sguardo penetrante e indagatore) non era privo di un certo disgusto, ma lo strano era che ciò non gli dava fastidio, anzi, lo infervorava e lo eccitava, come se lui quel disgusto lo cercasse; il desiderio di sesso si avvicinava in lui al desiderio di disgusto; il desiderio di leggere finalmente sul corpo di lei ciò che così a lungo non aveva potuto conoscere si univa al desiderio di svalutare immediatamente ciò che aveva letto.
Da cosa nasceva quel desiderio? Che se ne rendesse o no conto, gli veniva offerta un’occasione unica: la sua ospite rappresentava per lui tutto ciò che non aveva avuto, ciò che gli era sfuggito, ciò che lui aveva mancato, tutto ciò che con la propria assenza gli rendeva così insopportabile la sua età di oggi, con i capelli sempre più radi e quel bilancio disperatamente magro; e lui, che se ne rendesse conto o ne avesse soltanto un vago sentore, adesso poteva privare di significato e di colore tutte queste gioie che gli erano state negate (perché era proprio la loro terribile ricchezza di colori a rendere così tristemente incolore la sua vita), poteva smascherare la loro nullità, il loro essere mere apparenze destinate a scomparire, nient’altro che ingannevole polvere, poteva vendicarsi di loro, umiliarle, distruggerle.
“Non mi resista!” ripeteva cercando di stringerla a sé.
14
Lei continuava a vedere davanti agli occhi il viso beffardo del figlio, e quando il suo ospite la strinse a sé con forza, disse: “La prego, mi lasci un istante” e si divincolò da lui; non voleva infatti interrompere il corso dei propri pensieri: i vecchi morti devono cedere il posto ai giovani morti e i monumenti non servono a nulla, così come non serviva a nulla quel suo monumento che l’uomo che le stava accanto aveva venerato per quindici anni nella propria mente, e non serve a nulla nemmeno il monumento del marito, sì, ragazzo, tutti quei monumenti non servono a nulla, diceva tra sé al figlio e con la soddisfazione della vendetta guardava il suo viso contrarsi e urlare: “Mamma, non avevi mai parlato così!”. Certo, sapeva bene di non aver mai parlato così, ma quell’istante era pieno di una luce che rendeva diverse tutte le cose.
Non ha alcun motivo per dare la precedenza ai monumenti rispetto alla vita; il suo monumento ha per lei un unico significato: poterne abusare in quell’istante a vantaggio del proprio corpo ignorato; l’uomo che le siede accanto le piace, è giovane ed è probabilmente (anzi, quasi sicuramente) l’ultimo uomo che le piaccia o che lei possa avere; ed è questa l’unica cosa importante; e se poi lui proverà disgusto per lei e abbatterà il suo monumento dentro di sé, ciò è indifferente, perché quel monumento è fuori di lei, così come sono fuori di lei la mente e la memoria di quell’uomo, e tutto ciò che è fuori di lei è indifferente. “Mamma, non avevi mai parlato così!” sentì gridare il figlio, ma non vi prestò attenzione. Sorrideva.
“Ha ragione. Perché dovrei resistere?” disse piano e si alzò. Poi cominciò lentamente a sbottonarsi il vestito. La sera era ancora lontana. Questa volta la stanza era piena di luce.
(Tratto dalla raccolta di racconti Amori ridicoli, Adelphi, Milano, 1988)
http://www.sagarana.it/rivista/numero17/narrativa2.html
Milan Kundera: l’idillio segreto – Carlos Fuentes
Nel dicembre del 1968 tre latino-americani infreddoliti scesero da un treno per ritrovarsi nell’immortalità di Praga. Nel tragitto fra Parigi e Monaco di Baviera, Cortàzar, Garcia Màrquez e io avevamo parlato molto di letteratura poliziesca e consumato delle quantità eroiche di birra e di salsicce. Quando stavamo per arrivare a Praga, un silenzio spettrale ci invitò a esserne partecipi.
Non vi è una città più bella in Europa. A cavallo fra l’alto gotico e il secolo barocco, la sua opulenza e la sua tristezza furono consumate dalle nozze fra le pietre e il fiume. Come il personaggio di Proust, Praga si dovette conquistare l’aspetto che oggi esibisce. E difficile tornare a Praga; è impossibile dimenticarla. Ed è naturale: vi abitano troppi fantasmi.
Le sue finestre incutono spavento; è la capitale delle defenestrazioni. Guardandole, vediamo ancora cadere e poi esalare il loro ultimo respiro sul selciato liscio e umido di Malà Strana e Palazzo Cernín i riformatori ussiti e gli agitatori boemi; i nazionalisti del XX secolo e quei comunisti che non trovarono il loro secolo. Il nostro secolo, infatti, non è stato quello di Dubcèk, ma quello dei due Masaryk. Fra il Golem e Gregorio Samsa, fra il gigante e lo scarafaggio, il destino di Praga si protende come il Ponte Carlo sulla Moldava: carico di fatalità scultoree, di commendatori barocchi che forse attendono il ritorno dell’incantesimo interrotto per voltarsi, parlare, maledire, ricordare, scappare dal “maleficio di Praga”. Qui Mozart diede la sua prima rappresentazione del Don Giovanni, l’oratorio della sacra maledizione e della burla profana sconfitte dalla grazia; da qui fuggirono Rilke e Werfel; qui visse Kafka. Qui ci aspettava Milan Kundera.
Se la storia ha un senso…
Avevo conosciuto Milan nella primavera di quello stesso anno, una primavera che avrebbe avuto un solo nome, quello della città. Venne a Parigi per la presentazione de Lo scherzo e fu accolto calorosamente da Claude Gallimard e Aragon, che scrisse la prefazione per l’edizione francese di quel romanzo che “spiega ciò che è inspiegabile”. Il poeta francese soggiungeva: “Bisogna leggere questo romanzo. Bisogna credere in ciò che narra”.
Mi fu presentato da Ugné Karvelis che, dall’inizio degli anni ’60, affermava che i due poli più importanti della narrativa contemporanea si trovavano nell’America Latina e nell’Europa Centrale. No, non nell’Europa Orientale; Kundera fece un salto quando utilizzai questa espressione. Non avevo forse visto una carta geografica del continente? Praga si trova al centro, non a est dell’Europa; l’oriente europeo si trova in Russia, nella Bisanzio moscovita, nel cesaro-papismo, nello zarismo e nell’ortodossia.
La Boemia e la Moravia sono dei punti focali in più di un senso: sono le terre delle prime sommosse moderne contro la gerarchia oppressiva, terre dove fu scelta l’eresia nel senso originale di libertà di scelta personale; sono dei fori critici, delle frettolose zone di transito nel corso delle fasi dialettiche: dove baroni furono vinti da principi, principi da mercanti, mercanti da commissari, commissari da cittadini eredi della triplice e perpetrata eredità della modernità: la rivoluzione intellettuale, la rivoluzione industriale e la rivoluzione nazionale.
Questo triplice dono aveva conferito un contenuto al golpe comunista del 1948: la Cecoslovacchia era matura per passare dal regno della necessità a quello della libertà. I commissari del Cremlino e i satrapi locali, con tutta la loro conoscenza, non si resero conto che nelle terre ceche e slovacche la democrazia sociale poteva sorgere dalla società civile e mai dalla tirannia burocratica. Per il fatto di averlo ignorato, per un atto di servilismo rivolto al modello sovietico, per altro già criticato da Gramsci che parlò della mancanza di una società autonoma in Russia, la Cecoslovacchia si ritrovò stretta dalle catene del terrore stalinista, con le sue delazioni, i processi contro i compagni calunniati, le esecuzioni dei comunisti del domani effettuate dai comunisti di ieri.
Se la storia ha un senso, Dubcek e i suoi compagni comunisti si incaricarono di darglielo: a partire dal gennaio del 1968, all’interno della macchina politica e burocratica del comunismo ceco, questi uomini fecero un passo che, ironicamente, nel compimento di quelle promesse fondamentali dell’ortodossia marxista, rendeva inutili le sue costruzioni formali. Se era vero (e lo era, e lo è) che il socialismo ceco non fu il prodotto del sottosviluppo famelico di una frettolosa capitalizzazione atta a rimpiazzare la stoltezza politica, ma di uno sviluppo industriale capitalistico, soddisfacente dal punto di vista politico ed economico, allora era anche vero (e lo è, e lo sarà) che il passo da fare sarebbe stato quello di permettere la graduale scomparsa dello Stato a mano a mano che i gruppi sociali assumevano le loro funzioni autonome. La società sociali-sta iniziò a occupare gli spazi della burocrazia comunista. La pianificazione centrale cedette delle iniziative ai consigli operai e il politburo di Praga alle organizzazioni politiche locali. Venne presa una decisione fondamentale: in tutti i livelli del partito, la democrazia si sarebbe espressa attraverso il suffragio segreto.
Questa disposizione democratica irritò sicuramente l’Unione Sovietica al di là di ogni immaginazione. Nulla fu rimproverato con maggiore acrimonia dai governanti russi a Dubcek. Per compiere il primo passo verso la democrazia, i comunisti cechi vollero anticipare il loro Congresso. Il paese era politicamente decentrato ma democraticamente unito da un fatto straordinario: la comparsa di una stampa rappresentativa dei gruppi sociali. Una stampa dei lavoratori agricoli, degli operai dell’industria, degli studenti, dei ricercatori scientifici, degli intellettuali e degli artisti, dei piccoli commercianti, degli stessi giornalisti, di tutti e di ognuno dei componenti attivi della società ceca. Nella democrazia socialista di Dubcek e dei suoi compagni, le iniziative dello Stato nazionale venivano commentate, completate, criticate e limitate dall’informazione dei gruppi sociali; a loro volta, questi prendevano delle iniziative che erano oggetto di commenti e di critiche da parte della stampa ufficiale. Questa stessa moltiplicazione di poteri e di pareri all’interno del comunismo doveva essere trasferita al parlamento; prima di tutto, era necessario stabilire la democrazia nel partito. E questo è ciò che 1’URSS non era disposta ad accettare.
Le idi di agosto
Kundera ci diede appuntamento in una sauna in riva al fiume per raccontarci ciò che era accaduto a Praga. Sembrava che fosse uno di quei pochi luoghi in cui i muri non avevano orecchie. Cortàzar preferì rimanere nell’ostello universitario dove eravamo stati alloggiati; aveva trovato una doccia su misura, senza dubbio disegnata dal suo omonimo Verne e degna di ornare la dimora sottomarina del Capitano Nemo: una cabina di vetro a chiusura ermetica, che aveva più rubinetti del Nautilus e dotata di getti obliqui e verticali all’altezza di testa, spalle, vita e ginocchia. Un siffatto paradiso dell’idroterapia diventava saturo e pericoloso a una data altezza: quella di uomini di statura normale come Garcia Màrquez ed io. Soltanto Cortàzar, con i suoi due metri e oltre, poteva goderselo davvero senza affogare.
Invece, nella sauna dove ci aspettava Kundera, non c’era la doccia. Dopo una mezz’ora di sudore, chiedemmo di fare un bagno nell’acqua fredda. Fummo condotti in direzione di una porta. Questa si apriva sul fiume ghiacciato. Un buco aperto nel ghiaccio ci invitava a calmare il nostro disagio e a riattivare la circolazione. Milan Kundera ci spinse dolcemente alla rovina. Viola come certe orchidee, noi, che provenivamo da Barranquilla e da Veracruz, ci immergemmo in quelle acque nemiche della nostra essenza tropicale.
Milan Kundera, ridendo a crepapelle, si stagliava come un gigante slavo con uno di quei volti che si vedono soltanto oltre il fiume Oder, gli zigomi alti e duri, il naso all’insù, i capelli corti che abbandonavano la bionda gioventù per entrare nei bianchi territori della quarantina, un misto di pugile e asceta, un incrocio fra Max Schmelling e il papa polacco Giovanni Paolo II, con un fisico da taglialegna o da scalatore di montagne, le mani di ciò che è, uno scrittore, le mani di ciò che fu suo padre, un pianista. Gli occhi sono quelli di tutti gli slavi: grigi, mutevoli, improvvisamente ridenti, come adesso mentre ci vede trasformati in statue di ghiaccio, o improvvisamente cupi, in quel passaggio folgorante da un sentimento a un altro che è la caratteristica dell’anima slava, crocevia di passioni. Lo vidi ridere; lo immaginai come una figura leggendaria, come un antico cacciatore dei monti Tatra, sovraccarico di pelli strappate agli orsi per somigliare di più a loro.
Senso dell’umorismo e tristezza: Kundera e Praga. Rabbia e pianto? Certamente. I russi erano ben voluti a Praga; erano i liberatori del 1945, i vincitori del satanismo hitleriano. Come capire che ora entravano con i loro carri armati a Praga per schiacciare i comunisti in nome del comunismo, quando avrebbero dovuto celebrare il trionfo del comunismo ceco in nome dell’internazionalismo socialista? Come capirlo? Rabbia; una ragazza offre un mazzo di fiori a un soldato sovietico in cima a un carro armato; il soldato si avvicina alla ragazza per baciarla; la ragazza gli sputa in faccia. Stupore: “Dove siamo?”, si chiedono molti soldati sovietici. “Perché ci ricevono così, con sputi, insulti e barricate di fuoco, se veniamo a salvare il comunismo da un complotto imperialista?” “Dove siamo?” si domandano i soldati asiatici. “Ci avevano detto che andavamo a soffocare un’insurrezione in una repubblica sovietica, ma dove siamo? Dove?” “Noi che viviamo tutta la nostra vita in funzione dell’avvenire” come dice Aragon.
Dove? C’è rabbia, c’è anche senso dell’umorismo, come negli occhi di Kundera. I treni sono strettamente sorvegliati; le truppe dei rinforzi provenienti dall’Unione Sovietica che arrivavano a bordo di questi treni, fischiettano, marciano, girano in tondo e finiscono per ritornare al confine da dove erano partite. La resistenza contro l’invasione viene organizzata attraverso le comunicazioni via radio; l’esercito sovietico dovrà affrontare uno scherzo gigantesco: gli scambisti deviano i treni militari, i camion bellici seguono delle segnaletiche sbagliate poste sulle strade principali, le radio della resistenza ceca sono irreperibili.
Il buon soldato Sc’vèik si trova alla testa delle manovre contro l’invasore e l’invasore s’innervosisce. Il maresciallo Gretchko, comandante delle forze del Patto di Varsavia, ordina inutilmente di sparare sulla facciata del Museo Nazionale di Praga; i cittadini della patria di Kafka lo chiamano il murale di El Gretchko. Un soldato asiatico, che non le ha mai viste, si schianta contro le porte a vetri di un negozio della metropolitana di piazza San Venceslao; in seguito a questo episodio, i cechi collocheranno un cartello con la scritta: “Niente può fermare il soldato sovietico”. Le truppe russe fanno la loro entrata di notte a Marienbad, dove un cinema all’aperto sta proiettando un film western; sentendo gli spari di Gary Cooper, i soldati si precipitano nella platea e sparano contro lo schermo. Gary Cooper continua a camminare nella strada di un villaggio ferito a morte dalle pallottole di un amaro scherzo. Gli spettatori di Marienbad trascorrono una brutta nottata, ma, il giorno dopo, come in Il valzer degli addii di Kundera, ritornano a fare la cura delle acque.
Aragon accende la radio il 21 di agosto e ascolta la condanna delle “nostre illusioni perpetue”. Con lui, quella stessa notte, tutti abbiamo appreso che, in nome dell’aiuto fraterno, “la Cecoslovacchia è stata fatta sprofondare negli abissi della schiavitù”.
Il mio amico Milan
Fummo invitati dall’Unione degli Scrittori Cechi in quello strano periodo che va dall’autunno del 1968 alla primavera decisiva, quella del 1969. Sartre e Simone de Beauvoir si erano recati a Praga e così pure Nathalie Sarraute e altri romanzieri francesi. Credo che vi andarono anche Grass e Bòll. Si trattava di fingere che non era successo niente; che anche se le truppe sovietiche si erano accampate nelle vicinanze di Praga e i loro carri armati si nasconde-vano nei boschi, il governo di Dubcek poteva ancora salvare qualcosa, non arrendersi alla propria sconfitta e trionfare con la comica perseveranza del soldato Sc’vèik.
Noi, come latino-americani, avevamo tutte le prerogative per parlare di imperialismi, di invasioni, di Davide e Golia; potevamo difendere, con la legge in una mano e la storia nell’altra, il principio del non intervento. Concedemmo un’intervista collettiva su questi argomenti alla rivista letteraria «Listy», che all’epoca era diretta dal nostro amico Antonin Liehm. Fu l’ultima intervista che apparve nell’ultimo numero della rivista. Non parlammo di Breznev in Cecoslovacchia, ma di Johnson nella Repubblica Dominicana.
Continuò a nevicare nei giorni che trascorremmo a Praga. Acquistammo dei berretti e degli stivali. Cortàzar e Garcia Màrquez, due melomani pari-menti infervorati, si disputavano le registrazioni delle opere di Janàcek; Kundera ci mostrò degli spartiti originali del grande musicista ceco che si trovavano fra le carte di suo padre, il grande pianista. In sua compagnia, mangiammo cinghiale e knedlíky in salsa bianca, bevemmo slivowitz e gettammo le basi di un’amicizia che, per me, è cresciuta nel tempo.
Fin da allora condividevo, e condivido sempre più con il romanziere ceco, una certa visione del romanzo quale elemento indispensabile, eppure non immolabile, della cultura che un ceco e un messicano possono avere in comune: un modo di dire le cose che altrimenti non potrebbero essere dette. In seguito, parlammo a lungo di questo argomento a Parigi, a Nizza, a La Renaudière, quando si trasferì con sua moglie Vera in Francia, dove stabilì la sua nuova residenza, visto che nel suo paese “normalizzato” i suoi romanzi non potevano essere pubblicati né letti.
Si può ridere amaramente: la grande letteratura di una lingua fragile e stretta d’assedio nel cuore dell’Europa deve essere scritta e pubblicata al di fuori dei suoi confini. Il romanzo, un genere presumibilmente agonizzante, è vivo al punto da essere assassinato. Il sublime cadavere deve essere proibito perché è un cadavere pericoloso. “Il romanzo è indispensabile all’uomo quanto il pane”, dice Aragon nella sua introduzione all’edizione francese de Lo scherzo. Perché? Perché in esso si troverà la chiave di ciò che lo storico, il mitografo trionfante, ignora o dissimula.
“Il romanzo non è minacciato dall’esaurimento” dice Kundera “ma dallo stato ideologico del mondo contemporaneo. Non vi è nulla che si opponga maggiormente allo spirito del romanzo, profondamente legato alla scoperta della relatività del mondo, quanto la mentalità totalitaria, che si consacra all’instaurazione di un’unica verità”.
Colui che l’afferma scriverebbe, per opporsi a un’ideologia, dei romanzi di un’ideologia contraria? Assolutamente no. Borges dice che il Corano è un libro arabo perché i cammelli non sono mai menzionati. Il critico Elizabeth Pochoda fa notare che la longevità dell’oppressione politica è testimoniata nei romanzi di Kundera perché non è mai menzionata.
Condannare il totalitarismo non crea la qualità di un romanzo, dice Kundera. Ciò che gli sembra interessante, invece, è la somiglianza fra il totalitarismo e “il sogno immemorabile e affascinante di una società armoniosa in cui la vita privata e quella pubblica formano un solo nucleo e tutti gravitano attorno a una stessa volontà e a una stessa fede. Non è un caso che il genere prediletto, all’epoca culminante del totalitarismo, fosse l’idillio”.
La parola ormai è stata detta e nessuno se l’aspettava. Questa parola è uno scandalo. E molto comodo nascondersi dietro alla grottesca definizione dell’arte di Stalin: “Di contenuto socialista e forma nazionale”. E molto divertente e molto amaro (lo scherzo amaro costituisce certamente l’universo di Kundera) tradurre questa definizione in termini pragmatici, come spiega un critico praghese a Philip Roth: il realismo socialista consiste nello scrivere l’elogio del governo e del partito in modo tale che persino il governo e il partito lo capiscano.
Lo scandalo, la verità insospettata, è quella che sentiamo dalle labbra di Milan Kundera: il totalitarismo è un idillio.
L’idillio
Idillio è il nome del vento costante, violento e terribile che attraversa le pagine dei libri di Milan Kundera. E la prima cosa che dobbiamo capire. E il tiepido respiro della nostalgia e il bagliore tempestoso della speranza: gli occhi di ghiaccio di entrambi i movimenti, quello che ci conduce a riconquistare l’armonioso passato delle origini e quello che ci promette la perfetta beatitudine nell’avvenire, si fondono in uno solo, il movimento della storia. Soltanto l’azione della Storia saprebbe offrirci, contemporaneamente, la nostalgia di ciò che siamo stati e la speranza di ciò che saremo. Il problema, ci dice Kundera, è che fra questi due movimenti in procinto di diventare uno solo, la storia ci impedisce, molto semplicemente, di essere noi stessi nel presente. Il commercio della storia consiste nel “vendere alla gente un futuro in cambio di un passato”.
Nella sua famosa conferenza all’Università di Jena, nel 1789, Schiller pretese il futuro subito. Nello stesso anno dello scoppio della Rivoluzione Francese, il poeta respinse la minaccia di una promessa perpetuamente rimandata per poter essere una menzogna senza possibilità di verifica: di conseguenza, una verità, promessa sempre a spese della pienezza del presente. Il secolo dell’Illuminismo consumò la secolarizzazione del millenarismo giudeo-cristiano e, per la prima volta, trovò l’età dell’oro, non soltanto sulla terra, ma nel futuro. Dal più antico sciamano indiano a Don Chisciotte, da Omero a Erasmo, tutti insieme riuniti attorno allo stesso fuoco pastorale, il tempo del paradiso era il passato. A partire dall’ironico ideologo del progresso illimitato, Condorcet, l’idillio ha soltanto un tempo: il futuro. Sulle sue promesse si basa il mondo industriale dell’Occidente.
L’apporto di Marx ed Engels consiste nel riconoscere che l’uomo non vive di solo futuro. Il luminoso avvenire dell’umanità, sciolto dall’Illuminismo da ogni vincolo con un passato definito barbaro e irrazionale dai suoi filosofi, consiste, secondo il comunismo, anche nella restaurazione dell’idillio origina-le, dell’armonia paradisiaca della proprietà comune, del paradiso corrotto dalla proprietà privata. In questo senso, vi sono poche utopie più belle di quella descritta da Engels nell’introduzione alla Dialettica della natura.
Il capitalismo e il comunismo condividono la visione del mondo come un mezzo diretto a quella meta che si confonde con la felicità. Ma se il capitalismo procede per la via della frantumazione, convinto che il miglior modo di dominare è isolare, polverizzare e accrescere le necessità e le soddisfazioni ugualmente artificiali degli individui che hanno maggiori necessità e che si accontentano in funzione del loro stesso isolamento, il comunismo, in realtà, procede per la via dell’integrazione totale.
Quando il capitalismo cercò di salvarsi utilizzando dei metodi totalitari, mobilitò le masse, mise loro degli stivali, delle uniformi e una svastica sul braccio. L’apparato del fascismo violò le premesse operative del capitalismo moderno, i cui padrini, l’uno nella teoria e l’altro nella pratica, furono John Maynard Keynes e Franklin Delano Roosevelt. E difficile combattere un sistema che precede sempre se stesso, anticipando le critiche con più concretezza di quella subito permessa al più severo dei suoi avversari. Ma questo stesso sistema sarà privo della forza di seduzione di una dottrina che rende esplicito l’idillio, che promette tanto la restaurazione dell’antica Arcadia quanto la costruzione dell’Arcadia del futuro. I sogni totalitari hanno acceso l’immaginazione di parecchie generazioni di giovani: in modo diabolico, quando l’idillio aveva raggiunto la sua apoteosi nella cavalcata del Walhalla wagneriano e nelle legioni operistiche del nuovo Scipione; in modo angelico, quando poteva suscitare la fede di Romain Rolland e di André Malraux, di Stephen Spender, W.H. Auden e André Gide. Solo un camionista ubriaco o una zitella inacidita combatterebbero, invece, a pugni e a ombrellate per un’Arcadia così sbiadita come quella rappresentata dal “sogno americano”.
I personaggi di Kundera ruotano attorno a questo dilemma: fare o non fare parte del sistema dell’idillio assoluto, l’idillio per tutti, senza eccezioni o lacune, idillio proprio perché non ammette più niente e nessuno che metta in dubbio il diritto di tutti alla felicità in un’unica Arcadia, paradiso dell’origine e paradiso del futuro? Non un semplice idillio, sottolinea Kundera in uno dei suoi racconti, bensì un idillio per tutti, poiché: “Da sempre tutti gli esseri umani aspirano all’idillio, a quel giardino in cui cantano gli usignoli, a quel regno dell’armonia in cui il mondo non si erge alienato contro l’uomo e l’uomo contro gli altri uomini, ma dove l’uomo e gli uomini sono, al contrario, fatti di una stessa materia e dove il fuoco che splende nelle stelle è lo stesso che illumina le anime. Lì ognuno è una nota in una sublime fuga di Bach e colui che non voglia esserlo diventa un punto nero privo di senso che è sufficiente afferrare e schiacciare sotto un’unghia come una pulce”.
E proprio come una pulce, Milan Kundera, l’altra K. della Cecoslovacchia, non ha certo bisogno di ricorrere a nessuna forma allegorica per provocare le sensazioni di stranezza e di disagio con cui Franz Kafka inondò di ombre luminose un mondo che già esisteva senza saperlo. Adesso il mondo di Kafka sa di esistere. I personaggi di Kundera non hanno più bisogno di svegliarsi trasformati in insetti perché la storia dell’Europa centrale si è incaricata di dimostrare loro che un uomo non ha davvero bisogno di essere un insetto per essere trattato come tale. Ciò che è peggio, i personaggi di Milan K. vivono in un mondo dove tutte le caratteristiche della metamorfosi di Franz K. si mantengono inalterate, con una sola eccezione: Gregor Samsa, lo scarafaggio, non crede più di sapere, ora sa di credere.
Adesso egli ha una forma umana, si chiama Jaromil ed è un poeta.
Il santo bambino di Praga
Durante la Seconda guerra mondiale, il padre di Jaromil ha perso la vita in nome di un valore assoluto reale: proteggere una persona, salvarla dalla delazione, dalla tortura e dalla morte. Quella persona era l’amante del padre di Jaromil. La madre del poeta, invece, prova una totale ripugnanza nei confronti dell’animalità fisica così come suo marito la prova nei confronti dell’animalità morale e lo tradisce non per sensualità ma per innocenza.
Quando il padre muore, la madre esce dal regno dei morti con suo figlio fra le braccia. Lo attenderà all’uscita della scuola sotto un grande ombrello. Incarnerà la bellezza della tristezza allo scopo di indurre suo figlio a formare con lei una coppia intoccabile: quella di una madre e di un figlio, amanti frustrati, che incarnano la protezione assoluta in cambio della rinuncia suprema.
Quella stessa cosa Jaromil esigerà prima dall’amore, in seguito dalla rivoluzione e infine dalla morte: un dono totale in cambio di una protezione assoluta. E un sentimento feudale, simile a quello che il servo offriva al suo signore. Jaromil crede che si tratta di un sentimento poetico, che gli permette di collocarsi non “al di fuori dai limiti della sua esperienza, ma molto al di sopra”.
E, così, riuscire a vedere tutto. E a essere visto. I messaggi del volto, gli sguardi enigmatici attraverso una serratura scambiati con la ragazza di nome Magda che si trova in una vasca da bagno (altrettanto enigmatica del contatto dei piedi di Julien Sorel e di Madame Renal sotto il tavolo), la lirica del corpo, della morte, delle parole, della città, degli altri poeti (Rimbaud, Majakóvskij, Wolker) costituiscono il repertorio poetico originale di Jaromil. Non vuole allontanarlo dalla sua vita; vuole essere, come Rimbaud, il giovane poeta che vede tutto ed è visto nella sua totalità prima di diventare invisibile e completamente cieco. L’assoluto o il nulla: questo pretende dall’amore della ragazza dai capelli rossi. Se non sarà assoluto è meglio che non sia. Quando l’amante non gli promette tutta la sua vita, Jaromil spera nella totalità della morte, e, quando l’amante non gli promette la morte, ma la tristezza, la ragazza dai capelli rossi cessa di avere un’esistenza reale, corrispondente all’interiorità assoluta del poeta: il tutto o il nulla, la vita o la morte.
L’assoluto o il nulla: questo esige da sua madre al di là delle amare e folli aspettative della donna che vorrebbe essere l’amante frustrata di suo figlio. Tuttavia l’ampio e ambiguo repertorio del ricatto materno assolutista si scompone in troppe emozioni parziali, fatte di pietà e di rimproveri, di speranza, di collera, di seduzione. La madre del poeta, e Kundera ci dice che “nella casa dei poeti, regnano le donne”, non può essere Giocasta, e diventa Gertrude, la quale crede che dando tutto al figlio questi continui a ricambiarla fino a pagare l’impossibile, vale a dire, tutto. Jaromil non sarà Edipo, ma Amleto: il poeta che vede in sua madre non il valore assoluto che tanto ricerca, bensì la limitatezza che uccide.
Nella pagina più bella di quella meraviglia della narrativa che è La vita è altrove (nel capitolo 13 della terza parte), Kundera colloca Jaromil “nel paese della tenerezza, che è il paese dell’infanzia artificiale”: “La tenerezza nasce nel momento in cui, rigettati sulla soglia dell’età adulta, ci si rende conto con angoscia dei vantaggi dell’infanzia, vantaggi che da bambini non si potevano capire […] La tenerezza è il tentativo di creare uno spazio artificiale in cui valga il patto di trattarsi l’un l’altro come bambini […] La tenerezza è anche paura delle conseguenze fisiche dell’amore, è tentativo di sottrarre l’amore al mondo degli adulti […] e di considerare la donna come una bambina”.
È questa tenerezza impossibile che Jaromil, il poeta, non troverà né in sua madre né nella sua amante, entrambe intrise dell’amore “insidioso, costrittivo, permeato di carnalità e di responsabilità” tipico dell’età adulta, sia questo l’amore della donna verso il suo amante poeta o quello della madre verso suo figlio ormai cresciuto. E questo l’idillio introvabile negli esseri umani che Jaromil cercherà e troverà nella rivoluzione socialista: ha bisogno dell’assoluto per essere un poeta, così come Baudelaire, per esserlo, aveva bisogno “di sentirsi eternamente ebbro… di vino, di poesia o di virtù, a piacimento”...
QUI il documentario su Arte.tv
LA LEZIONE DI MILAN KUNDERA – Francesco M. Cataluccio
https://it.gariwo.net/editoriali/la-lezione-di-milan-kundera-26419.html
https://www.youtube.com/watch?v=MrwfaUZZwRg&ab_channel=CinemaSepolto

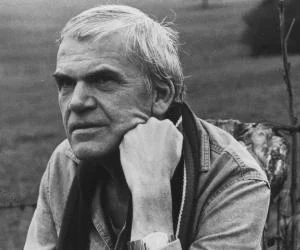

Un lettore ci scrive: «Grazie per l’ottimo “mix”. Siccome il mondo è strano (e smemorato) avrei sottolineato un passaggio mediatico significativo: in Italia all’epoca dell’uscita di “Insostenibile leggerezza…” certamente Kundera aveva un suo piccolo pubblico che però si moltiplicò in pochi giorni quando in tv Renzo Arbore cominciò a fare un tormentone con quel titolo».
Bellissimo il racconto di Kundera “Che i vecchi morti cedano il posto ai giovani morti”! Grazie di avermelo fatto conoscere!
Marcella Pepe
non lo conoscevo neanch’io, ma frugando un quel forziere di tesori che è sagarana.it si trovano tante cose molto belle
“Kundera era una spia”
CLAUDIO GUIDI – Il Messaggero
14 Ottobre 2008
Ad oltre mezzo secolo di distanza Milan Kundera è chiamato a fare i conti con un oscuro e grave episodio della sua vita, quando nel 1950 denunciò alla polizia politica ceca un giovane anticomunista, rientrato clandestinamente a Praga, che in seguito alla delazione dello scrittore subì una condanna a 22 anni di reclusione, scontandone quattordici.
A fare la clamorosa rivelazione è la Frankfurter Allgemeine Zeitung che ha avuto accesso alle ricerche condotte da un giovane storico ceco, Adam Hradilek, pubblicate dalla rivista ceca Respekt. Hradilek è un ricercatore dell’Istituto praghese per lo studio dei regimi totalitari, l’istituzione ceca che conserva l’intero archivio della polizia politica e dei servizi segreti dell’ex Cecoslovacchia. Il documento che inchioda lo scrittore, privato a suo tempo della cittadinanza ceca e rifugiatosi in Francia dopo la Primavera di Praga del 1968, era rimasto ben sepolto negli archivi ed era sfuggito perfino all’attenzione dello spionaggio interno ceco che, se lo avesse individuato lo avrebbe senza dubbio utilizzato per screditare lo scrittore.
Il 14 marzo 1950 Milan Kundera, all’epoca studente presso la Facoltà di Arti Cinematografiche di Praga, alle quattro del pomeriggio entra nella sesta stazione di polizia della capitale e denuncia un giovane anticomunista ceco, Miroslav Dvoracek, appena rientrato in patria dalla Germania per organizzare una rete di informatori su incarico dello spionaggio americano. Dvoracek aveva chiesto a Iva Militka, una studentessa fidanzata con un suo amico, di ospitarlo nella sua camera alla Casa dello Studente e la ragazza aveva acconsentito, dopo aver informato il suo ragazzo di non andare a pernottare da lei quella sera a causa dell’ospite inatteso.
Il fidanzato di Iva aveva rivelato la notizia all’amico Kundera, che si era subito affrettato a fare la spiata alla polizia, con il risultato che Dvoracek veniva arrestato la sera stessa. Il verbale contenente la delazione di Kundera porta il numero 624/1950-II e lo storico che lo ha portato alla luce lo ha inviato per fax a Parigi all’autore della “Insostenibile leggerezza dell’essere”, che si è subito difeso: «Sono assolutamente sconcertato da una cosa inaspettata della quale ancora ieri non ero al corrente e che non è mai accaduta. Io quell’uomo non lo conoscevo. Questa notizia mi coglie di sorpresa».
Ma il fronte di sostegno allo scrittore sembra già incrinarsi: «È stato uno shock, non era una cosa abituale fra gli scrittori» azzarda Ivan Klima, autore di “Amore e spazzatura” e vecchio amico di Kundera «non me lo sarei mai aspettato». Fra le motivazioni che avrebbero indotto lo scrittore a denunciare Dvoracek ci sarebbe stato il desiderio di ingraziarsi le autorità ceche, presso le quali era caduto in disgrazia in seguito a critiche poco ortodosse da lui espresse nei confronti del regime comunista. A giocare un ruolo decisivo sarebbe stato il timore dello scrittore di venire espulso dalla Facoltà di Cinema, che poi riuscì a frequentare fino alla laurea, mentre due suoi amici altrettanto compromessi quanto lui vennero invece espulsi. E Klima conferma: «La sua potrebbe essere stata una presa di coscienza. O forse avrà temuto di essere espulso, di perdere dei privilegi.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung sottolinea anche un’altra singolare coincidenza, riguardante la pubblicazione nel 1963 del volume di racconti di Kundera “Amori ridicoli”, avvenuta proprio dopo che Dvoracek aveva finito di scontare i 14 anni di lavori forzati in una miniera di uranio. L’uomo infatti è sempre stato convinto che a denunciarlo alla polizia fosse stata Iva Militka, la ragazza che lo aveva accolto, ma di fronte all’evidenza del documento venuto alla luce quel grave episodio di delazione assume adesso ben altri risvolti.
Il giornale sottolinea che Kundera non poteva ignorare le conseguenze della sua spiata, poiché in quei mesi i giornali cechi erano pieni delle notizie con le condanne dei cosiddetti «traditori e agenti dell’imperialismo», venti dei quali erano stati impiccati, mentre altri 480 avevano ricevuto pesantissime condanne comprese tra dodici anni di reclusione e l’ergastolo.
Per il monumento nazionale ceco, considerato un apostolo morale, ma lontano dall’esempio di un Vaclav Havel che ha subito cinque anni di carcere comunista, da drammaturgo dissidente, per la sua ferma opposizione al regime, sarebbe una disfatta senza precedenti. Un finale inglorioso dopo essersi affermato come difensore della libertà contro ogni tipo di regime e costrizione politica e ideologica. I primi a impossessarsi della storia sono stati Hradilek e i giornalisti della rivista ceca Respekt, che ne hanno subito capito la portata sconvolgente. Ora la fotocopia della denuncia n° 624/1950 inchioda Kundera ormai travolto dal sospetto e dal fango di un’azione ignominiosa: «Da allora mi sento in colpa di aver parlato con lui tra amici» assicura Iva Militka «ero troppo ingenua».
Il paradosso è che Dvoracek, che dal ’68 vive in Svezia e due mesi fa ha avuto un ictus, è stato sempre convinto della responsabilità della donna e sua moglie fa sapere che «oggi non ha alcuna importanza sapere chi lo denunciò». Kundera vive a Parigi e scrive in francese. Da 25 anni non concede interviste, arriva a Praga in incognito, e ha fatto promettere ai suoi amici di non parlare mai di lui. Forse con qualche motivo.