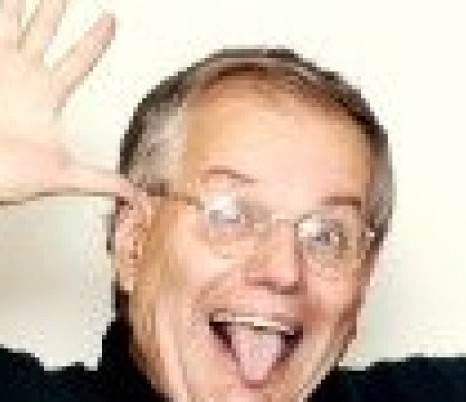«Non mi sono fatto niente»
riflessioni di Giuliano Spagnul sul libro di Maurizio Gibertini.
Ho iniziato la lettura del libro di Maurizio “Gibo” Gibertini (Settanta Milieu) appena uscito in libreria nel marzo 2025. Un senso di irritazione me l’ha fatto interrompere a un quarto delle 320 pagine che lo compongono.
Non l’ho detto a Gibo; anche se vecchio è grande e grosso, e non si sa mai! Però l’ho ripreso a fine estate e l’ho finito d’un fiato. I ripensamenti, quando positivi, sono sempre sorprese gradite. Non voglio indulgere troppo sul perché di quella prima irritazione ma forse posso stigmatizzarla in quella frase di Fabio Zeta, nella sua breve recensione, in cui ringrazia Gibo per aver comunque “vissuto alla grande” (1).
A una lettura superficiale (non me ne voglia Zeta) ci sono cascato anch’io; questo libro trasuda di “folle voglia di vita e di rivolta, del comunismo qui e ora”. Ma non è questo il comunismo, che sia qui e ora o lontano in un tempo indefinito. Quello vero e reale è quello ben rappresentato da Gian Maria Volonté nel finale del Sospetto di Citto Maselli, in cui, da militante comunista, risponde al commissario fascista che nell’interrogarlo gli rivela che è stato usato dai suoi stessi compagni (dal partito) come esca sacrificabile per altri fini da quelli a lui dichiarati: «ma io lo sapevo, l’ho sempre saputo!».
La “causa”: ciò che sta sopra di noi e ci trascende e ci rende parte del disegno della Storia, di quel disegno (che si vorrebbe laico) che va ad occupare quel posto lasciato libero dall’ormai vetusto disegno di Dio. Al riguardo, molto meglio del sottoscritto, lo spiega Antonio Caronia in un sofferto conflitto con la propria storia e i propri ideali di militante trozkista (2).
Ma è rispetto a Gibo e alla sua scrittura che si rischia una lettura, lo ripeto, superficiale. Il carattere “splatter” del racconto, come con acutezza lo interpreta Gaetano Grasso non rimane legato al solo periodo di carcerazione “in quel sadico teatro dell’assurdo” (3) ma si estende a tutto questo Bildungsroman che di formativo ha ben poco o nulla e non può servire per “capire chi si è” quanto piuttosto, e già sarebbe molto, capire chi non si è. E qui lo splatter, paradossalmente, aiuta e tocca ogni momento e vicissitudine della storia: è splatter lo scontro fisico o armato con l’avversario, così come la comprensione del nemico fascista “combattente scaltro, con una caratura da malavitoso” Riccardo Manfredi che muore in un rocambolesco tentativo di evasione e per questo merita “un fiore sulla tomba” (pag. 59).
È splatter l’abbondanza di sangue che qui, tra scontri e pestaggi, abbonda; ma è splatter anche lo sperma che pure abbonda nelle innumerevoli scopate, compulsive e, verrebbe da dire, macchiniche nella loro asciutta descrittività. E che altro modo ci sarebbe stato per esemplificarle al meglio se non buttarle lì nella loro stringente e necessaria pulsione di vita che si oppone alla morte.
E, se posso concedermi una digressione personale, mi verrebbe da accomunare qui quanto scrisse nei suoi diari la mia compagna Marisa Bello in occasione della morte di una comune amica il cui funerale si sarebbe svolto a Venezia, sua città d’origine:
«Ho sonno, stamattina Giuliano è partito alle sei per Venezia per il funerale di Luci. Ieri non sono riuscita a pensare ad altro… Venezia e la morte. Le gondole lugubri e quel cimitero in mezzo al mare. La presenza di quei ricordi era talmente forte da essere quasi allucinata nelle immagini così piene di tanta realtà. Avrei voluto star sola tanto erano forti quelle immagini ma ancora non ne sono capace, in maniera a volte scontata resto con Giuliano e come ogni volta che ci ha sfiorato la morte di altri facciamo l’amore. Poi lui parte ed io resto sola a guardare la vita con sempre più stupore. Da sola metto fuoco meglio me stessa e sempre me ne stupisco».
Mi viene da domandarmi chissà cosa hanno pensato ed eventualmente scritto nei rispettivi diari le compagne (e non) di quel “lo infili dentro, godi e fai vento come tutti i maschi del cazzo” (pag. 133). Gibo non si sottrae, non abbellisce la sessualità spinta, quanto sporca, che trasuda tutto il suo raccontarsi “come un lungo rap mitragliato senza mai riprendere fiato” (4).
Anche questo, in fondo, è un diario; solo che scritto postumo: dopo le tante morti del suo autore. Tra la voglia di vivere e il desiderio di lasciarsi andare, in questo mettere a nudo il corpo come “teatro di tensioni, tra autodistruzione e vitalità, tra umiliazione e forza” (5) la morte la fa da protagonista indiscussa.
Ma è morte vista al femminile (come solo le donne sanno cogliere questo momento liminale) non un vivere per la morte, ma un vivere la morte come ricominciamento: ancora una volta, fosse anche l’ultimo gesto dell’uomo, nella fine del mondo (e per ogni individuo la propria morte non può che essere esperita come fine del mondo) sia un tentativo di ricominciare da capo (6).
In questo ennesimo viaggio (ancora uno) attraverso la scrittura, Gibo ci offre “un ingaggio, un imbarco in realtà” verso il tradimento “del proprio regno, traditore del proprio sesso, della propria classe, della propria maggioranza” per poter, come si dicono Claire e Gilles nelle loro intricate Conversazioni (7) divenire minoranza e quindi tradire per poter creare.
Certo poi che possiamo leggere in tutto questo anche quella “domanda mai pacificata [su] come si attraversa la propria storia senza rinnegarla e senza farsi schiacciare dal giudizio storico” (8) ma questa domanda porta in sé la ricerca proprio di una pacificazione, e, inevitabilmente, volge i nostri occhi al passato: a un passato che non passa e ci inibisce al nuovo, a ciò che solo il tradimento del passato permette di creare.
Sempre però tenendo conto del fatto “che tradire è una cosa difficile” perché se deve significare essere capaci di “creare” ciò comporta necessariamente dover “perdere la propria identità, il proprio volto” (9) .
E Gibo, al termine del viaggio in questa sua personale “notte” sparisce per diventare infine a se stesso, come a tutti noi, “sconosciuto”. In una vita non vissuta “alla grande” ma semplicemente vissuta, nel perseguimento del proprio daimon interiore, nel rispetto e nel conflitto con le esigenze, i bisogni, le differenze di tutti gli altri individui che compongono il mondo che abitiamo e che formano le nostre stesse identità rendendoci sconosciuti a noi stessi.
E ancora, alla fine: una nuova acquisita consapevolezza che “la memoria è una prigione che si attraversa e si rompe – di là da questa c’è la possibilità di tutto costruire” (10).
Nota 1: https://milanoinmovimento.com/culture/non-mi-sono-fatto-niente
Nota 4: https://ilmanifesto.it/un-memoir-di-viaggio-e-di-lotta-tra-peripezie-picaresche-e-carcerarie
Nota 5: idem
Nota 6: Ernesto De Martino, La fine del mondo, Einaudi 1977, p. 630
Nota 7: Gilles Deleuze Claire Parnet, Conversazioni, Ombre corte, 2023
Nota 8: https://www.ahidaonline.com/post/selfie-da-zemrudenonmisonofattoniente
Nota 9: G. Deleuze C. Parnet, Conversazioni, op. cit.
Nota 10: Antonio Negri, Lenta ginestra, Mimesis, 2023 p. 19