«Tecnologie del futuro»: vivamente consigliato
Fra scienza e fantascienza: in edicola 13 racconti italiani “ispirati” a 13 interviste a ricercatori e ricercatrici dell’IIT (Istituto Italiano di tecnologia). La recensione di db, a seguire la presentazione e l’introduzione di Marco Passarello.
«Abbiamo un’organizzazione» mormora Attilio. All’inizio Andrea fa finta di non aver sentito ma poi decide di fidarsi perchè (già lo aveva spiegato Spinoza) a volte «la pazzia è più saggia della nostra saggezza». Siamo nelle pagine del racconto «No internet caffè» di Paolo Aresi fra operai, pensionati, tubercolotici, iper-controllo e assicurazioni sanitarie menzognere. Un mondo bellissimo per i ricchi, cioè l’1 per cento.
Ottimo inizio per un’eccellente antologia. Che la fantascienza italiana stia vivendo una fase dorata, qui in “bottega” non fa più notizia però è piacevole registrare conferme e nuovi nomi.
Di solito chi legge segue l’ordine delle pagine e dunque, in questo caso, prima le interviste e poi i racconti. Anche stavolta, come per l’antologia «Fanta-scienza 2», io ho preferito leggere prima ogni racconto e solo dopo vedere se l’intervista era più ricca (o più povera) e se certi fili potenziali non erano stati annodati.
Domanda dal pubblico.
E allora prof db che “voti” dà?
Risposta da privato.
Promuovo tutte/i, con una sola perplessità.
Oltre ogni lode Aresi, Serena Barbacetto, Franci Conforti, Franco Ricciardello, Alessandro Forlani e i due famosi AV, cioè Andrea Viscusi e Alessandro Vietti.
Perplesso mi ha lasciato solo Dario De Marco, il quale scrive benissimo però a me è parso con la testa altrove. A peggiorare il suo non riuscitissimo racconto «Ma gli androidi mangiano pecore elettriche?» una lunga e inutile «Nota critica»: scritta bene pure quella, per carità, ma che c’azzeccava lì non l’ho inteso.
Se, al solito, la spada di Spoiler non minacciasse il mio collo vi direi molto sulle trame dei 13 racconti; e su un trio di personaggi per me indimenticabili. Invece posso solo accenarvi che, fra cascate di scienze e tecnologie, via-via incontreremo anche un vecchio amico-nemico degli umani (il sonno), i disabili con annessi razzismi dei presunti normali, il tradire “a fin di bene”, un Borges piovoso, Jugaad (traduzione hindi dell’arte diarrangiarsi), corvi e «Santa Incendiaria, la principessa che arse vive le tribù slave». C’è qualcuno che si colloca nel «ristretto numero di persone sparse per il mondo che della propria disabilità fanno un mestiere». Ma anche cani tenuti al guinzaglio nell’universo (la costellazione Canes Venatici), ancora versi di Borges, «il problema del pozzo semantico». Problemone è anche ricordare se «C. Blanchett» è una persoma o un acronimo, se Yuri Gagarin suonava jazz; e «Rosae non auleunt» che diavolo di lingua sarà? Per finire citando Haruki Murakami (mooolto amato in “bottega”), i neoluddisti, anatemi e botte. Ma quante luci occorrono per fare battere un cuore solo?
Tranne un paio di casi, scrittori e scrittrici si sono veramente ispirati alle interviste e forse si sono senti anche “in gabbia”: c’era da mettere su romanzi o trilogie.
Ed ecco allora qualche altra citazione ma ripresa dalle interviste e condita con un pizzico di pensieri miei.
Nella prima delle interviste, Arash Ajoudani – responsabile per l’ITT della HRI (Human-Robot Interfaces and Interaction Laboratory) – così risponde a una domanda: «Se immagino il futuro come vorrei … Un’industria in cui non vedi umani che trasportano oggetti pesanti, o che rischiano di perdere le dita utilizzando macchinari pericolosi o che, dopo aver lavorato per 50 o 60 anni accusano forti dolori alla schiena, subiscono un intervento chirurgico e vengono lasciati in ospedale senza riabilitazione». La direzione è ottima, se i decisori politici ed economici non mettono bastoni fra le ruote…
Gli fa eco un altro intervistato, Daniele Pucci che è responsabile all’ITT dell’Artificial Mechanical Intelligence: «Una parte dei nostri tentativi va in questa direzione… si sono derivate protesi di mani per esseri umani, una soluzione per chi ha subìto un’imputazione».
Claudio Semini è responsabile della DynamicLegged System dell’ITT. Spiega che c’è un «progetto finanziato dall’INAIL per la prevenzione di incidenti sul lavoro…». E a proposito di usi militari precisa: «Personalmente in ITT ho sempre evitato di accettare fondi per ricerche di tipo militare».
«Stiamo lavorando con Twin… e con gli esoscheletri in generale pe renderli in grado di scambiare informazoni in modo bidirezionale col soggetto ma anche col medico… Abbiamo una collaborazione con diversi ospedali del Nord e del Centro Italia…» racconta nell’intervista Matteo Lanfranchi, coordinatore del «Laboratorio congiunto Rehab Technologies Inail-Itt».
L’unità di ricerca Syntetic and Systems Biology for Biomedicine è impegnata «per sviluppare un sistema immunitario molto più forte e resistente verso alcune patologie, come i tumori». Lo spiega la responsabile Velia Siciliano,
Angelica Chiodoni è responsabile dell’unità di ricerca Advanced Characterizations and Optimized Functional Materials for Energetic Transition. Senza volerlo dunque si trova al centro anche di uno scontro (molto italiano) sulle «tecnologie di cattura della Co-due». Rispondendo a una domanda sul futuro prossimo delle tecnologie concernenti la transizione energetica spiega che «immaginarsi cosa succederà ra 20 anni è difficile perchè molto dipenderà non solo da quale tecnologia risulterà più efficace ma anche da scelte governative nazionali e globali che determineranno il formarsi di un determinato sistema industriale. Qualcuno prenderà una decisione e tutti gli altri seguiranno». Eh già – aggiungo io – e speriamo che nel frattempo si sviluppino i contropoteri democratici necessari a evitare che decida il solito 1 per cento dell’umanità
Un’altra donna, Arianna Traviglia, dirige il Center for Cultural Heritage Technology e si occupa soprattutto di progetti per i beni culturali, che «spaziano in molti ambiti, dall’intelligenza artificiale alle nanotecnologie e alla robotica».
Se le parole «elettronica commestibile» vi fanno pensare a una battuta, leggete con la necessaria calma l’intervista a Mario Caironi, responsabile di Printed and Molecular Electronic dell’Itt.
Di nuovo i tumori ma ancor più le malattie degenerative (come SLA o Parkinson) nel mirino dell’unità di ricerca RNA Systems Biology. A un certo punto dell’intervista si commuove Gian Gaetano Tartaglia: «da parte mia sono più interessato alla terapeutica: a cosa serve diagnosticare la malattia se poi non c’è ancora la cura».
Anche nelle altre interviste c’è – grazie anche all’incalzare delle domande – molta concretezza. Eppure a volte il confine tra scienza e fantascienza è fragile. Cvd, come volevasi dimostrare.
PS PER VAGABONDE-I DELLE EDICOLE
In vista di qualche giorno di relax con letture, ho preso altri 2 Urania che mi sembravano degni di interesse … e nel caso li recensirò: «Così si perde la guerra del tempo» (Premio Nebula 2020 per il miglior romanzo breve) di Amal El-Mohtar e Max Gladstone ma anche il jumbo «Lassù oltre il cielo» (del 2009), un volumone della prolifica Nancy Kress. Consiglio di tenere d’occhio le edicole anche ad agosto perchè Urania promette «Red Planet Blues» del canadese Robert Sawyer che in “bottega” teniamo in alta considerazione: quando anche una sua trama sembra ovvia bastano poche pagine per ri-scoprire che Sawyer sa cavare oro dalle rape.
PER GENTILE CONCESSIONE DI MARCO PASSARELLO ECCO L’INDICE E LA PRESENTAZIONE DI «TECNOLOGIE DEL FUTURO» E LA SUA INTRODUZIONE AL LIBRO
Cosa succede quando la ricerca scientifica più avanzata incontra l’immaginazione senza confini della narrativa fantascientifica?
È da questa domanda che nasce “Tecnologie del futuro”, la nuova antologia di Urania curata da Marco Passarello, un visionario esperimento letterario.
Ben tredici autori di sci-fi hanno raccolto la sfida: trasformare in narrativa le suggestioni emerse da una serie di interviste a scienziati e ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno dei principali centri europei per la ricerca applicata.
Dalle interviste, incluse nel volume, sono nati tredici racconti originali, firmati da alcune delle migliori penne della fantascienza italiana contemporanea. Un viaggio tra scienza e immaginazione, dove le più promettenti innovazioni del presente diventano i semi narrativi del futuro.
Realtà virtuali ed esoscheletri robotici, intelligenze artificiali, interfacce bio-organiche, bioingegneria, città deambulanti, elettronica commestibile, materiali intelligenti e nanotecnologie mediche: ogni racconto esplora un diverso scenario, proiettando il lettore in sorprendenti mondi futuri.
“Tecnologie del futuro” è più di una semplice raccolta di racconti: è un dialogo tra scienza e fantascienza, tra ciò che stiamo costruendo oggi nei laboratori e ciò che, per ora, esiste solo negli orizzonti dell’immaginario.
Ma lasciamo la parola al curatore, Marco Passarello:
Sono passati ormai quasi undici anni da quando Bruce Sterling, parlandomi di “Hieroglyph”, antologia di racconti di fantascienza ispirati da colloqui con scienziati dell’università dell’Arizona, mi disse che sarebbe stato bello se qualche istituzione scientifica italiana avesse fatto qualcosa di simile. Sul momento non mi resi conto che mi stava piantando un seme nel cervello, che sarebbe sbocciato in “Tecnologie del futuro”, l’Urania che ho curato e che contiene tredici racconti dei migliori autori italiani, ognuno ispirato a una mia intervista con un ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Per arrivare fin qui sono passato attraverso altre due antologie pubblicate da Delos Digital e tantissimo lavoro, immergendomi nelle ricerche più affascinanti dell’IIT: robot umanoidi e quadrupedi, genetica e medicina personalizzata, nuovi materiali ed elettronica commestibile. Una dose gigante di scienza e fantascienza che sono felice di poter condividere coi lettori di Urania.
Ed ecco la lista dei racconti:
- NO INTERNET CAFFÈ
di Paolo Aresi
Ispirato dall’intervista ad Arash Ajoudani - L’ABITO NON FA IL MONACO
di Marco Passarello
Ispirato dall’intervista a Daniele Pucci - WANDERCITY
di Lukha B. Kremo
Ispirato dall’intervista a Claudio Semini - TURNO DI NOTTE
di Serena M. Barbacetto
Ispirato dall’intervista a Matteo Laffranchi - IL MARE AL DI LÀ DEL CIELO
di Fabio Aloisio
Ispirato dall’intervista a Velia Siciliano - STRALCI
di Franci Conforti
Ispirato dall’intervista a Gianni Ciofani - CADE NEL PASSATO LA PIOGGIA
di Franco Ricciardiello
Ispirato dall’intervista ad Angelica Chiodoni - IMPRONTE
di Irene Drago
Ispirato dall’intervista ad Arianna Traviglia - SINCRO
di Salvatore Sanfilippo
Ispirato dall’intervista ad Annamaria Petrozza - MA GLI ANDROIDI MANGIANO PECORE ELETTRICHE?
di Dario De Marco
Ispirato dall’intervista a Mario Caironi - ROSAE NON AULEUNT
di Alessandro Forlani
Ispirato dall’intervista a Gian Gaetano Tartaglia - ORIGAMI
di Andrea Viscusi
Ispirato dall’intervista a Irene Farabella - L’AMORE AL TEMPO DEI FOTOIDI
di Alessandro Vietti
Ispirato dall’intervista a Guglielmo Lanzani
E all’interno, Franco Brambilla – 25 anni con Urania, intervista al celebre illustratore a cura degli amici di Uraniamania, per celebrare la collaborazione tra Urania e il celebre illustratore.
INTRODUZIONE di Marco Passarello
Quella che avete tra le mani è un’antologia molto particolare, in cui scienza e fantascienza si incontrano. Contiene infatti tredici interviste con altrettanti ricercatori affiliati all’Istituto Italiano di Tecnologia, su temi che vanno dalla robotica alla genetica alla scienza dei materiali; e ogni intervista è seguita da un racconto in cui un autore di fantascienza ha tentato di trasformare in una storia le visioni presentate dagli scienziati.
Questo progetto arriva da molto lontano: comincia a nascere nel 2014, quando viene pubblicata Hieroglyph, un’antologia di fantascienza (tuttora inedita in Italia) curata da Neal Stephenson, in cui molti dei principali autori statunitensi si erano lasciati ispirare dalle idee degli scienziati dell’università dell’Arizona. In proposito mi capitò di intervistare Bruce Sterling, il celebre autore texano fondatore del genere cyberpunk, che mi disse: «Spero che altre istituzioni vedano la saggezza di questo sforzo e lo seguano. Se ci provasse un’università italiana, sarei il primo a festeggiare».
Sul momento l’auspicio di Bruce mi parve nel novero delle cose irrealizzabili. Si sa che la fantascienza non gode di buona reputazione nell’ambito delle istituzioni accademiche italiane. Chi mai avrebbe potuto dare ascolto a una simile idea? La risposta arrivò inattesa poco tempo dopo, quando intervistai Roberto Cingolani, che aveva fondato e allora dirigeva l’Istituto Italiano di Tecnologia. Fu lui a portare il discorso sulla fantascienza; lo scoprii appassionato di autori non banali come Iain M. Banks, e nel mio cervello cominciò a germogliare l’idea che lui avrebbe potuto essere interessa to a coinvolgere il suo istituto in un progetto simile a Hieroglyph. Presi il coraggio a due mani e gli feci la proposta; e lui rispose che mi avrebbe volentieri messo in contatto con ricercatori disposti a lasciarsi intervistare e fornire spunti agli scrittori.
Da lì partì un vortice di attività durato un decennio, e che prima di questo libro ne ha prodotti altri due, ambedue pubblicati da Delos Digital: Fanta-Scienza, uscito nel 2019, e Fanta-Scienza 2, uscito nel 2022, al quale mi fece l’onore di partecipare lo stesso Bruce Sterling. (*)
A questo punto tendevo a ritenere l’esperienza conclusa: a mio avviso non aveva senso continuare a fare la stessa cosa per gli stessi lettori, mentre in più occasioni avevo sperimentato il completo disinteresse della grande editoria italiana verso il progetto, e quindi l’impossibilità di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.
O almeno così credevo. Perché invece, quando provai a sondare Franco Forte sulla possibilità di trovare una sistemazione in Mondadori per un allora del tutto ipotetico terzo volume, lui non solo mi disse che c’era, ma mi propose immediatamente l’uscita come «Urania Speciale» 2025. Poco più di un anno e mezzo dopo, il volume si è realizzato e ora lo tenete in mano (o forse sullo schermo del lettore di ebook).
In queste pagine, cartacee o digitali che siano, troverete due cose. In primo luogo tredici interviste che permettono di guardare da vicino le affascinanti ricerche che si svolgono nei laboratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia; alcune su classici temi fantascientifici, come la robotica, altre su argomenti apparentemente (ma solo apparentemente!) meno futuribili, come la protezione dei beni culturali. Spero, nel realizzare e trascrivere queste interviste, di essere riuscito a trasmettervi la mia meraviglia nel vedere come in Italia, e non in qualche lontano laboratorio oltreoceano, si svolgano ricerche mirate a far diventare realtà quelli che fino a ieri sarebbero sembrati frutti di un’immaginazione troppo sbrigliata.
In secondo luogo, troverete tredici racconti ispirati alle interviste. Sono a mio avviso ottimi racconti, e lo sono ancor di più se si tiene presente quanto possa essere difficile per un autore scrivere un racconto a partire da uno spunto predeterminato. E infatti non sono stati pochi gli scrittori e le scrittrici che, di fronte alla mia richiesta di partecipare, hanno deciso di declinare l’invito. Per questo motivo a coloro che hanno invece accettato di partecipare ho deciso di concedere ampia libertà di movimento, senza richiedere un’aderenza letterale al contenuto dell’intervista, ma lasciandoli spaziare con la fantasia, ponendo come unica regola che qualcuno dei temi o delle idee proposti dai ricercatori fosse ben riconoscibile all’interno del racconto.
Per Tecnologie del futuro credo di aver selezionato una rosa di ottimi autori e autrici molto rappresentativi di ciò che è oggi la fantascienza italiana. Ci sono alcuni dei nomi più conosciuti del genere, tra cui diversi vincitori del premio Urania; ma anche autori emergenti e completi outsider. Sono convinto che i racconti che hanno prodotto, anche considerandoli al di fuori del contesto di questo progetto, siano di una qualità complessiva eccellente e testimonino l’alto livello che la fantascienza italiana ha raggiunto in questi ultimi anni.
Il libro esce dopo un periodo di aspre polemiche relative ai rapporti tra «Urania» e la fantascienza italiana. Si era anche diffusa la falsa impressione che non ci sarebbero più state antologie di autori italiani sulle pagine della testata. Sono felicissimo di poter dimostrare coi fatti che le cose non stanno così. Spero di aver realizzato un degno seguito delle antologie curate annualmente da Franco Forte, e che Tecnologie del futuro possa essere un valido contributo per far arrivare la migliore fantascienza italiana a un pubblico il più ampio possibile.
Questa antologia mi permette anche di fornire un esempio di cosa significa per me “fantascienza”. Si sa che si tratta di un genere letterario dai confini incerti, per cui è quasi impossibile trovare una definizione che metta d’accordo tra loro due appassionati. Ma, per quanto mi riguarda, ciò che distingue la fantascienza dal resto della letteratura fantastica è l’avere sempre come punto di partenza uno spunto scientifico o speculativo che consenta di interrogarsi sul presente e sul futuro.
Viviamo purtroppo in un frangente storico in cui si è diffuso un sentimento di sfiducia e sospetto nei confronti della scienza e dei suoi risultati, che ritengo sia dovuto anche al fatto che le persone non hanno occa-sione di conoscere e capire veramente cosa sia e come funzioni la ricerca scientifica. Credo che queste pagine forniscano l’opportunità di apprezzare l’impegno di chi ha dedicato la sua vita all’aspirazione di migliorare il mondo attraverso la ricerca.
Per me vedere approdare questo progetto sulle pagine di «Urania» rappresenta il sogno di una vita che si realizza. Voglio quindi ringraziare tutti coloro che mi
hanno aiutato in questa impresa. In particolare Roberto Cingolani, che fu il primo a credere nella mia idea; il suo successore Giorgio Metta, che mi ha dato la possibilità di proseguire; il compianto Giuseppe Lippi, che mi diede un forte incoraggiamento quando il progetto era ancora nella fase embrionale; Silvio Sosio, che ha pubblicato i primi due volumi e senza il quale il progetto non sarebbe mai nato; Bruce Sterling, che si è speso in mille modi per sostenerci e farci arrivare a un pubblico più ampio; Giuliano Greco, Camilla Dalla Bona e Gioele Lecquio, che dall’interno dell’IIT mi hanno fornito ogni sorta di assistenza; e soprattutto tutti i ricercatori e tutti gli autori che hanno scelto di partecipare, molti dei quali quando ancora neppure si sapeva se avremmo mai trovato un editore; e infine mia moglie Silvia Castoldi, il cui contributo all’editing dei racconti è stato fondamentale. A tutti loro esprimo la mia più profonda gratitudine.
E ora uno sguardo ai tredici autori che hanno parte cipato all’antologia.
Giornalista, autore di fantascienza di lunghissimo corso, appassionato di bicicletta e grande esperto di esplorazioni spaziali, PAOLO ARESI ha alle spalle diversi romanzi, fantascientifici e non, tra cui la trilogia dedicata al pioniere dell’astronautica Korolev e una vittoria al premio Urania nel 2004 con Oltre il pianeta del vento, vincitore del premio Urania nel 2004. A lui è toccato prendere ispirazione da ARASH AJOUDANI, le cui ricerche si occupano dell’interazione tra robot ed esseri umani nell’ambiente di lavoro. Nel racconto No Internet Caffè Paolo abbandona gli scenari spaziali che gli sono abituali e scende sul nostro pianeta, dove il suo stile che riecheggia i grandi autori della fantascienza classica assume toni di vibrante critica sociale.
Il secondo racconto spetta al sottoscritto, MARCO PASSARELLO. Sono ingegnere aeronautico di formazione e giornalista radiotelevisivo di professione. Ho pubblicato il mio primo racconto di fantascienza nel lontanissimo 1983 sulla rivista Futura, e da allora non ho mai smesso di frequentare il genere come autore, traduttore, curatore. Il mio racconto si intitola L’abito non fa il monaco e si ispira alle ricerche sulla robotica di DANIELE PUCCI. La sua intervista è quanto di più fantascientifico si possa immaginare, sta lavorando persino a un robot volante! Intorno ai suoi numerosi spunti ho costruito una trama gialla che ha inglobato anche un’altra delle mie passioni, la musica.
Chiunque frequenti la fantascienza italiana non può non conoscere LUKHA B. KREMO, editore di fantascienza con Kipple Officina Libraria e autore vincitore di svariati premi, tra cui nel 2015 il premio Urania con il romanzo Pulphagus®. Gli ho affidato il compito di ispirarsi alle ricerche di CLAUDIO SEMINI sulla deambulazione dei robot, e lui ha usato la sua immaginazione in grande, visto che nel racconto Wandercity fa camminare su zampe meccaniche addirittura case e città.
Mentre cercavo autori e autrici che potessero traslare in un racconto le ricerche scientifiche dell’IIT ho pensato subito a SERENA M. BARBACETTO, che ha un vero e proprio feeling con la tecnologia e che firma storie in piena sintonia con un ethos cyberpunk. Nel racconto Turno di notte sfrutta le ricerche di MATTEO LAFFRANCHI sull’uso di esoscheletri come tecnologie riabilitative per descrivere l’io frammentato di chi vive immerso in un mondo tecnologico.
Si dice che gli ingegneri siano persone con i piedi per terra, ma la formazione ingegneristica non impedisce a FABIO ALOISIO di spaziare con l’immaginazione verso mondi molto lontani dal nostro. Nel racconto Il mare al di là del cielo prende ispirazioni dalle ricerche di VELIA SICILIANO su un altro tipo di ingegneria, quella biologica che progetta nuovi esseri viventi, e narra come anche attraverso le più bizzarre trasformazioni l’essere umano e le sue motivazioni riescano a sopravvivere e a trionfare.
FRANCI CONFORTI ci ha raccontato di essersi affacciata tardi al mondo dell’ editoria fantascientifica, e di aver deciso di provare a farsi pubblicare solo dietro l’insistenza del figlio. Il quale non aveva torto, visto che Conforti è riuscita in pochi anni a vincere tutti i premi più importanti, tra cui il premio Urania nel 2022 con il romanzo Spine. Quello delle biotecnologie è un tema portante dell’immaginario di Franci, che quindi si è trovata perfettamente a suo agio nel rapportarsi alle ricerche di GIANNI CIOFANI sul tema della nanomedicina. Il suo racconto Stralci mi ha trasmesso un’atmosfera quasi asimoviana, con le sue diatribe tra pomposi accademici succubi di intelligenze artificiali.
FRANCO RICCIARDIELLO è un altro autore di lungo corso. La sua vittoria al premio Urania risale al 1998 con il romanzo Ai margini del caos, ma da allora non ha mai smesso di scrivere e di aprirsi a nuove tematiche, come di recente quella solarpunk. Per questo mi è parso l’autore ideale per affrontare l’intervista di ANGELICA CHIODONI, ricercatrice nell’ambito dei materiali per la transizione energetica. Nel suo racconto Cade nel passato la pioggia descrive un’Italia in balia di eventi climatici estremi; un mondo futuro che purtroppo rischia di diventare presente, se la transizione energetica non sarà rapida.
La persona che si cela dietro allo pseudonimo di IRENE DRAGO esercita la professione medica, e pertanto ha rappresentato la mia prima scelta per ricavare un racconto da ricerche su genetica e biologia. Però in questa occasione mi ha stoppato: «Questa volta no, dammi qualcosa che non abbia niente a che vedere con mitocondri e cromosomi». L’ho accontentata affidandole l’intervista ad ARIANNA TRAVIGLIA, che si occupa di tecnologia per la tutela dei beni culturali. Né è venuto fuori Impronte, un racconto allucinato ai confini tra la fantascienza e il gotico, in cui la tecnologia è la chiave per risvegliare i fantasmi di una villa antica.
Ci tenevo a includere in questa antologia qualche nome che fosse assolutamente nuovo ai lettori di Urania, e ho optato per SALVATORE SANFILIPPO, di professione programmatore. A motivare la mia scelta c’è il suo primo romanzo pubblicato, Wohpe, in cui riesce a descrivere in modo convincente l’ambiente della ricerca. Cosa che fa anche in Sincro, ispirato all’intervista ad ANNAMARIA PETROZZA sui materiali avanzati per l’optoelettronica, sulla quale Sanfilippo costruisce un mistero fantascientifico di notevole suspence.
L’altro outsider di questa antologia è DARIO DE MARCO, eclettico giornalista, in grado di scrivere tanto libri quanto di cibo (leggetevi il suo delizioso Alla ricerca della pizza perfetta). Come autore frequenta il fantastico con una predilezione per le strutture insolite, come quella del suo Storie che si biforcano. Qui non si è smentito, e nel suo Ma gli androidi mangiano pecore elettriche? (ecco che torna il cibo!) ha tradotto le ricerche di MARIO CAIRONI sull’elettronica stampata e commestibile in una storia che continua a cambiare forma e che ingloba pezzi della stessa intervista.
Se c’è un autore difficile da classificare è ALESSANDRO FORLANI. Anche lui è vincitore del premio Urania (nel 2012 con I senza-tempo), ma i confini del genere gli stanno stretti. Anche lo stile che adotta è personalissimo, una prosa italiana che non di rado sconfina nella poesia snocciolando perfetti ottonari ed endecasillabi. Io dico che, se fossimo un Paese meno parruccone e snob, qualcuno si sarebbe accorto che il suo ultimo romanzo, Non tutti certo moriremo, va letto non solo perché è una buona storia di fantascienza, ma perché dà una descrizione lucidissima e amara della condizione presente dell’Italia. Prendendo spunto dalle ricerche di GIAN GAETANO TARTAGLIA, che studia l’RNA per trovare il modo di guarire le malattie degenerative, ha scritto il racconto Rosae non auleunt incentrato sui labirinti della memoria.
Autore di uno dei pochi “long seller” della fantascienza italiana, il romanzo Dimenticami trovami sognami, ANDREA VISCUSI è ben conosciuto dagli appassionati anche per la sua capillare presenza ovunque ci sia da discutere di fantascienza, dai social media alle fanzine. Ma questo non lo trattiene da una cospicua produzione letteraria. Il suo racconto Origami prende il titolo da una metafora della ricercatrice IRENE FARABELLA, secondo la quale il nostro genoma è come una scultura di carta che può prendere molte forme a seconda di come la si piega. Se ne accorgeranno le due protagoniste, incaricate di ricreare l’umanità a partire da una banca genetica, trovandosi di fronte a una soluzione alternativa per il futuro della specie.
Con cinque romanzi alle spalle, tutti molto diversi tra loro, ALESSANDRO VIETTI è una delle certezze della fantascienza nostrana. A lui è toccato in sorte di tradurre in racconto le ricerche di GUGLIELMO LANZANI, che si occupa di nanomateriali per le scienze della vita, e si propone di creare interfacce tra il vivente e il non-vivente. Il racconto che ne è risultato, L’amore al tempo dei fotoidi, scritto secondo una molteplicità di punti di vista, mette in scena una delle nostre paure più profonde: quella di perdere la nostra identità e diventare qualcos’altro.
(*) Di questo secondo volume trovate qui una recensione (del 2022) di db: «Fanta-scienza 2»: un’antologia da lode. In “bottega” si è parlato altre volte di Marco Passarello e il consiglio è muoversi con il TAG giusto. C’è poi Passarello in veste di “intervistatore” a chiudere un ciclo di Vincent Spasaro: cfr Narrator in Fabula – 35 (*) … però siamo nel 2016.




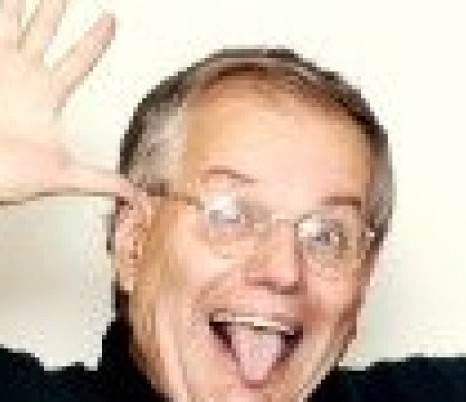
Grazie per la bella recensione, Daniele!
M’incuriosiscono i “tre personaggi indimenticabili”…
Serena